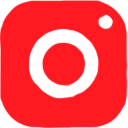STORIA E TRADIZIONI
"N'arrubaru 'a lingua": la (vera) storia della Scuola Siciliana, un equivoco lungo secoli
Se tutti noi siciliani fossimo a conoscenza della vera lingua usata alla scuola siciliana di Federico II, rivaluteremmo l’importanza della nostra lingua siciliana

Miniatura di Federico II e della sua corte
Per secoli gli eruditi siciliani hanno rivendicato la paternità sulla lingua italiana. E, perlomeno fino al 1790, i siciliani avevano apparentemente tutte le ragioni di questo mondo per poter affermare che la lingua italiana fu forgiata alla corte di Federico II e che questo "primato" ci fu scippato.
Ecco cosa scriveva il nobile e colto siciliano del XVII secolo (quindi, prima del 1790) Giovanni Ventimiglia.
«Però voglio che voi sappiate non essere mio pensiero di entrare in odiosa disputa co' Fiorentini se quella lingua nella quale scrisse il Petrarca, e gli altri, fosse stata allora in Firenze; ma solo asserisco che, quando vi sia stata, non era diversa dalla nostra siciliana.
E così intenderete quel membro della mia proposizione che dice il Petrarca avere scritto in siciliano o in idioma dal siciliano non differente. Sicché, se non vogliamo dire che il Petrarca scrisse in altra lingua che nella fiorentina, bisogna anche confessare che questa non differiva dalla siciliana».
D'altronde, se leggiamo i componimenti della scuola poetica siciliana, sorta alla corte di Federico II intorno al 1230, giunti sino a noi attraverso alcune raccolte di fogli manoscritti tardo-duecenteschi, opera di copisti toscani, tra le quali la più importante è il codice Vaticano-Latino 3793, ci rendiamo conto dell'enorme somiglianza tra la lingua di tali componimenti e la lingua usata da Dante Alighieri nella "Commedia".
Da "S’eo trovasse pietanza", di Re Enzo, figlio di Federico II, anch’egli poeta della scuola siciliana
Tutti quei pensamenti
che 'l spirto meo divisa,
sono pene e dolore
senz'allegrar che non li s'accompagna
Poi, nel 1790, succede una cosa che cambia "tutto".
Fino ad allora si era sempre creduto che il Vaticano-Latino 3793 e gli altri codici riportassero i componimenti della scuola poetica siciliana nella loro forma originale, cioè così come furono composti e scritti dagli autori.
Ma, appunto, nel 1790 lo storico della letteratura italiana Girolamo Tiraboschi rinvenne in una biblioteca un libro manoscritto e inedito del XVI secolo del filologo modenese Giovanni Maria Barbieri (“L'arte del rimare”).
In questo libro il Barbieri trascrive una poesia intera ("Pir meu cori alligrari") e alcuni frammenti di altre poesie della scuola poetica siciliana – tra le quali anche le ultime due strofe di “S’eo trovasse pietanza” - che dice di aver tratto da un "Libro Siciliano", di cui oggi non si ha più traccia.
La cosa sorprendente è che tali poesie sono scritte in una lingua ben diversa da quella che si legge nei componimenti del Vaticano-Latino 3793.
Questa lingua è molto più simile alla lingua siciliana odierna di quanto non lo fosse la lingua usata nel Vaticano-Latino 3793 e negli altri codici, come si può evincere dallo stesso passaggio del "S’eo trovasse pietanza" riportato prima nella forma in cui appare nei codici toscani e qui a seguire come appare nel libro del Barbieri
Tutti li pinsamenti
chi 'l spirtu meu divisa
sunu pen’e duluri sinz’alligrar,
chi nu lli s’accompagna
E fu così che il Tiraboschi diede alle stampe il libro inedito del Barbieri con il titolo "Dell'origine della poesia rimata", lanciando l'ipotesi che nel Vaticano-Latino 3793 e negli altri due codici toscani le poesie siciliane avessero subito una sorta di traduzione per assumere una forma toscaneggiante e che gli originali fossero stati scritti, invece, nella lingua che lui leggeva nei componimenti riportati nel libro del Barbieri.
All'inizio ci furono resistenze nel credere a ciò. Certamente non doveva essere facile ricredersi su un assunto dato per consolidato e scontato nel corso di molti secoli.
Qualcuno avanzò l'ipotesi che le poesie della scuola siciliana presenti nel libro del Barbieri non fossero altro che delle traduzioni a posteriori in siciliano degli originali. Ci fu persino chi disse che il Barbieri si fosse inventato tutto.
Ma ben presto un'altra scoperta chiarì definitivamente la situazione: la famosa "rima siciliana" (cioè il rimare imperfetto del tipo volere/gioire), una caratteristica della scuola siciliana che si era pensato fosse dovuto a una sorta di "sciccheria" e che fu imitata anche da Dante e altri poeti dato il prestigio che aveva tale scuola, in realtà era un prodotto della traduzione in toscano dei componimenti originali siciliani.
Infatti, traducendo - meglio sarebbe dire "riportando" - al siciliano i testi dei codici toscani, tutte le rime tornavano a combaciare (vuliri/giuiri), divenendo "perfette".
Ebbene, nonostante siano passati più di due secoli, a gran parte dei siciliani queste informazioni non sono arrivate (alcuni pensano ancora che la lingua italiana sia nata in Sicilia).
Se tutti noi siciliani fossimo a conoscenza della vera lingua usata alla scuola siciliana di Federico II, anziché rivendicare ancora oggi la paternità sulla lingua italiana, dovremmo rivalutare l’importanza e il prestigio della nostra lingua siciliana.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





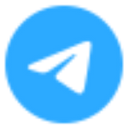


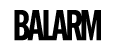

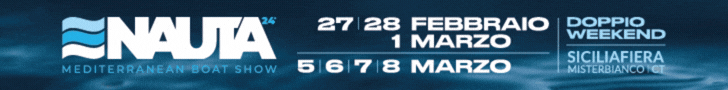



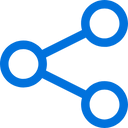
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram