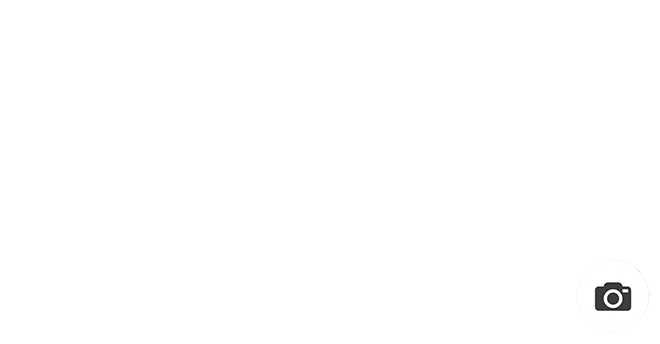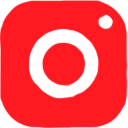STORIA E TRADIZIONI
Quando in Sicilia vivevano i leoni delle caverne: il ritrovamento nella grotta dell'Addaura
Una scoperta, quella fatta sul monte di Palermo, definita "enigmatica" dal grande studioso di archeologia preistorica Giovanni Mannino e che vi raccontiamo grazie a una sua pubblicazione del 1961
Il leone delle caverne fu uno degli ultimi predatori di megafauna (gli animali di grandi dimensioni) e, contrariamente a quanto si può pensare, il nome attribuitogli non è legato al fatto che vivesse nelle caverne, ma al luogo in cui sono stati ritrovati i fossili nel corso del tempo.
Sembra che in Europa vissero due leoni preistorici, il leone delle caverne europeo del Pleistocene inferiore e medio, Panthera leo fossilis, e il leone delle caverne europeo del Pleistocene superiore, (Panthera leo spelaea) vissuto da 370.000 a 10.000 anni fa.
In tempi storici visse anche nella penisola iberica, in Francia meridionale, in Italia e nei Balcani. Poco si sa su questo animale a causa della sua estinzione avvenuta in tempi assai remoti ma di certo rappresenta una "icona" dei predatori dell'"Era Glaciale” europea. Questo grazie ai numerosi ritrovamenti fossili in varie parti del mondo tra cui... la Sicilia, più precisamente a Palermo.
E quella che vi riportiamo è proprio la scoperta dei resti di un leone delle caverne avvenuta negli anni '60, nella Grotta Addaura Crapara "scavata dal mare, nelle strapiombanti pareti settentrionali di Monte Pellegrino a circa una dozzina di chilometri da Palermo, un luogo che, costituisce uno dei fenomeno carsici più interessanti d’Italia e che prima che dei vandali ne iniziassero il sistematico saccheggio fu sede di spettacolari fenomeni concrezionari, che possiamo definire unici al mondo".
Era alla distanza di 700 metri dall’ingresso. Tra cunicoli e budelli, in qualche modo, quel grosso felino riuscì a passare. A trovare i resti fu un gruppo di speleologi della Sezione del CAI di Palermo: Lucia Pagano, Tibor Kirner e Pippo Morina.
Una scoperta definita "enigmatica" dal grande studioso di archeologia preistorica Giovanni Mannino che, ancor prima da speleologo, amava già da ragazzo esplorare grotte inaccessibili e cavità profonde crenado grazie alle sue "spedizioni" anche il Catasto delle Grotte della Sicilia.
"Enigmatica" dicevamo, così Mannino scrisse quando raccontò e documentò la scoperta sulla rivista La Spelologia nel 1961. L’aggettivo è più che azzeccato proprio per le condizioni in cui si sviluppava la grotta e che riportiamo sperando che susciti in voi le stesse sensazioni che ho provato io leggendo: "miriade di cunicoli, budelli divisi da strozzature e piccole sale. Un labirinto scavato da un fiume sotterraneo che già allora non esisteva più e nel quale si distinguevano un ramo principale dal quale si dipartono centinaia di piccoli cunicoli alcuni dei queli, per il fatto che da essi dipartono a loro volta altri cunicoli e budelli, costituiscono dei rami secondari".
L’accesso al ramo principale era decisamente faticoso e impossibile per le persone corpulente. Per un uomo di statura normale, del peso di un centinaio di chili, era impossibile percorrere l’intero ramo, "anche se capace di qualsiasi contorsionismo – si legge -. Pure riuscendo a fare qualche metro in più sarebbe costretto affermarsi al 246 metri dall’ingresso".
Per raggiungere il "laghetto" che segnava il termine del ramo principale, bisognava come detto, fare delle contorsioni e spesso percorrere a ventre a terra, facendo spaccate, trattenendo il respiro. Tutto questo almeno per un’ora.
La relazione dello speleologo va avanti formulando passo passo delle ipotesi, come quella di una penetrazione per via verticale o semiverticale, non più esistente ma che decine di millenni prima era decisamente possibile che esistesse. Mannino fece notare infatti che sulla sommità del monte (a quota 370 metri), si trovava la dolina denominata "gorgo rosso", chiusa già a quel tempo ma nella quale una volta si riversavano, come mostrato dalle levigature nelle rocce in prossimità del centro della dolina, le acque dei piccoli rilievi, che probabilmente crearono attraverso un lento lavoro di erosione e corrosione, la grotta in questione.
La distanza tra il gorgo e il punto del ritrovamento era di circa 700 metri con un dislivello di 250 metri.
La diramazione alla fine della quale si trovava l'abitacolo, lunga circa 70 metri, era strettissima e bassa tanto da doverla percorrere in parte distesi per terra. Abitacolo che era in una fessura lunga poco più di due metri e alta 1 metro e 20 e con una larghezza variabile per la base dai 30 ai 30 cm.
Proprio per questo le possibilità di ingresso nella fessura erano limitatissime. Non tutti i componenti del gruppo infatti riuscirono a vedere l’interno delle fessura in cui si trovava l’animale. Solo due di loro perché più minuti, scalzi, uno per volta, erano riusciti a penetrare. Gli altri poterono solo per due terzi, infatti la lunghezza delle tibie aveva reso impossibile muoversi oltre ma erano riusciti comunque a guardare all'interno. A tutto questo si aggiungeva la sensibile rarefazione dell'aria.
Dunque il mistero del leone diventò sempre più fitto. Come poteva essere entrato l’animale nell’abitacolo in cui era stato trovato? Un luogo chiuso da ogni altra parte. In quella fessura, il pavimento era orizzontale nel primo tratto per concludere in una buca di un'altezza di un un metro e 50 in prossimità della quale furono trovati alcuni resti: vertebre sacrali, coccige, un femore. Il cranio fu rinvenuto completamente intatto.
Gli speleologi studiarono in lungo e in largo la grotta, ogni percorso, lunghezza, altezza, dislivelli, pensando anche a possibili errori di rilevamento o di un cattivo orientamento della poligonale. Pensando anche a un posizionamento dei resti dell’animale causato dal trasporto per via acqua.
Fecero accuratissimi controlli, verifiche e riscontri, arrivando alla conclusione che no, non avevano commesso alcun errore: l’enigma del rinvenimento dei resti in quel determinato punto probabilmente non sarebbe mai stato svelato.
Per loro era "inverosimile" che l’animale per raggiungere il luogo in cui poi morì avesse potuto percorrere il ramo principale, vivo o morto, o qualunque altra ipotetica galleria. Oltretutto la pendenza era positiva (in salita) quindi che fosse morto prima risultava impossibile.
Dunque, scrive Mannino o l’animale era morto lì dentro, ma non si sa come vi fosse arrivato, o vi sarebbe stato trasportato morto, ma con tutti i tessuti muscolari integri (impoedendo questo la dispoersione ela levigazione delle ossa) e che permise il seguente ritrovamento dei resti in una posizione “relativamente composta”.
L’unica ipotesi - scartata alla fine quella dell’animale in vita - era che, da morto, fosse stato trasportato, intatto, spinto da forti correnti d’acqua. Secondo gli speleologi quest’acqua probabilmente trovava una via d’uscita nella buca di un metro e mezzo di altezza di cui dicevamo. Ma per questo sarebbero stati necessari altri studi.
A noi posteri rimane l'aver appreso di questa bella avventura che ci riporta indietro di oltre 50 anni ma anche di decine di millenni, ad un'era in cui su Monte Pellegrino vivevano i leoni. E dunque questo articolo vuole essere anche un ringraziamento al grande Giovanni Mannino, scomparso a 92 anni, nell'ottobre del 2021.
Sembra che in Europa vissero due leoni preistorici, il leone delle caverne europeo del Pleistocene inferiore e medio, Panthera leo fossilis, e il leone delle caverne europeo del Pleistocene superiore, (Panthera leo spelaea) vissuto da 370.000 a 10.000 anni fa.
In tempi storici visse anche nella penisola iberica, in Francia meridionale, in Italia e nei Balcani. Poco si sa su questo animale a causa della sua estinzione avvenuta in tempi assai remoti ma di certo rappresenta una "icona" dei predatori dell'"Era Glaciale” europea. Questo grazie ai numerosi ritrovamenti fossili in varie parti del mondo tra cui... la Sicilia, più precisamente a Palermo.
E quella che vi riportiamo è proprio la scoperta dei resti di un leone delle caverne avvenuta negli anni '60, nella Grotta Addaura Crapara "scavata dal mare, nelle strapiombanti pareti settentrionali di Monte Pellegrino a circa una dozzina di chilometri da Palermo, un luogo che, costituisce uno dei fenomeno carsici più interessanti d’Italia e che prima che dei vandali ne iniziassero il sistematico saccheggio fu sede di spettacolari fenomeni concrezionari, che possiamo definire unici al mondo".
Era alla distanza di 700 metri dall’ingresso. Tra cunicoli e budelli, in qualche modo, quel grosso felino riuscì a passare. A trovare i resti fu un gruppo di speleologi della Sezione del CAI di Palermo: Lucia Pagano, Tibor Kirner e Pippo Morina.
Una scoperta definita "enigmatica" dal grande studioso di archeologia preistorica Giovanni Mannino che, ancor prima da speleologo, amava già da ragazzo esplorare grotte inaccessibili e cavità profonde crenado grazie alle sue "spedizioni" anche il Catasto delle Grotte della Sicilia.
"Enigmatica" dicevamo, così Mannino scrisse quando raccontò e documentò la scoperta sulla rivista La Spelologia nel 1961. L’aggettivo è più che azzeccato proprio per le condizioni in cui si sviluppava la grotta e che riportiamo sperando che susciti in voi le stesse sensazioni che ho provato io leggendo: "miriade di cunicoli, budelli divisi da strozzature e piccole sale. Un labirinto scavato da un fiume sotterraneo che già allora non esisteva più e nel quale si distinguevano un ramo principale dal quale si dipartono centinaia di piccoli cunicoli alcuni dei queli, per il fatto che da essi dipartono a loro volta altri cunicoli e budelli, costituiscono dei rami secondari".
L’accesso al ramo principale era decisamente faticoso e impossibile per le persone corpulente. Per un uomo di statura normale, del peso di un centinaio di chili, era impossibile percorrere l’intero ramo, "anche se capace di qualsiasi contorsionismo – si legge -. Pure riuscendo a fare qualche metro in più sarebbe costretto affermarsi al 246 metri dall’ingresso".
Per raggiungere il "laghetto" che segnava il termine del ramo principale, bisognava come detto, fare delle contorsioni e spesso percorrere a ventre a terra, facendo spaccate, trattenendo il respiro. Tutto questo almeno per un’ora.
La relazione dello speleologo va avanti formulando passo passo delle ipotesi, come quella di una penetrazione per via verticale o semiverticale, non più esistente ma che decine di millenni prima era decisamente possibile che esistesse. Mannino fece notare infatti che sulla sommità del monte (a quota 370 metri), si trovava la dolina denominata "gorgo rosso", chiusa già a quel tempo ma nella quale una volta si riversavano, come mostrato dalle levigature nelle rocce in prossimità del centro della dolina, le acque dei piccoli rilievi, che probabilmente crearono attraverso un lento lavoro di erosione e corrosione, la grotta in questione.
La distanza tra il gorgo e il punto del ritrovamento era di circa 700 metri con un dislivello di 250 metri.
La diramazione alla fine della quale si trovava l'abitacolo, lunga circa 70 metri, era strettissima e bassa tanto da doverla percorrere in parte distesi per terra. Abitacolo che era in una fessura lunga poco più di due metri e alta 1 metro e 20 e con una larghezza variabile per la base dai 30 ai 30 cm.
Proprio per questo le possibilità di ingresso nella fessura erano limitatissime. Non tutti i componenti del gruppo infatti riuscirono a vedere l’interno delle fessura in cui si trovava l’animale. Solo due di loro perché più minuti, scalzi, uno per volta, erano riusciti a penetrare. Gli altri poterono solo per due terzi, infatti la lunghezza delle tibie aveva reso impossibile muoversi oltre ma erano riusciti comunque a guardare all'interno. A tutto questo si aggiungeva la sensibile rarefazione dell'aria.
Dunque il mistero del leone diventò sempre più fitto. Come poteva essere entrato l’animale nell’abitacolo in cui era stato trovato? Un luogo chiuso da ogni altra parte. In quella fessura, il pavimento era orizzontale nel primo tratto per concludere in una buca di un'altezza di un un metro e 50 in prossimità della quale furono trovati alcuni resti: vertebre sacrali, coccige, un femore. Il cranio fu rinvenuto completamente intatto.
Gli speleologi studiarono in lungo e in largo la grotta, ogni percorso, lunghezza, altezza, dislivelli, pensando anche a possibili errori di rilevamento o di un cattivo orientamento della poligonale. Pensando anche a un posizionamento dei resti dell’animale causato dal trasporto per via acqua.
Fecero accuratissimi controlli, verifiche e riscontri, arrivando alla conclusione che no, non avevano commesso alcun errore: l’enigma del rinvenimento dei resti in quel determinato punto probabilmente non sarebbe mai stato svelato.
Per loro era "inverosimile" che l’animale per raggiungere il luogo in cui poi morì avesse potuto percorrere il ramo principale, vivo o morto, o qualunque altra ipotetica galleria. Oltretutto la pendenza era positiva (in salita) quindi che fosse morto prima risultava impossibile.
Dunque, scrive Mannino o l’animale era morto lì dentro, ma non si sa come vi fosse arrivato, o vi sarebbe stato trasportato morto, ma con tutti i tessuti muscolari integri (impoedendo questo la dispoersione ela levigazione delle ossa) e che permise il seguente ritrovamento dei resti in una posizione “relativamente composta”.
L’unica ipotesi - scartata alla fine quella dell’animale in vita - era che, da morto, fosse stato trasportato, intatto, spinto da forti correnti d’acqua. Secondo gli speleologi quest’acqua probabilmente trovava una via d’uscita nella buca di un metro e mezzo di altezza di cui dicevamo. Ma per questo sarebbero stati necessari altri studi.
A noi posteri rimane l'aver appreso di questa bella avventura che ci riporta indietro di oltre 50 anni ma anche di decine di millenni, ad un'era in cui su Monte Pellegrino vivevano i leoni. E dunque questo articolo vuole essere anche un ringraziamento al grande Giovanni Mannino, scomparso a 92 anni, nell'ottobre del 2021.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





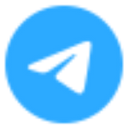


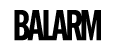





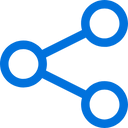
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram