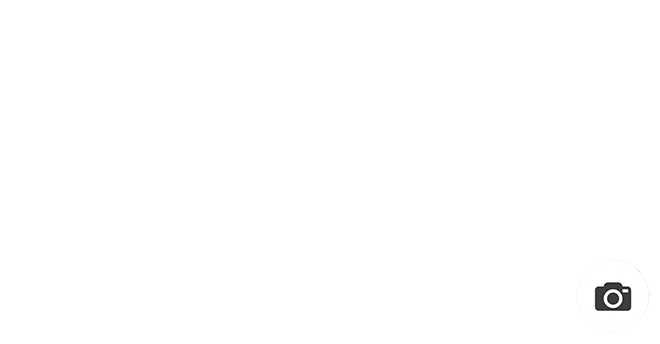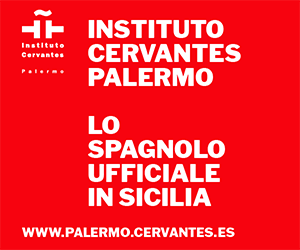TRADIZIONI
Amati da tutti, pure dal Gattopardo: i dolci dimenticati tra i chiostri nascosti in Sicilia
C’è una Sicilia che pulsa nei chiostri nascosti, tra mura che odorano di mandorle amare, dove il tempo non ha solo camminato, ma ha cucito storie e gusti
C’è una Sicilia che pulsa ancora nei chiostri nascosti, tra mura che odorano d’incenso e mandorle amare, dove il tempo non ha solo camminato, ma ha cucito storie, gusti, destini.
È la Sicilia dei monasteri femminili del Settecento, microcosmi in cui s’intrecciavano devozione e gerarchie nobiliari, spiritualità e pragmatismo aristocratico.
Di questo scrigno di memorie si è parlato il 27 maggio a Catania, grazie all’evento organizzato dal FAI, ideato da Antonella Mandalà, vice capo Delegazione del FAI di Catania e coordinato dalla Capo Delegazione Marilisa Spironello.
L’incontro si è tenuto presso il Monastero delle Benedettine di via Crociferi, capolavoro barocco e cuore silenzioso di una città che troppo spesso dimentica i suoi tesori.
A introdurre e moderare i lavori sono stati Stefania Scoglio e Giovanni Vetrano del FAI, guidando il pubblico attraverso un viaggio di parole e memorie condivise.
Tra i relatori, il professore Eugenio Magnano di San Lio, l’ingegnere Sergio d’Arrigo e il Maestro pasticcere Lillo Defraia.
Eugenio Magnano di San Lio ha aperto i lavori con un affondo sulle trasformazioni urbanistiche dei monasteri dopo il devastante terremoto del 1693, sottolineando come questi luoghi si siano reinventati nel rapporto con la città, diventando baluardi di resistenza e riorganizzazione del tessuto urbano.
Sergio d’Arrigo, con la precisione dello storico e la sensibilità del narratore, ha indagato i legami tra i monasteri e le grandi famiglie aristocratiche, partendo proprio dal casato dei Tomasi di Lampedusa, intrecciando architettura, genealogie e potere.
I monasteri non erano solo luoghi di clausura. Erano rifugi obbligati per le figlie cadette dell’aristocrazia, inserite in convento per preservare i patrimoni familiari.
Ma dentro quei portoni chiusi si muovevano donne colte, educate, eredi di saperi raffinati: dalla biblioteca alla cucina.
E proprio quest’ultima divenne un lascito indelebile, fatto di ricettari tramandati come reliquie, di profumi che raccontano influenze arabe, normanne, spagnole.
I dolci conventuali, creati nell’ombra del chiostro, erano gioielli di arte pasticcera: i “ricci”, i “nocattoli”, le paste di mandorla e i biscotti profumati di zagara.
E se tutto questo suona ancora lontano, ecco che la letteratura riaccende la memoria: fu a Palma di Montechiaro, nel monastero fondato proprio dai Tomasi, che Giuseppe Tomasi di Lampedusa trovò la forza di completare "Il Gattopardo".
Condotto lì dall’amico Francesco Agnello, Lampedusa – unico uomo ammesso tra quelle mura perché discendente diretto del fondatore – fu folgorato dalla bellezza del chiostro, dalla storia della “suora crocifissa” che scrisse una lettera dettata dal diavolo, e soprattutto dalla cucina.
Ne nacque un turbine d’emozioni: lo scrittore sentì su di sé il peso e l’onore della propria stirpe. E nel romanzo, tutto questo esplose in forma di parola, di tensione, e di banchetto: il cibo diventava simbolo, identità, estasi e addio.
All’appuntamento catanese cui ha preso parte anche Carla Verga, discendente del famoso Giovanni Verga, si è parlato di tutto questo: con studiosi, con testimonianze rare, con il Maestro Lillo Defraia, custode di quelle antiche ricette e con una giovane donna cresciuta tra le Benedettine.
Lei rappresenta l’ultima eco viva di un mondo in via d’estinzione, il ricordo discreto e prezioso, Concetta Marino, considerata l’ultima vera custode dei segreti conventuali, voce fragile ma tenace di una tradizione che oggi rischia di spegnersi.
Il Maestro ha preparato dei dolci tipici della cucina conventuale, come la spina santa, il trionfo di gola del Gattopardo, le crocette all’arancia e al limone e i bocconi al cioccolato, dolci che richiamano alla memoria profumi preziosi del passato ed evocano ricordi di un tempo che fu.
Ma se c’è ancora qualcuno disposto ad ascoltare, a scrivere, a gustare, forse quella Sicilia “di santi e di reclusi” potrà ancora parlare.
Anche solo attraverso un dolce riccio, modellato a mano come un’opera d’arte, e che racchiude in sé l’intera storia di un popolo.
E allora non resta che domandarcelo: davvero vogliamo lasciar svanire tutto questo in una nuvola di zucchero? No, non possiamo. Non dobbiamo. La Sicilia ha bisogno di ricordare, e soprattutto di raccontarsi.
Perché ogni riccio di mandorla, ogni suora che annotava ricette su foglietti macchiati di mosto, ogni chiostro immerso nel silenzio del pomeriggio estivo, è un frammento del nostro patrimonio più prezioso: la memoria viva.
È nei conventi, come in quello di Palma di Montechiaro o delle Benedettine di Catania, che si sono impastate le identità di un’isola intera: tra sacro e profano, tra clausura e festa, tra carezze celesti e tentazioni diaboliche (come quella famosa “lettera del diavolo” dettata a suor Crocifissa!).
E se oggi ci resta una giovane testimone che ha vissuto quegli ambienti, o un pasticcere che ha il coraggio di impastare ancora secondo quei codici antichi, allora abbiamo il dovere di ascoltarli.
Tramandare non vuol dire solo copiare una ricetta, ma onorare chi ci ha preceduti, ridare voce a chi parlava tra i muri spessi di un monastero, cucinare per chi non può più farlo.
Come scriveva Sciascia, “la memoria è l’unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati” – e forse anche il solo in cui possiamo ritrovare la nostra verità.
Che siano allora le cucine delle monache, i saloni nobiliari, le parole del Gattopardo, i dolci che profumano d’infanzia e silenzio, a guidarci verso un futuro che non rinnega, ma abbraccia il suo passato con fierezza.
Perché una Sicilia che sa ricordare è una Sicilia che sa resistere. E incantare.
È la Sicilia dei monasteri femminili del Settecento, microcosmi in cui s’intrecciavano devozione e gerarchie nobiliari, spiritualità e pragmatismo aristocratico.
Di questo scrigno di memorie si è parlato il 27 maggio a Catania, grazie all’evento organizzato dal FAI, ideato da Antonella Mandalà, vice capo Delegazione del FAI di Catania e coordinato dalla Capo Delegazione Marilisa Spironello.
L’incontro si è tenuto presso il Monastero delle Benedettine di via Crociferi, capolavoro barocco e cuore silenzioso di una città che troppo spesso dimentica i suoi tesori.
A introdurre e moderare i lavori sono stati Stefania Scoglio e Giovanni Vetrano del FAI, guidando il pubblico attraverso un viaggio di parole e memorie condivise.
Tra i relatori, il professore Eugenio Magnano di San Lio, l’ingegnere Sergio d’Arrigo e il Maestro pasticcere Lillo Defraia.
Eugenio Magnano di San Lio ha aperto i lavori con un affondo sulle trasformazioni urbanistiche dei monasteri dopo il devastante terremoto del 1693, sottolineando come questi luoghi si siano reinventati nel rapporto con la città, diventando baluardi di resistenza e riorganizzazione del tessuto urbano.
Sergio d’Arrigo, con la precisione dello storico e la sensibilità del narratore, ha indagato i legami tra i monasteri e le grandi famiglie aristocratiche, partendo proprio dal casato dei Tomasi di Lampedusa, intrecciando architettura, genealogie e potere.
I monasteri non erano solo luoghi di clausura. Erano rifugi obbligati per le figlie cadette dell’aristocrazia, inserite in convento per preservare i patrimoni familiari.
Ma dentro quei portoni chiusi si muovevano donne colte, educate, eredi di saperi raffinati: dalla biblioteca alla cucina.
E proprio quest’ultima divenne un lascito indelebile, fatto di ricettari tramandati come reliquie, di profumi che raccontano influenze arabe, normanne, spagnole.
I dolci conventuali, creati nell’ombra del chiostro, erano gioielli di arte pasticcera: i “ricci”, i “nocattoli”, le paste di mandorla e i biscotti profumati di zagara.
E se tutto questo suona ancora lontano, ecco che la letteratura riaccende la memoria: fu a Palma di Montechiaro, nel monastero fondato proprio dai Tomasi, che Giuseppe Tomasi di Lampedusa trovò la forza di completare "Il Gattopardo".
Condotto lì dall’amico Francesco Agnello, Lampedusa – unico uomo ammesso tra quelle mura perché discendente diretto del fondatore – fu folgorato dalla bellezza del chiostro, dalla storia della “suora crocifissa” che scrisse una lettera dettata dal diavolo, e soprattutto dalla cucina.
Ne nacque un turbine d’emozioni: lo scrittore sentì su di sé il peso e l’onore della propria stirpe. E nel romanzo, tutto questo esplose in forma di parola, di tensione, e di banchetto: il cibo diventava simbolo, identità, estasi e addio.
All’appuntamento catanese cui ha preso parte anche Carla Verga, discendente del famoso Giovanni Verga, si è parlato di tutto questo: con studiosi, con testimonianze rare, con il Maestro Lillo Defraia, custode di quelle antiche ricette e con una giovane donna cresciuta tra le Benedettine.
Lei rappresenta l’ultima eco viva di un mondo in via d’estinzione, il ricordo discreto e prezioso, Concetta Marino, considerata l’ultima vera custode dei segreti conventuali, voce fragile ma tenace di una tradizione che oggi rischia di spegnersi.
Il Maestro ha preparato dei dolci tipici della cucina conventuale, come la spina santa, il trionfo di gola del Gattopardo, le crocette all’arancia e al limone e i bocconi al cioccolato, dolci che richiamano alla memoria profumi preziosi del passato ed evocano ricordi di un tempo che fu.
Ma se c’è ancora qualcuno disposto ad ascoltare, a scrivere, a gustare, forse quella Sicilia “di santi e di reclusi” potrà ancora parlare.
Anche solo attraverso un dolce riccio, modellato a mano come un’opera d’arte, e che racchiude in sé l’intera storia di un popolo.
E allora non resta che domandarcelo: davvero vogliamo lasciar svanire tutto questo in una nuvola di zucchero? No, non possiamo. Non dobbiamo. La Sicilia ha bisogno di ricordare, e soprattutto di raccontarsi.
Perché ogni riccio di mandorla, ogni suora che annotava ricette su foglietti macchiati di mosto, ogni chiostro immerso nel silenzio del pomeriggio estivo, è un frammento del nostro patrimonio più prezioso: la memoria viva.
È nei conventi, come in quello di Palma di Montechiaro o delle Benedettine di Catania, che si sono impastate le identità di un’isola intera: tra sacro e profano, tra clausura e festa, tra carezze celesti e tentazioni diaboliche (come quella famosa “lettera del diavolo” dettata a suor Crocifissa!).
E se oggi ci resta una giovane testimone che ha vissuto quegli ambienti, o un pasticcere che ha il coraggio di impastare ancora secondo quei codici antichi, allora abbiamo il dovere di ascoltarli.
Tramandare non vuol dire solo copiare una ricetta, ma onorare chi ci ha preceduti, ridare voce a chi parlava tra i muri spessi di un monastero, cucinare per chi non può più farlo.
Come scriveva Sciascia, “la memoria è l’unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati” – e forse anche il solo in cui possiamo ritrovare la nostra verità.
Che siano allora le cucine delle monache, i saloni nobiliari, le parole del Gattopardo, i dolci che profumano d’infanzia e silenzio, a guidarci verso un futuro che non rinnega, ma abbraccia il suo passato con fierezza.
Perché una Sicilia che sa ricordare è una Sicilia che sa resistere. E incantare.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
LE FOTO PIÚ VISTE
-
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Aree verdi nell'ex stazione Lolli: nasce un nuovo campus universitario a Palermo
di Alice Marchese















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram