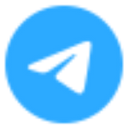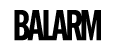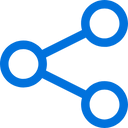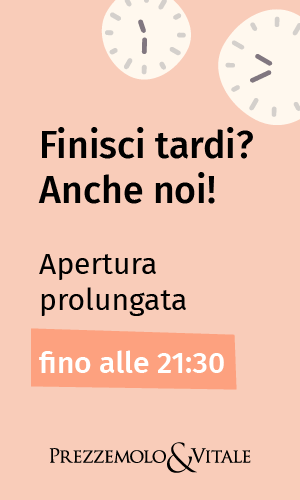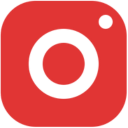LIBRI
“Minchia di Re”, un titolo irriverente che fa tremare i benpensanti
L’irriverenza non è nel titolo del libro, ma nell’assenza di memoria quando è scomoda alla morale comune o all’autorità costituita dagli uomini. Minchia di Re ( Mursia Editore, pagg. 185 – euro 13,00) toglie il velo a una verità coperta dagli archetipi di una società prigioniera del proprio bisogno essenziale, quello di sopravvivere. Negare l’evidenza porta a confrontarsi con se stessi prima o poi, ma allo stesso tempo il negarla in assoluto – sotterrandola nel silenzio – significa sradicare il concetto stesso di libertà. Giacomo Pilati – giornalista, scrittore trapanese e autore del libro – dissotterra una storia dimenticata, sedimentata sotto una cappa d’omertà, scovata quasi per caso, in quella “farfalla delle Egadi”, l’isola di Favignana, dirimpetto alla propria città. Il luogo non dichiarato è comunque riconoscibile; uno dei tanti angoli di Sicilia che nascostamente partorisce personaggi sconosciuti eppure controversi, irriverenti, ambigui, leggendari, cioè unici – per complessa drammaticità – e per questo stesso epici e destinati a divenire patrimonio di una terra dove il più si traduce in mistero.
La protagonista del racconto, Pina, si addormenta nei panni di donna e senza scampo si ritrova a dover vestire, il mattino successivo, panni maschili. Pantaloni, coppola e seno fasciato, tutto avvallato da una “correzione” del certificato di battesimo. In una finzione che durerà per tutta la sua vita tutti sembrano avere perso la memoria della verità, anche per terrore del curatolo, padre della ragazza, e di quel barone Burruto che può chiudere la cava e decretare la morte dell’economia dell’isola e di chi ci vive. Il personaggio è realmente esistito. Pina – poi Pino – si muove sullo sfondo di una Sicilia tra due sbarchi, quello piemontese e quello americano alleato.Pilati rivela – fuori dal libro – che Pina è nata nel 1868, morendo alla veneranda età di cent’anni, ma la necessità di voler limare edulcorate pagine di certa storia del Risorgimento – il passaggio dai Borboni ai Savoia non fu indolore in Sicilia, né ricco d’entusiasmi per le genti del meridione – lo porta a retrodatare la nascita allo sbarco garibaldino e ad accorciare nella finzione narrativa la vita della protagonista. Il racconto – che storico non è – abbozza la dolorosa vicenda della dittatura garibaldina e del dominio sabaudo per bocca di un esule nell’isola – lo strano personaggio del vecchio Cecè – che prigioniero, nel castello in cima alla collina, opera, in modo bizzarro, una lenta vendetta per la perdita dei figli, facendo dei propri carcerieri i veri prigionieri. Un gioco di parti che si inverte e ricompone nell’intera rappresentazione, in un costante equilibrio circolare che è comune a tutti i personaggi del racconto.
Per Pina l’incontro con il vecchio è fonte di conquista, la rivelazione della sua vera natura: «Ma tu sei una Viola» – dice Cecè alla ragazza – «La Viola è un pesce e lo ha voluto Dio. Quando è maschio si chiama Minchia di Re. Per amore diventa femmina e ha i colori del fiore. Torna di nuovo maschio dopo che l’acqua si è presa le sue uova». La fantasia del narrare rende anche queste metafore, partendo da un pesce ermafrodita detto appunto Donzella di Mare (nel dizionario italiano, n.d.r.) e in Sicilia – che è terra di colore, pure nel linguaggio – appunto Minchia di Re. Lo scrivere che l’autore mette in scena è una ricostruzione di effetti che dalla realtà muove lungo i binari della fantasia. Altri i passaggi veri, trattati in modo funzionale al racconto: il matrimonio in chiesa – con la bella e dolce Sara – e la visita di leva, dall’esito scontato. Eppure, alla rivelazione di Cecè, la ragazza è titubante e nonostante comprenda d’essere come il pesce ermafrodita afferma: «Ma io sempre questa resto.» – cioè una donna – e Cecè incalza «Tu devi morire un poco, per tornare a vivere come vuoi tu.». Gli occhi, le membra, il sangue e il sentimento di Pina-Pino sono tutti orientati alla ricerca del riscatto, per quell’amore negatogli fin dai primi attimi di respiro, poi durante l’adolescenza e giovinezza. La presenza di un padre-padrone, deluso dalla mancata nascita di un maschio; l’assenza di una madre, zittita dall’autorità maritale e per ciò vittima dello stesso annullamento patito dalla figlia; della zia zitella, animo mortificato e trafitto da un corpo pesante che espia gravi pene terrene in un circolo vizioso che spinge allo svilimento e alla vergogna; sono fertile humus dove si perde, e per tortuose circostanze si ritrova, l’identità della protagonista, che negli occhi e nelle movenze di Sara – l’amore conosciuto e all’inizio proibito – si riconosce.
Questa la realtà, che non è avvilimento ma purezza, e Pina chiede al vecchio come sia possibile il morire e poi rinascere senza fare violenza fisica a se stessi. Il prigioniero comprensivo allora spiega: «A mare il calamaro, dopo che ha perso le uova, muore di disperazione. I pesci briganti sono lì attorno, con la bocca aperta per sbranarselo, piccolo e tenero. Ma se lui resiste alla paura è salvo. E muore di vecchiaia. Perché ora è lui, grosso com’è che fa paura agli altri». In ogni risposta saggia c’è una predestinazione, così è anche nella risposta di Cecè. Nel tempo che passa c’è il momento del riscatto, ma il prezzo da pagare è durissimo. Pina morendo rinasce nella sua dignità di persona. Un riscatto che porta il personaggio a riappropriarsi di se stessa.
GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Chi le mangia "un mori mai": in Sicilia è un elisir di lunga vita e un (noto) modo di dire
52.977 di Gianluca Tantillo