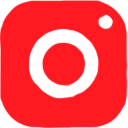ARTE E ARCHITETTURA
Le inquiete morfologie di Giovanni Leto
Quella di Giovanni Leto è una affermazione pittorica stratificata di tensioni, fratture, deflagrazioni: configurazioni compositive legate ad un fare dinamico e sicuro eppure mai azione automatica, quanto “gesto” che dà vita ad una premonizione della forma che matura fluidamente come proliferante entità organica. Tracce, grumi, segmenti cartacei, pagine di giornali attorcigliati (e, più recentemente, pagine stese, “strappi” di partiture) sono come reperti di un racconto interrotto, volto a stimolare ambiguità percettive sostenute da una molteplicità di orizzonti che obbliga lo sguardo a vagabondare sull'opera, quasi si volesse trovare un possibile “centro”, un punto che possa determinare una rassicurante lettura prospettica.
Probabilmente questo spaesamento visivo sposta ogni indizio fisico, tangibile, nel confine labile della metafisica: la mutazione della materia, la contaminazione del colore, ci indirizza verso territori lontani, evocazioni spaziali appartenenti ad un altrove geologico dalle inedite “Morfologie”, come suggerisce il titolo della bella mostra ospitata a Casteldaccia presso Chimù Handesign fino al 21 ottobre (via Pintello, 17-19; tutti i giorni ore 9.30-13 e 16.30-20, chiusura lunedì mattina e festivi; infoline 328 0613750) , interessante e dinamico “centro di ricerca per il design d'interni” gestito dall'intelligenza creativa dei suoi giovani ideatori, Lorenzo Guzzo e Caterina Tosi. Circa venti opere, di piccolo e medio formato, condividono lo spazio con i raffinati progetti dello show room, sintesi di gusto e capacità interpretativa, espressa in complementi d'arredo di efficacia contemporanea, creati con oggetti di riciclo (cestelli di lavatrici, scolapasta...) che divengono oggetti eleganti e colorati.
L'attuale produzione di Giovanni Leto, come abbiamo potuto osservare nella recente mostra antologica tenutasi presso il Museo d'Arte Contemporanea “Renato Guttuso” di Bagheria (curata da Enrico Crispolti), tende a una singolare scarnificazione, a un “impoverimento” del linguaggio che corrisponde ad una intensificazione del moto. Come fosse il gesto a creare lo spazio, portandoselo appresso, anzi, reinventandolo radicalmente. Non siamo mai di fronte ad una “costruzione” precisa, di architettonico richiamo: il procedere dell'artista, anche nei momenti di maggiore fisicità, è sempre evocativo. Propone un'idea di “luogo”, senza resistenza; un territorio sempre più rarefatto, precario, immateriale.
La percezione rapida degli oggetti, apparentemente sommaria nella loro posizione, ritrova configurazione più netta allorché uno schema di orizzontalità accentuata si riappropria della tridimensionalità che gli appartiene; e questa orizzontalità scrive regioni assolutamente bilanciate in cui le intersecazioni con i tessuti ora diagonali, ora verticali, diventano luogo di sintassi. Qualsiasi oggetto è una dimensione a sé stante, eppure, comunicante: i grumi cartacei, di colore, le incrostazioni materiche, si disgregano creando rapporti formali e spaziali che sono territorio di cadenze e pesi, di attrazioni e derive. Ogni elemento indica uno spazio, ogni riquadro stabilisce un ordine di sistemi e distanze, di possibili rapporti, input capaci di generare l'energia per attivare una scena, creare movenze di una fluenza plastica. L'elaborazione, tanto spontanea quanto calcolata, degli artifici del linguaggio pittorico, rivela la consapevolezza stilistica di Giovanni Leto, il suo lavoro assiduo di cancellazione, di riduzione, della materia e del segno.
Se prima Leto nutriva la necessità di saturare la superficie, di creare complessi magmatici di carta fibrosa, in queste più recenti opere la voglia di frammentarietà prende il sopravvento, accelera e ispessisce il corso, riduce la scia: da zone monocrome si sprigiona il vigore di un tracciato, la forza di solchi e sporgenze in corsa verso un ritaglio di cielo. Allora la massa diventa traccia, si accampa come il relitto di un naufragio nell'incendio ardente dei rossi, nelle ferite del nero, nelle nubi del bianco. Forse questi filamenti sparsi, inquieti nel loro errare, s'interrogano sulla stessa arbitrarietà dello spazio; lo scarnificarsi dell'opera, il suo configurarsi per tracce, inizia a indicare qualcosa di consunto, esprime la condizione di qualcosa che è stato e che non è più. Ecco allora che la superficie diventa il territorio non già di ciò che accoglie, di quanto è visibile “ora”, ma di ciò che verosimilmente “è stato”, o avrebbe potuto essere.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





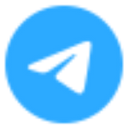


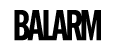




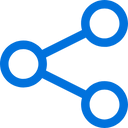
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram