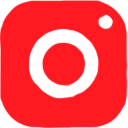Nell'oscurità del Medioevo brillavano Pina, Rosa e le altre: storie di ieri da leggere oggi
Dalla saracena all'ebrea, dalla signora della borghesia alla dama dell’alta aristocrazia: storie di donne coraggiose che hanno vissuto - e vinto - nella Palermo medievale

Illustrazione del 1497 di Robinet Testard per il libro "Eroine" di Publio Ovidio Nasone
Gli archivi di Palermo sono uno scrigno da cui ancora c’è tanto da scoprire. Nell’immensa mole di documentazione conservata, è documentata, mediante scritture a mano, non solo la storia dei Re e Vicerè, del Senato e dei Pretore che si sono susseguiti nel corso nei secoli ma anche la vita quotidiana della città.
Si ergono a protagonisti anche uomini e donne di ogni classe sociale. Certamente è più difficile reperire le notizie dei popolani, indubbiamente sono più difficili da cercare ma anche loro si trovano in loco, aspettano soltanto che qualcuno li porti alla luce.
Ancor più difficile è la ricerca di donne comuni, ma esistono, a dispetto della grande storia e degli avvenimenti storici più importanti. Palermo da sempre è stata popolata da donne coraggiose, alcune furono attive nel mondo del lavoro e diedero prova di autonomia che conquistarono a caro prezzo, superando enormi vincoli e costrizioni.
Si tratta di donne di diverse etnie e classi sociali, dalla saracena a quella ebrea, dalla signora della borghesia mercantile alla dama dell’alta aristocrazia.
Queste donne, ebbero in comune, il coraggio di mettersi in gioco e difendere i propri diritti, in una società maschilista che le relegava ad una condizione inferiore e subalterna rispetto agli uomini.
Alcune furono vere e proprie dipendenti pubbliche, come, ad esempio, le venditrici della Corte Pretoriana di Palermo, alle quali era affidato il compito di pignorare e mettere all’asta i beni dei debitori morosi.
Negli anni 1341-1410, sette delle quindici pubbliche venditrici in servizio per la Corte Pretoriana erano ebree, le rimanenti cristiane.
Più rare furono le imprenditrici in proprio, attività di solito riservata a donne di estrazione sociale elevata, spesso erano vedove che continuavano l’attività del marito defunto. Una di queste si chiamava Pina Spatafora.
Apparteneva alla famiglia dei conti Spatafora, una delle più importanti famiglie siciliane del Trecento. Vedova del mercante catalano Bernardo Roudus, dopo la morte di questi continuò ad esercitare il commercio, essendo socia di Pietro de Bertolino.
Risposatasi in seconde nozze, riuscì a mantenere la tutela dei figli avuti dal precedente matrimonio nonostante le proteste dello zio materno, che ricorse inutilmente al sovrano.
Per le donne di bassa estrazione sociale, era ancor più difficile difendere i propri diritti. Rosa, ad esempio, era la schiava del mercante genovese Iacopo de Vivaldis.
Questi, in punto di morte, nel suo testamento che porta la data del 13 Agosto 1400, la rese "liberta" (libera), sollevandola dalla schiavitù, a condizione che continuasse a lavorare nella sua casa per quattro anni dopo la sua morte.
Rosa rispettò il patto. Continuò a servire con diligenza la moglie ed i figli del padrone ma allo scadere dei quattro anni, chiese di essere lasciata libera.
I familiari di Iacopo de Vivaldis, però, si opposero a tale richiesta, anzi la cedettero ad un altro mercante genovese, tale Tommaso Spinola, che la tenne ancora come schiava.
La ragazza, con grande determinazione, nonostante l’enorme differenza di condizione sociale rispetto ai ricchi e potenti mercanti genovesi, non esitò a far valere i suoi diritti dinanzi alla Curia Arcivescovile di Palermo. Riuscì a vincere la sua battaglia, grazie a quel prezioso testamento di Jacopo de Vivaldis che esibì al processo e dal quale risultava inequivocabilmente il suo nuovo status di liberta.
Non sempre queste battaglie ebbero il lieto fine. È il caso di una donna che si chiamava Grazia, figlia di mastro Giovanni. Nel febbraio del 1338, sposò il notaio, Vivulo De Vivulis, ben inserito nella ricca borghesia palermitana del Trecento, fratello di un ricco mercante.
Grazia portò al marito una dote cospicua, grazie alla condizione di figlia di un maestro artigiano e sorella di un uomo di chiesa, l’abate Ippolito: 30 onze di corredo e oggetti, 29 in contanti, una vigna del valore di 60 onze ed una schiava saracena battezzata col nome Antonia.
Appena un mese dopo il matrimonio, grazie anche all’apporto economico della moglie e del cognato, che gli prestò una grossa somma di denaro, il notaio acquistò una casa a due piani alla Kalsa. Nonostante ciò, il matrimonio non durò più di due anni, a causa delle continue violenze dell’uomo sulla moglie.
Il marito, arrivò addirittura a cavarle un occhio e ad attentare alla sua vita. Lei lo denunciò e chiese la separazione. Ne seguì un’estenuante battaglia legale che si consumò tra Corte Pretoriana, Curia Arcivescovile e Magna Regia Curia.
Alla fine, nonostante la donna fosse difesa da uno dei più importanti giuristi del tempo, il notaio fu condannato a versarle gli alimenti nella misura di 8 onze all’anno ma la vicenda si concluse a vantaggio del marito ed in modo drammatico per la donna.
Il De Vivulis non solo non versò il dovuto, ma ottenne dalla Magna Regia Curia una sentenza che lo sollevava da quest’obbligo e che sanciva la divisione dei beni comuni, compresa la dote, senza computare nel calcolo gli alimenti mai versati in passato.
Grazia si appellò e ricorse presso lo stesso tribunale, ma pochi mesi dopo, nel febbraio 1342, morì, esattamente a distanza di appena quattro anni dall’infelice matrimonio, forse a causa dei maltrattamenti subiti dal marito.
Questi ebbe buon gioco nell’ottenere dalla Regia Curia, il riconoscimento del suo diritto alla metà dei beni comuni, appellandosi ad una consuetudine, visto che la divisione era avvenuta quando la moglie era ancora in vita.
Negli atti del processo, relativi, fu appena sfiorato il tema delle violenze domestiche, l’atteggiamento aggressivo del marito non incise sulle decisioni di ordine economico.
Le carte dichiarano che Grazia perse la sua battaglia, in realtà fu il simbolo di quel coraggio delle donne che, vittime di chi dovrebbe amarle in ogni tempo, non smettono di lottare e difendere la propria vita e la propria dignità. Anche a costo della morte o di perdere tutto.
Tratto dal libro "Donne di Sicilia", di Santi Gnoffo (Edizioni Qanat).
Si ergono a protagonisti anche uomini e donne di ogni classe sociale. Certamente è più difficile reperire le notizie dei popolani, indubbiamente sono più difficili da cercare ma anche loro si trovano in loco, aspettano soltanto che qualcuno li porti alla luce.
Ancor più difficile è la ricerca di donne comuni, ma esistono, a dispetto della grande storia e degli avvenimenti storici più importanti. Palermo da sempre è stata popolata da donne coraggiose, alcune furono attive nel mondo del lavoro e diedero prova di autonomia che conquistarono a caro prezzo, superando enormi vincoli e costrizioni.
Si tratta di donne di diverse etnie e classi sociali, dalla saracena a quella ebrea, dalla signora della borghesia mercantile alla dama dell’alta aristocrazia.
Queste donne, ebbero in comune, il coraggio di mettersi in gioco e difendere i propri diritti, in una società maschilista che le relegava ad una condizione inferiore e subalterna rispetto agli uomini.
Alcune furono vere e proprie dipendenti pubbliche, come, ad esempio, le venditrici della Corte Pretoriana di Palermo, alle quali era affidato il compito di pignorare e mettere all’asta i beni dei debitori morosi.
Negli anni 1341-1410, sette delle quindici pubbliche venditrici in servizio per la Corte Pretoriana erano ebree, le rimanenti cristiane.
Più rare furono le imprenditrici in proprio, attività di solito riservata a donne di estrazione sociale elevata, spesso erano vedove che continuavano l’attività del marito defunto. Una di queste si chiamava Pina Spatafora.
Apparteneva alla famiglia dei conti Spatafora, una delle più importanti famiglie siciliane del Trecento. Vedova del mercante catalano Bernardo Roudus, dopo la morte di questi continuò ad esercitare il commercio, essendo socia di Pietro de Bertolino.
Risposatasi in seconde nozze, riuscì a mantenere la tutela dei figli avuti dal precedente matrimonio nonostante le proteste dello zio materno, che ricorse inutilmente al sovrano.
Per le donne di bassa estrazione sociale, era ancor più difficile difendere i propri diritti. Rosa, ad esempio, era la schiava del mercante genovese Iacopo de Vivaldis.
Questi, in punto di morte, nel suo testamento che porta la data del 13 Agosto 1400, la rese "liberta" (libera), sollevandola dalla schiavitù, a condizione che continuasse a lavorare nella sua casa per quattro anni dopo la sua morte.
Rosa rispettò il patto. Continuò a servire con diligenza la moglie ed i figli del padrone ma allo scadere dei quattro anni, chiese di essere lasciata libera.
I familiari di Iacopo de Vivaldis, però, si opposero a tale richiesta, anzi la cedettero ad un altro mercante genovese, tale Tommaso Spinola, che la tenne ancora come schiava.
La ragazza, con grande determinazione, nonostante l’enorme differenza di condizione sociale rispetto ai ricchi e potenti mercanti genovesi, non esitò a far valere i suoi diritti dinanzi alla Curia Arcivescovile di Palermo. Riuscì a vincere la sua battaglia, grazie a quel prezioso testamento di Jacopo de Vivaldis che esibì al processo e dal quale risultava inequivocabilmente il suo nuovo status di liberta.
Non sempre queste battaglie ebbero il lieto fine. È il caso di una donna che si chiamava Grazia, figlia di mastro Giovanni. Nel febbraio del 1338, sposò il notaio, Vivulo De Vivulis, ben inserito nella ricca borghesia palermitana del Trecento, fratello di un ricco mercante.
Grazia portò al marito una dote cospicua, grazie alla condizione di figlia di un maestro artigiano e sorella di un uomo di chiesa, l’abate Ippolito: 30 onze di corredo e oggetti, 29 in contanti, una vigna del valore di 60 onze ed una schiava saracena battezzata col nome Antonia.
Appena un mese dopo il matrimonio, grazie anche all’apporto economico della moglie e del cognato, che gli prestò una grossa somma di denaro, il notaio acquistò una casa a due piani alla Kalsa. Nonostante ciò, il matrimonio non durò più di due anni, a causa delle continue violenze dell’uomo sulla moglie.
Il marito, arrivò addirittura a cavarle un occhio e ad attentare alla sua vita. Lei lo denunciò e chiese la separazione. Ne seguì un’estenuante battaglia legale che si consumò tra Corte Pretoriana, Curia Arcivescovile e Magna Regia Curia.
Alla fine, nonostante la donna fosse difesa da uno dei più importanti giuristi del tempo, il notaio fu condannato a versarle gli alimenti nella misura di 8 onze all’anno ma la vicenda si concluse a vantaggio del marito ed in modo drammatico per la donna.
Il De Vivulis non solo non versò il dovuto, ma ottenne dalla Magna Regia Curia una sentenza che lo sollevava da quest’obbligo e che sanciva la divisione dei beni comuni, compresa la dote, senza computare nel calcolo gli alimenti mai versati in passato.
Grazia si appellò e ricorse presso lo stesso tribunale, ma pochi mesi dopo, nel febbraio 1342, morì, esattamente a distanza di appena quattro anni dall’infelice matrimonio, forse a causa dei maltrattamenti subiti dal marito.
Questi ebbe buon gioco nell’ottenere dalla Regia Curia, il riconoscimento del suo diritto alla metà dei beni comuni, appellandosi ad una consuetudine, visto che la divisione era avvenuta quando la moglie era ancora in vita.
Negli atti del processo, relativi, fu appena sfiorato il tema delle violenze domestiche, l’atteggiamento aggressivo del marito non incise sulle decisioni di ordine economico.
Le carte dichiarano che Grazia perse la sua battaglia, in realtà fu il simbolo di quel coraggio delle donne che, vittime di chi dovrebbe amarle in ogni tempo, non smettono di lottare e difendere la propria vita e la propria dignità. Anche a costo della morte o di perdere tutto.
Tratto dal libro "Donne di Sicilia", di Santi Gnoffo (Edizioni Qanat).
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





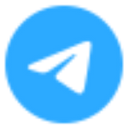


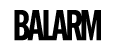





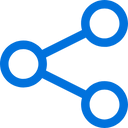
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram