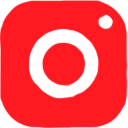Palermo com'era e com'è: piccolo manuale di sopravvivenza (per gente onesta)
Come andavano le cose negli anni '80 e poi dopo le Stragi di mafia e come sono ora. Un promemoria su ciò che siamo stati, che siamo e che forse oggi dovremmo essere

Picciotti, io me la ricordo la Palermo degli anni ’80. Vero è, ero nicareddu, ma quella città mi è rimasta addosso come la puzza di benzina della 126 di mia madre, bianca, prima serie, col motore dietro e il portapacchi i ravanzi che ci trasievano a stento due sacchetti, zero cintura di sicurezza e con lo specchietto retrovisore montato “per comodità”, mica perché era previsto.
Eravamo appena usciti da una sanitaria in via Oreto. Lei guidava, io guardavo fuori e volevo le brioscine. Due picciottonazzi, uno con la polo Lacoste arancione (forse è per questo che a mia a Lacoste mi sta in capu a min… vabbè ci siamo capiti), così normali da sembrare invisibili, si avvicinarono, aprirono lo sportello e provarono a prendere la borsa.
Dico provarono perché io gridai “la borsa, mamma!”, e lei, con quella tipica calma da tempesta di scirocco siciliana, cominciò a chiudere lo sportello a raffica sull’unico arto disponibile del ladro, come se volesse staccarglielo, un braccio che presto imparò il significato di “non t’arrisicare a ncuitari una madre palermitana”.
Quello cominciò a gridare di dolore a sua volta, mollò, scappò, e noi restammo in mezzo al traffico. Centinaia di occhi che avevano osservato tutto il siparietto, ovviamente zero mani mosse. Tutti impegnati a campare cent’anni, che si sa, la salute prima di tutto. Mia madre no, vide un vecchio camioncino Fiat 900T dei carabinieri, lo fermò, fece la descrizione ai militari, e quando li presero, erano fermi a leccarsi le ferite a due vicoli di distanza, lei li indicò senza tremare.
«Signora, ma che fa?”, “La borsa non gliel’hanno pigghiata, e lei li fa pure arrestare? Nun si scanta che la vengono a cercare?», questo il panettiere dove mia madre alla fine mi stava comprando le brioscine, che io non volli più. “No,” rispose lei, «questa città non è loro, è nostra, e loro sono "ospiti sgraditi"».
Forse fu lì che capii cosa voleva dire “onestà”, non un concetto semplice, ma senza dubbio rischioso, almeno alle nostre latitudini. A diciassett’anni, quando vidi due scippare una signora, gli buttai giù il vespino con un calcio. Loro volarono, la borsa tornò, e io rimasi con la convinzione — che mi porto dietro ancora oggi — che il coraggio, a Palermo, è una malattia genetica. Si eredita, ogni tanto ti ammazza e ti fa male, ma purtroppo te la porti dentro.
E oggi? Oggi incoccio il video del grandissimo Dario Cascio col suo “The Sicilian Wanderer”, fatto mentre ancora si sente l’eco dello sparo che ha ucciso Paolo Taormina, un ragazzo che ha fatto la cosa giusta. Non un eroe, no. Un cristiano normale, un picciuttieddu che travagghiava, uno di quelli che magari davanti a una sciarra non ce la fa a fare solo da spettatore e dice: “Amunì non ci fu niente, pigghiamune u cafè” Ma il caffè non basta più.
Oggi rischi che uno, con una pistola in sacchetta carica di frustrazione, ignoranza ed emulazione, decida che per te non ci debbano essere più cafè i pigghiarisi. E lui, u gaggio che paura non ne ha e si fa “rispettare”, è convinto che Palermo sia pericolosa e non capisce che la pericolosità la crea lui e quelli come lui, che se la porta in tasca, assieme u ferro e alla melma che si ritrova in testa. La caricatura perfetta del palermitano che urla “u stato un c’è”, ma che trova lecito sentirsi sopra lo Stato, giudice, giuria e carnefice. Io, nel ’92, ci avevo creduto. Dopo Falcone e Borsellino pensai che stavamo cambiando.
E invece eccoci qua, alla fine Palermo si è solo abituata alla puzza. Perché la mafia, quello che cerco di fare capire ad amici e conoscenti del nord o esteri, non è solo u ferro na sacchetta o un’estorsione, ma un modo di vivere, una mentalità, un atteggimento, anche piccoli gesti. “ma a mia chi minni fuotte?” “Cu si fa i cazzi soi campa cent’anni".
E il problema è che campano davvero, magari pure meglio di te, anche se non so se riescano a dormire sereni la notte. Perché forse mafia è mettere la musica a tutto volume e dire “io fazzu un zu cu vogghiu”, “se i case un trimuliano allora il volume è basso”.
Forse mafia è stare zitti perché “è meglio non avere problemi”. Forse mafia è votare “Pippinieddu” perché “lo conosciamo da piccoli, non è cattivo, ruba ma con educazione, e poi si fa rispettare, e poi amunì rubano tutti, t’apprecare proprio a iddu?”. Forse mafia è lasciare la macchina in quarta fila e sentirsi chiù scaltri nel dire a quello che deve uscire “e che fa un po' aspittare 5 minuti? Chi l’hai na pariedda?” Forse mafia è il Totò Termini di turno che accelera sulle strisce perché “lui deve passare, l’altro deve morire educato”.
Forse mafia è lamentarsi dello Stato mentre si sbutria la sesta stecca di stigghiola dall’abusivo. E forse mafia è anche quando un bambino dice “ti faccio fare la fine di Paolo Taormina”. Lì, signori miei, non si arrizzano solo i carni, ma proprio s’astuta a luce. E allora? Allora tocca a noi, a quelli che ancora si ostinano a pensare che Palermo possa essere una città e non una diagnosi infausta A quelli che nonostante tutto continuano a dire “no”, anche se lo dicono sottovoce, che è sottovoce oggi, magari domani sarà urlato. Perché alla fine, in questa giungla di paura e indifferenza, l’unica vera bestemmia è restare “normali”.
Eravamo appena usciti da una sanitaria in via Oreto. Lei guidava, io guardavo fuori e volevo le brioscine. Due picciottonazzi, uno con la polo Lacoste arancione (forse è per questo che a mia a Lacoste mi sta in capu a min… vabbè ci siamo capiti), così normali da sembrare invisibili, si avvicinarono, aprirono lo sportello e provarono a prendere la borsa.
Dico provarono perché io gridai “la borsa, mamma!”, e lei, con quella tipica calma da tempesta di scirocco siciliana, cominciò a chiudere lo sportello a raffica sull’unico arto disponibile del ladro, come se volesse staccarglielo, un braccio che presto imparò il significato di “non t’arrisicare a ncuitari una madre palermitana”.
Quello cominciò a gridare di dolore a sua volta, mollò, scappò, e noi restammo in mezzo al traffico. Centinaia di occhi che avevano osservato tutto il siparietto, ovviamente zero mani mosse. Tutti impegnati a campare cent’anni, che si sa, la salute prima di tutto. Mia madre no, vide un vecchio camioncino Fiat 900T dei carabinieri, lo fermò, fece la descrizione ai militari, e quando li presero, erano fermi a leccarsi le ferite a due vicoli di distanza, lei li indicò senza tremare.
«Signora, ma che fa?”, “La borsa non gliel’hanno pigghiata, e lei li fa pure arrestare? Nun si scanta che la vengono a cercare?», questo il panettiere dove mia madre alla fine mi stava comprando le brioscine, che io non volli più. “No,” rispose lei, «questa città non è loro, è nostra, e loro sono "ospiti sgraditi"».
Forse fu lì che capii cosa voleva dire “onestà”, non un concetto semplice, ma senza dubbio rischioso, almeno alle nostre latitudini. A diciassett’anni, quando vidi due scippare una signora, gli buttai giù il vespino con un calcio. Loro volarono, la borsa tornò, e io rimasi con la convinzione — che mi porto dietro ancora oggi — che il coraggio, a Palermo, è una malattia genetica. Si eredita, ogni tanto ti ammazza e ti fa male, ma purtroppo te la porti dentro.
E oggi? Oggi incoccio il video del grandissimo Dario Cascio col suo “The Sicilian Wanderer”, fatto mentre ancora si sente l’eco dello sparo che ha ucciso Paolo Taormina, un ragazzo che ha fatto la cosa giusta. Non un eroe, no. Un cristiano normale, un picciuttieddu che travagghiava, uno di quelli che magari davanti a una sciarra non ce la fa a fare solo da spettatore e dice: “Amunì non ci fu niente, pigghiamune u cafè” Ma il caffè non basta più.
Oggi rischi che uno, con una pistola in sacchetta carica di frustrazione, ignoranza ed emulazione, decida che per te non ci debbano essere più cafè i pigghiarisi. E lui, u gaggio che paura non ne ha e si fa “rispettare”, è convinto che Palermo sia pericolosa e non capisce che la pericolosità la crea lui e quelli come lui, che se la porta in tasca, assieme u ferro e alla melma che si ritrova in testa. La caricatura perfetta del palermitano che urla “u stato un c’è”, ma che trova lecito sentirsi sopra lo Stato, giudice, giuria e carnefice. Io, nel ’92, ci avevo creduto. Dopo Falcone e Borsellino pensai che stavamo cambiando.
E invece eccoci qua, alla fine Palermo si è solo abituata alla puzza. Perché la mafia, quello che cerco di fare capire ad amici e conoscenti del nord o esteri, non è solo u ferro na sacchetta o un’estorsione, ma un modo di vivere, una mentalità, un atteggimento, anche piccoli gesti. “ma a mia chi minni fuotte?” “Cu si fa i cazzi soi campa cent’anni".
E il problema è che campano davvero, magari pure meglio di te, anche se non so se riescano a dormire sereni la notte. Perché forse mafia è mettere la musica a tutto volume e dire “io fazzu un zu cu vogghiu”, “se i case un trimuliano allora il volume è basso”.
Forse mafia è stare zitti perché “è meglio non avere problemi”. Forse mafia è votare “Pippinieddu” perché “lo conosciamo da piccoli, non è cattivo, ruba ma con educazione, e poi si fa rispettare, e poi amunì rubano tutti, t’apprecare proprio a iddu?”. Forse mafia è lasciare la macchina in quarta fila e sentirsi chiù scaltri nel dire a quello che deve uscire “e che fa un po' aspittare 5 minuti? Chi l’hai na pariedda?” Forse mafia è il Totò Termini di turno che accelera sulle strisce perché “lui deve passare, l’altro deve morire educato”.
Forse mafia è lamentarsi dello Stato mentre si sbutria la sesta stecca di stigghiola dall’abusivo. E forse mafia è anche quando un bambino dice “ti faccio fare la fine di Paolo Taormina”. Lì, signori miei, non si arrizzano solo i carni, ma proprio s’astuta a luce. E allora? Allora tocca a noi, a quelli che ancora si ostinano a pensare che Palermo possa essere una città e non una diagnosi infausta A quelli che nonostante tutto continuano a dire “no”, anche se lo dicono sottovoce, che è sottovoce oggi, magari domani sarà urlato. Perché alla fine, in questa giungla di paura e indifferenza, l’unica vera bestemmia è restare “normali”.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ARTE E ARCHITETTURA
A Palermo riapre il monastero di Santa Caterina: dopo 100 anni "torna" Van Dyck
di Maria Oliveri





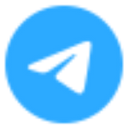


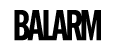





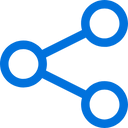
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram