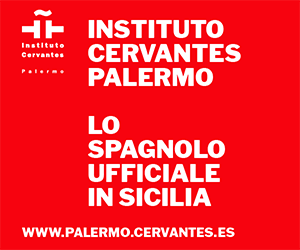Scoperto in Sicilia un candelabro di mille anni fa: testimone di un'epoca di guerre
È stato ritrovato all’interno di una cavità gessosa ricavata nel castello di Sutera, oggi in rovina, forse destinato all’illuminazione di un edificio religioso. Che cosa sappiamo

Il Polycandelon di Sutera
Nei pressi dei ruderi del castello medievale di Sutera, arroccato sul Monte San Paolino, gli archeologi hanno portato alla luce un prezioso candelabro risalente a oltre un millennio fa, testimone di un’epoca segnata da guerre.
Il reperto, identificato come un polycandelion bizantino, ovvero un tipo di lampadario liturgico, era dotato di quattro alloggiamenti per lucerne, ognuno dei quali misura circa 15 centimetri di diametro.
Realizzato in metallo e composto da una corona circolare, decorata con motivi cruciformi, il candelabro venne probabilmente sospeso al soffitto del castello tramite delle catenelle ed era destinato all’illuminazione di un edificio religioso di rito greco.
Il candelabro è stato ritrovato all’interno di una cavità gessosa ricavata nel castello, oggi in rovina. Secondo gli esperti della Soprintendenza per i Beni culturali di Caltanissetta e dei Gruppi Archeologici d’Italia, che hanno partecipato agli scavi che hanno permesso di ottenere la scoperta, il manufatto sarebbe stato deliberatamente smontato e nascosto, nel tentativo di proteggerlo da potenziali furti.
A confermare questa ipotesi è anche l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, che in una intervista ha dichiarato «riteniamo che il candelabro sia stato occultato intenzionalmente, probabilmente durante uno dei numerosi momenti di crisi che hanno segnato la Sicilia bizantina, in particolare durante i primi attacchi musulmani del IX secolo.
Non si tratta di un caso isolato: diversi tesori e oggetti liturgici furono nascosti in quel periodo per sottrarli alla razzia». Per celarne l’esistenza, gli abitanti del castello ricoprirono persino il manufatto con uno spesso strato di malta, rendendone quasi impossibile l’individuazione.
Solo grazie a sofisticate tecniche di indagine e all’abilità degli archeologi è stato possibile riportarlo alla luce. Il ritrovamento di Sutera ci permette di conoscere un contesto storico affascinante, sebbene contrassegnato da numerose violenze e peripezie.
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la Sicilia entrò a far parte dell’Impero Bizantino a partire dal VI secolo, sotto la dominazione dell’imperatore Giustiniano.
L’isola divenne poi una provincia strategica – il Thema di Sicilia – al centro del Mediterraneo, governata da un dux o da un strategos inviato da Costantinopoli.
Per alcuni anni, Siracusa divenne persino la capitale ufficiale dell’impero bizantino, dal 663 al 669 d.C., quando l'imperatore Costante II trasferì la sua corte da Costantinopoli alla città siciliana, nel tentativo di porre l'Italia intera sotto il suo dominio. Un’impresa che non gli riuscì, per via della presenza delle varie popolazioni barbariche ormai di stanza nella penisola.
Nel corso dei secoli successivi, la Sicilia visse una profonda bizantinizzazione, sia nell’organizzazione amministrativa che nella vita religiosa. I monaci greco-ortodossi, insediatisi anche a Sutera – comune oggi inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia - costruirono monasteri, cappelle rupestri e luoghi di culto, spesso riutilizzando strutture preesistenti, come tombe sicane o edifici tardo-romani.
Anche monumenti pagani, come i templi di Agrigento, subirono questo precesso, divenendo presto dei centri religiosi cristiani. A partire però dall’827, con lo sbarco degli eserciti islamici provenienti dall’attuale Tunisia, iniziò una lunga fase di conflitti, che portò al diffondersi di violenze tra islamici e cristiani.
La crisi culminò con la caduta dell’ultima roccaforte bizantina, nel 965. In quel contesto di invasioni e saccheggi, molti oggetti sacri vennero nascosti o distrutti, ed è proprio per salvaguardare i tesori del castello di Sutera se gli allora abitanti della città decisero probabilmente di celare i tesori sacri della comunità.
Il candelabro di Sutera, nascosto con estrema cura, potrebbe dunque essere l’eco di quei drammatici eventi: un frammento prezioso di una civiltà scomparsa, che oggi riemerge dal sottosuolo per raccontare un pezzo dimenticato della storia siciliana. Il reperto è attualmente in fase di restauro e studio.
Le autorità locali e la Regione Siciliana stanno valutando la possibilità di esporlo in un museo del territorio, magari proprio a Sutera, nell’ambito di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio archeologico bizantino dell’entroterra siciliano.
Il reperto, identificato come un polycandelion bizantino, ovvero un tipo di lampadario liturgico, era dotato di quattro alloggiamenti per lucerne, ognuno dei quali misura circa 15 centimetri di diametro.
Realizzato in metallo e composto da una corona circolare, decorata con motivi cruciformi, il candelabro venne probabilmente sospeso al soffitto del castello tramite delle catenelle ed era destinato all’illuminazione di un edificio religioso di rito greco.
Il candelabro è stato ritrovato all’interno di una cavità gessosa ricavata nel castello, oggi in rovina. Secondo gli esperti della Soprintendenza per i Beni culturali di Caltanissetta e dei Gruppi Archeologici d’Italia, che hanno partecipato agli scavi che hanno permesso di ottenere la scoperta, il manufatto sarebbe stato deliberatamente smontato e nascosto, nel tentativo di proteggerlo da potenziali furti.
A confermare questa ipotesi è anche l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, che in una intervista ha dichiarato «riteniamo che il candelabro sia stato occultato intenzionalmente, probabilmente durante uno dei numerosi momenti di crisi che hanno segnato la Sicilia bizantina, in particolare durante i primi attacchi musulmani del IX secolo.
Non si tratta di un caso isolato: diversi tesori e oggetti liturgici furono nascosti in quel periodo per sottrarli alla razzia». Per celarne l’esistenza, gli abitanti del castello ricoprirono persino il manufatto con uno spesso strato di malta, rendendone quasi impossibile l’individuazione.
Solo grazie a sofisticate tecniche di indagine e all’abilità degli archeologi è stato possibile riportarlo alla luce. Il ritrovamento di Sutera ci permette di conoscere un contesto storico affascinante, sebbene contrassegnato da numerose violenze e peripezie.
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la Sicilia entrò a far parte dell’Impero Bizantino a partire dal VI secolo, sotto la dominazione dell’imperatore Giustiniano.
L’isola divenne poi una provincia strategica – il Thema di Sicilia – al centro del Mediterraneo, governata da un dux o da un strategos inviato da Costantinopoli.
Per alcuni anni, Siracusa divenne persino la capitale ufficiale dell’impero bizantino, dal 663 al 669 d.C., quando l'imperatore Costante II trasferì la sua corte da Costantinopoli alla città siciliana, nel tentativo di porre l'Italia intera sotto il suo dominio. Un’impresa che non gli riuscì, per via della presenza delle varie popolazioni barbariche ormai di stanza nella penisola.
Nel corso dei secoli successivi, la Sicilia visse una profonda bizantinizzazione, sia nell’organizzazione amministrativa che nella vita religiosa. I monaci greco-ortodossi, insediatisi anche a Sutera – comune oggi inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia - costruirono monasteri, cappelle rupestri e luoghi di culto, spesso riutilizzando strutture preesistenti, come tombe sicane o edifici tardo-romani.
Anche monumenti pagani, come i templi di Agrigento, subirono questo precesso, divenendo presto dei centri religiosi cristiani. A partire però dall’827, con lo sbarco degli eserciti islamici provenienti dall’attuale Tunisia, iniziò una lunga fase di conflitti, che portò al diffondersi di violenze tra islamici e cristiani.
La crisi culminò con la caduta dell’ultima roccaforte bizantina, nel 965. In quel contesto di invasioni e saccheggi, molti oggetti sacri vennero nascosti o distrutti, ed è proprio per salvaguardare i tesori del castello di Sutera se gli allora abitanti della città decisero probabilmente di celare i tesori sacri della comunità.
Il candelabro di Sutera, nascosto con estrema cura, potrebbe dunque essere l’eco di quei drammatici eventi: un frammento prezioso di una civiltà scomparsa, che oggi riemerge dal sottosuolo per raccontare un pezzo dimenticato della storia siciliana. Il reperto è attualmente in fase di restauro e studio.
Le autorità locali e la Regione Siciliana stanno valutando la possibilità di esporlo in un museo del territorio, magari proprio a Sutera, nell’ambito di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio archeologico bizantino dell’entroterra siciliano.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram