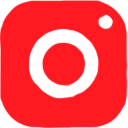TRADIZIONI
Come se la spassavano i monaci siciliani a tavola: pance piene, mortaretti e tornagusto
Siamo nell'Isola tra ‘700 e ‘800, quando gli ordini monastici preparano manicaretti di ogni genere. Tradizioni, storie e ricette arrivate fino a oggi. Eccone alcune

Timballo del Gattopardo
E per i gelati, per lo spumone, per la cassata gelata, i padri avevano chiamato apposta da Napoli don Tino, il giovane del caffè di Benvenuto».
Siamo nella Catania tra '700 e '800, epoca in cui numerose comunità monastiche, soprattutto quella dei Benedettini, appartenenti all'élite cittadina, prosperano grazie a ricchezze e rendite mentre il popolo soffre la fame.
E la classe meno abbiente della città infatti odia (e invidia) questi monaci privilegiati che non pagano i dazi per le merci pregiate e abbondanti che quotidianamente arrivano al convento.
I registri delle spese del monastero di S.Nicolò, conservati presso l'Archivio di Stato di Catania e studiati da Renata Rizzo Pavone e Anna Maria Iozzia, dal cui saggio attingiamo le informazioni, ci permettono di ricostruire un quadro molto interessante dello stile di vita dell'ordine benedettino di quel tempo.
Se curiosiamo in questi conti quotidiani, infatti, troviamo notizia delle quantità e della qualità degli acquisti alimentari, delle ricette per le preparazioni e persino del numero dei commensali.
L'alimentazione seguiva degli schemi molto metodici, a seconda delle occasioni come festività, digiuni e limitazioni imposte dalla regola dell'ordine.
C'era ad esempio il divieto di mangiare carne di quadrupedi, ma poiché esisteva per questo una deroga concessa tre volte la settimana, il pranzo in quei giorni consisteva in ben cinque portate.
La prima era di carne (circa mezzo chilo a testa!), seguiva la minestra di pasta, riso o couscous ( intorno a 150 grammi) conditi con carne e verdura oppure fave e lardo, o zucca, prosciutto e carne, o ancora "melinfante, minutissime palline di semolino impastato con uova e cotte nel brodo di carne".
La terza portata era il tornagusto, tipico della cucina aristocratica dell'epoca, consistente in qualche cibo che stuzzicasse (ancora!) l'appetito, come queste sfogliatine (segnatevi la ricetta!) ripiene di rognoni, carne, uova, miele, zucchero, uva passa, pinoli e altro bendidio.
Oppure i "mortaretti", pasticci con carne, ricotta e caciocavallo o ancora "impanate" ( di ascendenza spagnola) con pasta, lardo, salsiccia, soppressata e ancora molto altro.
C'è il rischio di indigestione alla sola lettura. La quarta portata è l’arrosto (spesso salsiccia) e infine la frutta o, come si chiamava allora, il "sopratavola".
Certo questi monaci erano tutt'altro che vegetariani e viene anche da chiedersi quale fosse la durata media della loro vita e il loro stato di salute.
La cena comunque in confronto era un pasto leggero: consisteva in un primo piatto, minestra di verdure dell'orto del convento, un secondo di pesce e una "terza cosa" ( così è indicata nei registri), cioè una pietanza di formaggio, ricotta, caponata, pane fritto con le uova, pasticci vari o un riso dolce condito con cioccolata, zucchero, mandorle, cannella, chiodi di garofano.
Infine la “foglia" ovvero finocchi o altri ortaggi.
Il lunedì era un giorno in cui si alleggerivano i bagordi alimentari dei giorni precedenti consumando un pranzo a base di uova, minestra, una “terza cosa" e frutta.
Nei giorni di astinenza dalla carne (venerdì e sabato) le portate di pesce erano due, di qualità e quantità diversa, per un totale di circa mezzo chilo a testa, di solito fritto e accompagnato da stuzzicanti salsine di pomodori e alici, o mandorle e miele.
Questo pasto inoltre comprendeva anche una minestra robusta: leggiamo una ricetta di zuppa (degna di uno chef d'oggi!) a base di ceci, pesce ed erbette. Una nota degna di attenzione: per compensare la “povertà “ dei menu di magro, le quantità pro capite erano notevolmente maggiorate.
Nelle grandi festività poi il menu prevedeva un ulteriore numero di pietanze di carne: rognone, fegato, galline, capretti, gelatina di maiale.
Le costanti rilevate nelle abitudini alimentari dei Benedettini si possono ricondurre dunque a un consumo sbalorditivo di carni; un uso indiscriminato di dolci( zucchero, miele, cioccolata, uva passa), aggiunti anche nelle preparazioni salate alla maniera araba.
Un’eccessiva frittura delle pietanze (pesce, crispelle dolci e salate e altro). Questi dati risaltano ancor più se messi a confronto con quelli – raccolti dalle studiose citate – riguardanti le spese alimentari di altri ordini religiosi a Catania nello stesso periodo, dove i pasti comprendono un numero di portate inferiore e quantità dimezzate, rivelando un stile di vita sobrio anche nella qualità non pregiata degli alimenti.
I Carmelitani, ad esempio, consumavano settimanalmente frattaglie e interiora (che i Benedettini snobbavano) e i frati minimi del convento di San Francesco di Paola addirittura obbedivano a una regola che richiedeva un perpetuo regime quaresimale, mentre la cucina dei ricchi e nobili Benedettini negli anni progrediva in raffinatezze gastronomiche grazie ai migliori cuochi al loro servizio.
Ancora il De Roberto nei Vicerè racconta che durante i pasti, mentre i frati banchettavano, un confratello Lettore "biascicava, dall'alto del pulpito, la regola di San Benedetto: (…) non esser superbo; non dedito al vino; non gran mangiatore; non dormiglione; non pigro".
Il Santo fondatore dell'Ordine aveva ordinato anche che per il sostentamento quotidiano bastassero due vivande cotte e una libbra di pane e a proposito del vino il massimo consentito fosse un quartino al giorno, ma non si può dire che tali regole avessero molto seguito.
«Padre Currera, segnatamente, - scrive De Roberto - una delle più valenti forchette, si levava di tavola ogni giorno mezzo cotto, e quando tornava in camera, dimenando il pancione gravido, con gli occhietti lucenti dietro gli occhiali d'oro posati sul naso fiorito, dava altri baci al fiasco che teneva giorno e notte sotto il letto, al posto del pitale.
Gli altri monaci, subito dopo tavola, se ne uscivano dal convento, si sparpagliavano pel quartiere popolato di famiglie, ciascuna delle quali aveva il suo Padre protettore(…)».
Si celebrava insomma sulla tavola un vero trionfo del peggiore barocchismo, oltre che un inno allo spreco. Emblema di una società in disfacimento.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





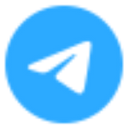


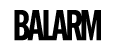





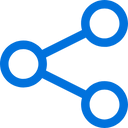
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram