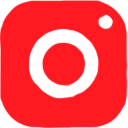ITINERARI E LUOGHI
Il carcere sul "Cassaro morto" a Palermo: la storia (terribile) dei detenuti della Vicarìa
Era nell'abbandonato Palazzo delle Finanze, che ancor prima di diventare la Camera di Commercio della città, era l'orribile carcere per i detenuti di basso rango

Il palazzo delle finanze a Palermo
Il Palazzo delle Finanze, ancor prima di diventare la Camera di Commercio della città, era un terribile carcere per i detenuti di basso rango chiamato la Vicarìa.
Della storia dell'edificio scrissi già a suo tempo in un altro articolo, vale la pena adesso concentrarsi sulla vita condotta dai detenuti in questa terribile fortezza e comprendere perché allora era così temuta.
Perfino il grande scrittore Luigi Natoli, seppur ancora un bambino, conobbe la Vicarìa perché nel 1860, saputo dell'arrivo di Garibaldi, la madre vestì lui e tutti i suoi fratelli con una camicia rossa per salutare l'arrivo dell'eroe.
Sarà anche per questo che nei suoi romanzi si avverte una vena anti-borbonica, chissà cosa scriverebbe oggi guardando le conseguenze dell'Unità, non lo sapremo mai.
A darci un'idea di come potessero vivere i detenuti della Vicarìa è un breve passo tratto dai Capitoli della venerabile opera di nostra Signora Santa Maria di Visita Carceri stampata nel 1747.
«Quì le gravi, cottidiane miserie onde oppressi gemevano i poveri carcerati, privi essendo dell'amministrazione dei Sacramenti, ed Esercizi Spirituali tanto necessari all'interesse dell'anima;
Privi altresì di assistenza di Procuratore nelle loro cause sì civili, che criminali astretti perciò ad eternarsi, per così dire nell'orror delle carceri, non avendo chi li provvedesse di vitto cotidiano, di vesti e d'ogni altra cosa che fosse all'umana natura bisognevole, in modo che riducevansi a morire di pura fame e di nudità».
Fu concependo una tale disumana realtà che nel 1627 nacque l'opera di Santa Maria di Visita Carceri con l'intento di provvedere ai carcerati dimenticati nelle carceri della città.
In sostanza la vita dei detenuti non era una vacanza. Soffrivano freddo e fame, tenuti a "pane e acqua" come si suol dire, sfamati con un piatto di legumi al massimo.
Alcuni morivano per deperimento, malattie infettive, alle catene o, addirittura, suicidi.
Qualcuno potrebbe obbiettare che era la giusta punizione per i reati che avevano commesso, può darsi, ma la Giustizia in uno Stato civile non può coincidere con la vendetta personale, tuttavia nel XVII secolo la società a Palermo era molto diversa ed esisteva anche la pena di morte, quindi bisogna sempre contestualizzare gli eventi.
Apposta sul cornicione d'ingresso della Vicarìa vi era u'insegna con su scritta una frase in dialetto siciliano che ancora oggi si usa nel gergo comune: curri curri ca cca t'aspettu, traducendo e smorfiando verrebbe fuori qualcosa come “continua a fare quello che fai che prima o poi qui dentro (la Vicarìa) finirai”.
Il carcere di Palermo incuteva timore e il senso della Giustizia era inteso sì come lento ma impeccabile, ciò ci rimanda ad un altro detto siciliano riferito non a una giustizia terrena ma divina: “U signuri avi i peri ri chiummu”.
Sopravvivere alla Vicarìa era quasi impossibile anche per le percosse subite dalle guardie, lo testimoniano alcuni modi di dire come: "Munta la via, ch'era n'fami nun lu sai ddu sbirruni d' 'a Vicarìa; Munta la via, cu' sa si nesciu di sta nfami Vicarìa".
Ma una volta l'anno il viceré di turno compiva un atto di clemenza concedendo una sorta di amnistia per i detenuti, altre volte l'influenza di un potente poteva intercedere per la liberazione di un condannato, ma i più morivano durante il supplizio infinito della pena.
Eppure i carcerati non venivano dimenticati dai propri cari. A testimonianza di ciò vi riporto alcuni canti registrati da Giuseppe Pitré a suo tempo:
"'Mmenzu lu chianu di la Vicarìa, Cu li manuzzi mi facia signali; vitti ca cc'era la matruzza mia, e l'occhi cci facianu du' funtani, Matri, ca sulu vui pinsati a mia, Sugnu mmenzu li mali cristiani; Lu malu stari e la malancunia mi levanu la paci e lu campari".
Nonostante la condizione psicofisica vissuta dai detenuti reclusi alla Vicarìa fosse estenuante, al peggio non c'è mai fine. Nel 1840 i detenuti della Vicarìa furono trasferiti in un nuovo edificio costruito nel piano dello “ciardone”, ovvero l'attuale carcere dell'Ucciardone.
La nuova condizione dei detenuti a quanto pare era ancora peggiore rispetto alla precedente, lo deduciamo da una lamentela della moglie di un detenuto nelle nuove prigioni registrata da Giuseppe Pitré.
«Quello sì era carcere -dicevami essa- nel quale si stava come a casa nostra: io lo vedevo ogni giorno quella buon'anima di Turiddu, e non solo lo vedevo e gli parlavo, ma anche me lo baciavo e me lo stringevo al petto.
Io me ne ricorderò sempre di quei giorni che stavo con lui! Poi lo condussero in quella Vicarìa nuova laggiù, dove ora che ci son venuti questi Piemontesi, hanno proibito perfino di cantare».
L'edificio ad onor del vero fu ideato e costruito dai Borboni, ma dopo l'Unità d'Italia fu ripensato e modificato dalla nuova amministrazione "piemontese".
Ne fanno fede i detti del tempo: "Sta liggi nova di Turinu vinni, ca pr'un cuteddu si va tridici anni”.
In conclusione, vecchie o nuove le vicarìe, per vivere sereni è meglio starci alla larga.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





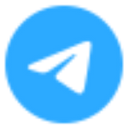


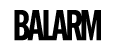

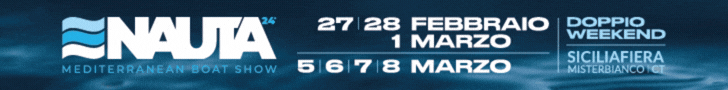



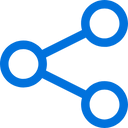
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram