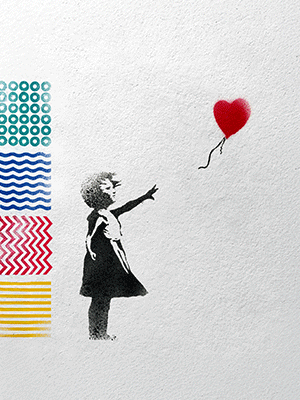STORIA E TRADIZIONI
Mangiavi uova "abbagnate no sali" e bevevi acqua di polpo: riti da (vere) osterie in Sicilia
Ci sono luoghi che raccontano storie di persone e usanze che ricordarle suscita commozione e rimpianto per un mondo che è stato, fatto di gente semplice e umile

Ciccio Ingrassia nel film "Kaos"
La storia che sto per raccontarvi riguarda le osterie che pullulavano nel quartiere di Ortigia, per la maggior parte, ma anche di alcune presenti nella “città nuova”.
Le osterie erano luoghi di ritrovo dove gli uomini si rifocillavano al termine della loro giornata lavorativa.
Qui, barcaioli, pescatori, facchini, ambulanti, contadini, insomma gente del popolo, semplice e operosa, ruotavano intorno al mondo della cantina e onoravano il quartiere cui appartenevano.
L’osteria era reclamizzata da insegne fatte da targhe di latta, poste davanti l’entrata, che portavano il nome del gestore e i simboli della specialità della bottega come fiaschi, botti, carte da gioco e tavoli con sedie se si faceva da mangiare.
All’interno, nella parte più importante del locale, si trovava il bancone in legno massiccio cui sopra era posta una lastra di marmo bianco.
Dietro al bancone vi erano le botti, in posizione comoda per l’oste che doveva solo girarsi per spillare il vino. Nel retro della porta, sui muri o sulle botti si potevano trovare oggetti scaramantici come ferri di cavallo, grattugie o immagini di santi che avevano il compito di proteggere i proprietari da eventuali maledizioni o sguardi invidiosi.
Sulla parte opposta al bancone stavano i cibi cotti, come il polpo bollito di questo si beveva pure la sua acqua di cottura a cui erano attribuiti poteri miracolosi che beneficiavano soprattutto alla vista.
D’inverno, si tenevano i legumi che venivano mangiati persino la mattina presto, quando i pescatori infreddoliti rientrati dal mare si scaldavano con queste minestre.
A non mancare mai, invece, erano i cibi piccanti e salati che venivano proposti dai proprietari dell’osteria per stimolare la sete ed aumentare la vendita di vino, come: uova sode "abbagnate no sali", olive condite, mascolino fritto, polpette di nunnata (novellame di pesce azzurro) e babbaluci (lumache), tutti questi cibi si accompagnavano con il vino.
Il vino ovviamente era locale, genuino e nostrano come il cerasuolo di Pachino, il moscato di Siracusa, lo zibibbo e il vino dell’ Etna; la qualità del vino era una cosa seria da esso infatti , dipendeva il successo dell’ osteria, alle volte si faceva la “miscela” e al vino veniva aggiunta la gassosa.
Questi luoghi raccoglievano le stesse categorie di lavoratori perciò le persone che li frequentavano erano accumunati dagli stessi argomenti e interessi qui si discuteva di affari, compravendite e alla fine della giornata lavorativa il padrone distribuiva le paghe e offriva vino e uova sode.
Alle volte, però le paghe non arrivavano a casa per intero perché si giocava a carte e il pegno di chi perdeva era il pagamento di un ulteriore bevuta. Il gioco delle carte era reclamizzato nelle insegne che mostravano soprattutto gli assi; così vi era: l’asso di Spade in via Mirabella, gestita dal signor Rizza, uomo timido ma molto ospitale; asso di denari in via Trieste.
Dei proprietari di queste osterie si racconta che erano dei bravi uomini, nobili di cuore, facevano credenza (credito) e segnavano tutto quello che gli avventori consumavano e quando si effettuavano i conti del lavoro, i primi soldi che venivano messi da parte erano per gli ostieri.
Alla fine degli anni ’50, le cantine divennero luogo di incontro per gli uomini di cultura; si potevano incontrare personalità come il Capodieci e attori di teatro come Lando Buzzanca.
Le sale perciò furono dotate di separé che separavano le diverse tipologie di avventori, sparirono le botti e comparirono le tovaglie di stoffa nei tavoli dell’élite, si cominciò a preparare mangiare su ordinazione e il cibo veniva servito ai tavoli; così pian piano tutte le osterie divennero trattorie, per poi divenire moderni ristoranti.
L’industrializzazione portò via via a una perdita di identità, iniziavano a scomparire i semplici frequentatori e si avvertivano i primi sintomi di una svolta generazionale; si andava perdendo l’autenticità di quei luoghi e tutto ben presto persino la pesca e i suoi uomini finirono per appartenere al passato e a divenire folklore.
Fuori da Ortigia vi erano altri ritrovi come il canneto di Corso Gelone, ritrovo per quelli delle segherie, tra questi si riconoscevano i picciotti che facevano le cassette, per via del muso nero, difatti per risparmiare tempo, dato che lavoravano a cottimo, prendevano una manciata di chiodi, li tenevano tra le labbra e ad uno ad uno li prelevavano per batterli sul legno.
Tutte le domeniche, dopo aver riscosso la settimana, quelli della segheria si ritrovavano al Cannetto, vestiti con l'abito della domenica e qui giocavano a carte, discutevano di lavoro, di donne e cose da uomini. Si ricorda la cantina di Di Caro, conosciuto come il "Panaro" in via Piave.
Tuttavia molti di questi luoghi per sopravvivere si trasformarono in botteghe rifornendosi di prodotti alimentari. In un modo o nell’altro queste osterie sono state snaturare diventando chi ristoranti, chi trattorie per turisti, chi addirittura dei piccoli supermercati.
Altre invece hanno chiuso cadendo nell’oblio del tempo, inghiottiti da una decadenza che in passato invece era vita con la sua meravigliosa, ormai perduta, identità.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ITINERARI E LUOGHI
Era il luogo sacro più grande di Sicilia e (ora) è in rovina: cosa resta del Tempio di Zeus
26.672 di Aurelio Sanguinetti










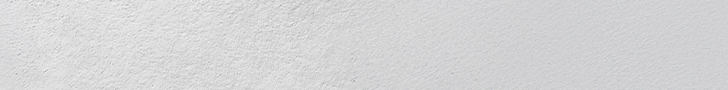




 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram