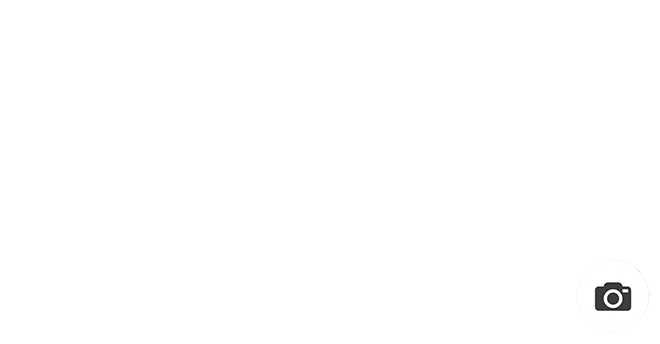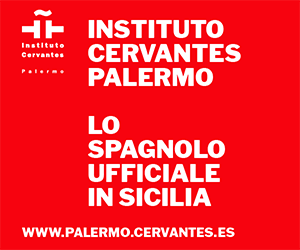ARTE E ARCHITETTURA
Tra le strade di Palermo c’è una chiesa che unisce due città: ma nessuno la visita più
Costruita da una confraternita di mercanti napoletani nel XVI secolo, tra colonne di granito, decorazioni in marmi mischi e le delicate statue di Procopio Serpotta
È la Chiesa di San Giovanni dei Napoletani, un edificio discreto e affascinante, come quei segreti che si svelano solo a chi ha occhi per coglierli.
Il suo portico trapezoidale, l’ingresso esagonale (frutto dell’ampliamento del Cassaro nel 1581) sembrano suggerire un invito gentile ma deciso: “Entra, se vuoi scoprire un altro mondo”.
E in effetti, oltre quel portale, si apre una storia fatta di incontri, di radici trapiantate e di culture che si intrecciano.
Questa chiesa fu eretta tra il 1526 e il 1617 dalla Congregazione della Nazione dei Napoletani, una comunità attiva e orgogliosa, composta in gran parte da mercanti provenienti da Cava de’ Tirreni.
Giunsero a Palermo per lavoro, ma portarono con sé ben più delle merci: tradizioni, lingua, devozioni, e il desiderio profondo di avere un punto d’appoggio, una casa spirituale che parlasse la loro stessa lingua dell’anima.
Nel 1519, affittarono un vecchio oratorio vicino alla Cala. Pagavano un’onza d’oro l’anno e un cero votivo: un gesto semplice, ma carico di simboli. Quando Carlo V ordinò la demolizione di quel primo edificio, non si scoraggiarono.
Chiesero e ottennero due magazzini e, con il sostegno economico della città, ben 400 onze, cominciarono un’impresa lunga quasi un secolo. Il risultato fu inaugurato nel 1617, come testimonianza duratura della presenza napoletana nel cuore di Palermo.
Quella chiesa divenne un ponte tra le due sponde del Regno, tra Napoli e Palermo. Non era solo un luogo di culto, ma un’ambasciata culturale, dove la fede si intrecciava con l’identità.
La comunità napoletana, spesso legata al commercio e alle arti, si inserì nel tessuto cittadino senza mai dimenticare le proprie origini. Palermo la accolse, talvolta con diffidenza, talvolta con entusiasmo, e nel tempo il dialogo si fece più profondo, più autentico.
Oggi, San Giovanni dei Napoletani è chiusa. Le sue porte restano serrate, come se stesse ancora custodendo un segreto. Ma basta fermarsi un attimo davanti a quel portico per cominciare a immaginare.
Sotto la cupoletta maiolicata che dall’esterno brilla di azzurro, s’innalza un tiburio ottagonale che dà movimento alla struttura. L’interno della chiesa colpisce per l’eleganza luminosa.
Tre navate scandite da alte colonne in marmo bianco, capitelli scolpiti con gusto rinascimentale e un trionfo di stucchi dorati che sembrano onde leggere, increspate da una luce antica.
Si dice che Procopio Serpotta, figlio del più celebre Giacomo, abbia contribuito a modellare quegli stucchi, dando forma ad allegorie di Grazia, Verginità, Fertilità e Giustizia: figure eteree che ancora oggi sembrano muoversi tra le navate.
Sulla controfacciata, due eleganti edicole marmoree del Cinquecento affiancavano, in passato, un organo realizzato dal celebre artigiano Raffaele La Valle.
Sopra di esso, una balconata accoglieva quindici piccoli quadri raffiguranti i Misteri del Rosario, firmati da Vincenzo Romano: oggi tutto scomparso, come molte delle opere che un tempo adornavano le pareti.
Sull’altare maggiore, dove un tempo troneggiava una tavola della Madonna del Rosario, fu poi posta una Sacra Famiglia.
Oggi, a vegliare sulla navata, rimane una delicata statua lignea settecentesca della Madonna col Bambino, una delle ultime presenze a mantenere vivo il cuore della chiesa.
Ai lati del presbiterio, due cappelle raccontavano altre storie: in una, l’Annunciazione; nell’altra, la SS. Trinità, entrambe opere di Giuseppe Albina, detto il Sozzo.
Le tele oggi riposano altrove, alla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, ma l’eco della loro presenza resta incisa sulle pareti.
Nella navata destra si apre la cappella di San Giovanni Battista, protetta da una balaustra in marmi mischi, con una statua gaginesca proveniente dalla chiesa originaria.
A fianco, le cappelle di San Gennaro e di Santa Rosalia, un abbraccio simbolico tra i due santi patroni delle città che questa chiesa tiene unite, Napoli e Palermo.
La chiesa, per lunghi decenni, è stata dimenticata. Negli anni ’60 venne chiusa, usata persino come magazzino per le opere d’arte del vicino Palazzo Abatellis.
Molte tele furono trasferite, disperse, dimenticate. Ma oggi, nonostante tutto, San Giovanni dei Napoletani è ancora lì. Ferita, sì. Silenziosa, sì. Ma ancora in piedi.
E se un giorno riaprirà , con le sue colonne, le sue statue, i suoi vuoti pieni di memoria, forse Palermo potrà riscoprire non solo una chiesa, ma una parte di sé.
Perché in quel piccolo edificio si conserva il respiro di una città che ha saputo accogliere l’altro, e il battito tenace di una comunità che ha lasciato tracce non solo nelle pietre, ma nel cuore.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
LE FOTO PIÚ VISTE
-
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Aree verdi nell'ex stazione Lolli: nasce un nuovo campus universitario a Palermo
di Alice Marchese















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram