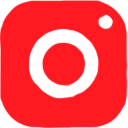STORIA E TRADIZIONI
Tra pianti disperati e bambagia nella bocca: la morte, il tabuto e i siciliani "cirimuniusi"
Il momento della morte per i siciliani è un rito dalle mille sfaccettature. Ve ne raccontiamo qualcuna rappresentativa di una tradizione forte in cui sacro e pagano si mescolano

Il "tabuto", ovvero il feretro in una foto dei primi anni'50 (Foto da CentroPolis Castelbuono, collezione famiglia Sperandeo)
Quel geniaccio di Jannacci cantava “Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale… per vedere se poi la gente piange davvero”. Ecco, quando nonna se ne andò alla prematura età di novantanove anni, papà, per assicurarsi che non avesse un ripensamento, mentre eravamo in chiesa, bussò un paio di volte nel tabuto. Pardon, quello che noi chiamiamo tabuto in realtà è il feretro... a questo ora ci arriviamo.
Abbiamo visto molti film in cui nelle culture celtiche, quando moriva qualcuno lo mettevano su una zattera, lo spingevano all’interno di un laghetto e lanciavano freccia infuocata, mentre i musicisti intonavano una qualche musica con le cornamuse. Dico io, non sarebbe più facile così?
E invece no: pompe funebri, luci, lucine, il parrino che senza picciuli messa non ne canta, autorizzazioni, certificati, e compra il loculo se non hai la cappella, e scegli il piano, e fai fare la lastra di marmo, pure la bolletta del lumino del cimitero si deve pagare.
Ma noi siciliani, e non solo, si sa, siamo così: cirimuniusi e legati alle nostre trazioni, che a volte ondeggiano tra il sacro e il pagano. Nel 1563, per esempio, fu istituita una legge che imponeva a chiunque doveva entrare in ospedale, pure per una gamba rotta, di confessarsi prima in modo che se moriva lì dentro il più era già stato fatto. E nonostante questa legge restò in vigore per tanto tempo, nessuno ci ha mai raccontato come facesse a confessarsi uno che magari si rompeva la mascella o si tranciava la lingua.
Per non parlare poi di quello che doveva subire il povero malato o moribondo dai parenti che vedevano un presagio in ogni cosa. Vediamone qualcuno: se passava un gatto nero, se una gallina aveva una défaillance di genere e gli veniva la fantasia di cantare come un gallo, se qualcuno distrattamente si metteva a scopare il pavimento di sera, se si scopriva nella casa un vano segreto fino ad allora sconosciuto, e pure se quel poveraccio del malato sentiva freddo e tirava la coperta verso di sé, questi, erano tutti presagi di morte.
Altro che cosa naturale, ci voleva fegato pure ad ammalarsi! E queste cose ce le racconta Giuseppe Pitrè. Sempre lui ci dice pure che quando il malato si avviava verso la morte succedeva questo: “la casa del malatu ‘nfirmu, che è quanto dire dell’ammalato grave, come si riempie di reliquie di santi, così diviene il convegno delle comari, le quali per tenerezza fan mille smorfie e versacci per non dar a capire al moribondo, ciò che egli spesso ha benissimo capito”.
In pratica non si poteva stare nemmeno tranquilli a casa propria, dieci minuti prima di tornarsene al Creatore. A Modica per esempio si usava vestire il morto di calze bianche e guai a mettergli le scarpe perché a quanto pare Dio in paradiso doveva avere qualche parquet delicato e non voleva che la gente si presentasse in casa sua con le scarpe.
E manco da morti si raggiungeva la serenità, dato che poi c’era l’interpretazione del volto: se si aveva un’espressione beata allora si sarebbe andati nel regno dei cieli, se invece non si aveva espressione beata allora si trattava di malamorte.
La stessa cosa la sostenne mia zia perché secondo il suo parere nonna era morta un po' arrabbiata. «Zì’,» le dissi, «nonna campò novantanove anni, e novantanove anni sempre incazzata… con che faccia doveva andarsene?». I piedi del dipartito, invece, dovevano essere sempre rivolti verso la porta d’uscita (per questo di dice “uscire con i piedi in avanti”).
Iniziava quindi il piagnisteo (su cui sicuramente faremo un articolo a parte) e se ne vedevano di tutti i colori. Vi dico solo che a Piana de’ Greci, ora Piana degli Albanesi, le donne si strappavano le trecce e le spargevano sul bistrattato cadavere che manco poteva avere il privilegio di andarsene con il vestito pulito. Se poi aveva la sfortuna di morire con la bocca aperta, per ovviare al problema, in certi posti, la riempivano con la bambagia.
La stanza in fine veniva addobbata di lumini di fortuna fatti con l’olio e le garze che venivano posti a terra: ecco perché si dice che l’olio a terra porta sfortuna. Alla fine, ma non alla fine perché ce ne sarebbe da raccontare per settimane, il tabuto poteva uscire. E qui giungiamo al perché la cassa da morto in Sicilia si chiama tabuto.
Ancora una volta ci colpano gli arabi perché la parola “tabut” in arabo significa cassa; tuttavia gli studiosi ne tracciano un'origine ancora più antica: per qualcuno è una parola aramaica, per altri è etiope, per qualcun altro ancora egiziana.
Non siamo però i soli ad utilizzarla, in Campania la cassa da morto si chiama tavuto (ma qui è una questione di cuginanza) e a Pisa (e noi a Palermo di pisani ne abbiamo avuti) si usava chiamarla tambuto. Il morto è uscito e l’articolo è finito, e come si dice dalle nostre parti: “morti a casa non ne sono rimasti mai”.
Per tornare a Jannacci che cantava: "Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale… per vedere se poi la gente piange davvero", se ci sarà veramente consentito di spiare quando sarà il nostro momento, forse andrà così "…e capire che per tutti una cosa normale, e veder di nascosto l’effetto che fa. Vengo anch’io. No, tu no!"
Abbiamo visto molti film in cui nelle culture celtiche, quando moriva qualcuno lo mettevano su una zattera, lo spingevano all’interno di un laghetto e lanciavano freccia infuocata, mentre i musicisti intonavano una qualche musica con le cornamuse. Dico io, non sarebbe più facile così?
E invece no: pompe funebri, luci, lucine, il parrino che senza picciuli messa non ne canta, autorizzazioni, certificati, e compra il loculo se non hai la cappella, e scegli il piano, e fai fare la lastra di marmo, pure la bolletta del lumino del cimitero si deve pagare.
Ma noi siciliani, e non solo, si sa, siamo così: cirimuniusi e legati alle nostre trazioni, che a volte ondeggiano tra il sacro e il pagano. Nel 1563, per esempio, fu istituita una legge che imponeva a chiunque doveva entrare in ospedale, pure per una gamba rotta, di confessarsi prima in modo che se moriva lì dentro il più era già stato fatto. E nonostante questa legge restò in vigore per tanto tempo, nessuno ci ha mai raccontato come facesse a confessarsi uno che magari si rompeva la mascella o si tranciava la lingua.
Per non parlare poi di quello che doveva subire il povero malato o moribondo dai parenti che vedevano un presagio in ogni cosa. Vediamone qualcuno: se passava un gatto nero, se una gallina aveva una défaillance di genere e gli veniva la fantasia di cantare come un gallo, se qualcuno distrattamente si metteva a scopare il pavimento di sera, se si scopriva nella casa un vano segreto fino ad allora sconosciuto, e pure se quel poveraccio del malato sentiva freddo e tirava la coperta verso di sé, questi, erano tutti presagi di morte.
Altro che cosa naturale, ci voleva fegato pure ad ammalarsi! E queste cose ce le racconta Giuseppe Pitrè. Sempre lui ci dice pure che quando il malato si avviava verso la morte succedeva questo: “la casa del malatu ‘nfirmu, che è quanto dire dell’ammalato grave, come si riempie di reliquie di santi, così diviene il convegno delle comari, le quali per tenerezza fan mille smorfie e versacci per non dar a capire al moribondo, ciò che egli spesso ha benissimo capito”.
In pratica non si poteva stare nemmeno tranquilli a casa propria, dieci minuti prima di tornarsene al Creatore. A Modica per esempio si usava vestire il morto di calze bianche e guai a mettergli le scarpe perché a quanto pare Dio in paradiso doveva avere qualche parquet delicato e non voleva che la gente si presentasse in casa sua con le scarpe.
E manco da morti si raggiungeva la serenità, dato che poi c’era l’interpretazione del volto: se si aveva un’espressione beata allora si sarebbe andati nel regno dei cieli, se invece non si aveva espressione beata allora si trattava di malamorte.
La stessa cosa la sostenne mia zia perché secondo il suo parere nonna era morta un po' arrabbiata. «Zì’,» le dissi, «nonna campò novantanove anni, e novantanove anni sempre incazzata… con che faccia doveva andarsene?». I piedi del dipartito, invece, dovevano essere sempre rivolti verso la porta d’uscita (per questo di dice “uscire con i piedi in avanti”).
Iniziava quindi il piagnisteo (su cui sicuramente faremo un articolo a parte) e se ne vedevano di tutti i colori. Vi dico solo che a Piana de’ Greci, ora Piana degli Albanesi, le donne si strappavano le trecce e le spargevano sul bistrattato cadavere che manco poteva avere il privilegio di andarsene con il vestito pulito. Se poi aveva la sfortuna di morire con la bocca aperta, per ovviare al problema, in certi posti, la riempivano con la bambagia.
La stanza in fine veniva addobbata di lumini di fortuna fatti con l’olio e le garze che venivano posti a terra: ecco perché si dice che l’olio a terra porta sfortuna. Alla fine, ma non alla fine perché ce ne sarebbe da raccontare per settimane, il tabuto poteva uscire. E qui giungiamo al perché la cassa da morto in Sicilia si chiama tabuto.
Ancora una volta ci colpano gli arabi perché la parola “tabut” in arabo significa cassa; tuttavia gli studiosi ne tracciano un'origine ancora più antica: per qualcuno è una parola aramaica, per altri è etiope, per qualcun altro ancora egiziana.
Non siamo però i soli ad utilizzarla, in Campania la cassa da morto si chiama tavuto (ma qui è una questione di cuginanza) e a Pisa (e noi a Palermo di pisani ne abbiamo avuti) si usava chiamarla tambuto. Il morto è uscito e l’articolo è finito, e come si dice dalle nostre parti: “morti a casa non ne sono rimasti mai”.
Per tornare a Jannacci che cantava: "Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale… per vedere se poi la gente piange davvero", se ci sarà veramente consentito di spiare quando sarà il nostro momento, forse andrà così "…e capire che per tutti una cosa normale, e veder di nascosto l’effetto che fa. Vengo anch’io. No, tu no!"
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





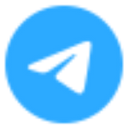


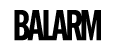





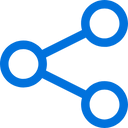
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram