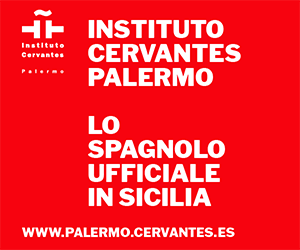Giovani isolati dai social e "persi" in alcune periferie: "Così a Palermo dilaga la violenza"
"In alcuni contesti la violenza è l'unica via per affermarsi. La repressione da sola non basta". L'intervista a Cirus Rinaldi, professore di Sociologia della devianza a Unipa

A lungo si è discusso, in piazza, al bar, nei luoghi di formazione, nei media e nei social di quelle che sono le ragioni che hanno portato ad un fenomeno tanto grande, che ormai sembra quasi essere un nuovo modello di atteggiamento, una nuova identità da affermare, inserita nelle coordinate specifiche di un modo di stare al mondo.
C’è chi attribuisce la responsabilità del fenomeno alla mancanza di forze dell’ordine, chi alla mancata presenza di presidi territoriali e di servizi nei quartieri, chi alle famiglie, chi ancora ai social e alla spettacolarizzazione dell’estetica criminale. La situazione, però, è più complessa di così, e non può che essere analizzata in termini complessivi.
Si assiste a un mutamento dell’identità dei soggetti che perpetrano azioni di violenza, che trasformano il proprio modo di stare in strada: «Sicuramente il problema è sistemico». Dice Cirus Rinaldi, professore ordinario di Sociologia del diritto e della devianza, coordinatore del Laboratorio di ricerca interdisciplinare “Corpi diritti conflitti”.
«Certo, con una cornice diversa, perché prima queste azioni, legate alla violenza di strada erano in qualche modo veicolate nella cornice mafiosa. Questi fenomeni sono ormai sganciati, si tratta di "cani sciolti". Abbiamo questo rapporto con una mafia che si è svincolata dagli affari di gestione dei pesci piccoli. Chiaro è che il commercio illegale di armi è vincolato alla criminalità organizzata, ma stiamo assistendo a risvolti del tutto nuovi».
Quello a cui ci troviamo ad assistere oggi, secondo il professore, non è un fenomeno improvviso o inatteso, ma è frutto di determiniate coordinate entro cui si formano le singole soggettività.
«Stiamo raccogliendo adesso i frutti tossici della mancanza sistemica di intervento socioeducativo all’interno delle periferie - spiega -. Sto alludendo a tutti quei mancati fenomeni di educazione informale, di intervento sociale, soprattutto sui soggetti della generazione Z, insomma, i giovani. Assistiamo a ventenni che hanno vissuto tutta l’infanzia sotto l’influenza digitale, in questo senso i social – utilizzati in termini di spettacolarizzazione – hanno soppiantato tutte le istituzioni educative manchevoli: scuole, educazione di strada, altre forme di intervento del terzo settore. Ci troviamo davanti a una gioventù che non viene valorizzata e che ritrova solo su internet modelli di intrattenimento, di costruzione della reputazione. Con una dimensione in più: il mancato intervento sul territorio».
Queste soggettività sono quindi frutto di una complessa rete di mancanze – da quelle fisiche in termini di spazi aggregativi, a quelle culturali e virtuali – che, intersecandosi tra loro «svelano queste nuove identità spettacolarizzate, che utilizzano l’unica risorsa che hanno a disposizione: il loro corpo e la violenza che possono associare a quel corpo».
La condizione di base in cui si formano queste soggettività sta proprio nella questione della periferia. Una periferia martoriata - a dire di Rinaldi - , senza servizi sociosanitari, socioassistenziali, non lascia spazio alcuno se non quello di incastrarsi in categorie specifiche: «Se sono una ragazza, l’unica attrattiva che ho è il mio capitale erotico; quindi, il mio unico ruolo può essere quello di madre. Se sono un ragazzo, non posso fare altro che diventare un masculu rispettabile, soggetto che fondamentalmente può agire utilizzando i mezzi a disposizione del suo capitale simbolico e culturale: la violenza. Violenza che oggi subisce processi sempre più accentuati di spettacolarizzazione all’interno dei media».
Secondo il professore, infatti, le azioni di Maranzano successive all’omicidio, in cui ha scelto di pubblicare un video il cui audio proveniva dal film "Il Capo dei capi" e in generale la conformazione a una estetica specifica, non sono casuali.
«L’unico tipo di reputazione che si sono costruiti è una reputazione falsata dai media, amplificata dal loro gruppo e dalla loro rete sociale, e dalla mancanza di opportunità, è l’unica cosa che possono agire. Il che non significa che questi soggetti non siano in grado di scegliere. Questo è però paradigmatico di ciò che avviene nelle periferie, nei grandi quartieri abbandonati dai servizi e dall’intervento sociale. È la stessa identica cosa che abbiamo già visto per esempio, a Caivano».
La questione della violenza diventa quindi un mezzo per affermare la propria identità specifica, il ruolo all’interno del sistema sociale. «Non c’è l’agito violento perché sei di classe inferiore, non c’è l’agito violento solo perché non sei educato. C’è un agito violento che attraversa le classi sociali, che attraversa i quartieri, ed è il modo in cui questi ragazzi - e mi riferisco soprattutto ai maschi - "diventano maschi"».
È tutta una estetica, un modello, che va letto sia alla luce delle origini del soggetto, ma anche del codice comportamentale che riproduce – a dire del professore – un tipo di mascolinità quasi di protesta che sembra essere utilizzata per reagire alle situazioni sociali di emarginazione. Non a caso, anche le altre relazioni che si tessono all’interno di quella rete hanno matrici simili.
Questo concetto gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dei processi di violenza, che vengono costantemente ostentati per trarre affermazione individuale: «È un tema che ogni volta si riproduce, soprattutto quando ci sono violenze di gruppo: risse, stupro, stupro di gruppo. Non si parla più di lotte tra cosche, di boss che sparano per avvertimento: qui ci sono dei ragazzi sciolti, dei soggetti che possiamo individuare all’interno di una sottocultura dove spesso non c’è neanche apprendistato criminale».
La risposta che viene data, in momenti del genere, è spesso ricorrere alla richiesta di maggiore sicurezza. Dinamiche che però, secondo il professore Rinaldi, sono completamente allineate con il problema di fondo. «Dopo momenti come questo, si assiste ad una deriva sicuritaria. Personalità del web e non, invocano maggiore sicurezza nelle strade, maggiore presenza di carabinieri, forze armate e polizia, non tenendo però in considerazione la cornice di mancanze che portano al problema».
La militarizzazione, da sola, non può essere una risposta. «Spesso gran parte dei nostri fondi vengono spesi in militarizzazione, ma questa cosa non farà che essere un cane che si morde la coda. Aumenteranno che cosa, le forze dell’ordine? Aumenteranno le forme di deterrenza? Questa prospettiva ideologica, ma allo stesso tempo queste culture sulle questioni pubbliche, rimarranno assolutamente indisturbate: crescerà il bisogno di questi soggetti di immaginare un contrasto con questo potere statale. Anzi, più riescono ad essere beffardi nei confronti del potere statale, tanto più diventano rispettabili».
Cosa fare allora? Serve immaginare alternative altrettanto complesse: «Auspico che il Comune di Palermo possa immaginare un tavolo tecnico dove non ci sia semplicemente l’espressione della questura e delle forze dell’ordine, ma che ci siano anche sociologi, pedagogisti, educatori. Noi avvertiamo da tantissimi anni le istituzioni politiche della loro manchevolezza rispetto agli interventi sociali».
Allo stesso modo, non sarà l’invocazione di vendetta a risolvere il problema: «Così non stiamo mai intervenendo al cuore del problema, stiamo reagendo a una maschilità aggressiva, che batte i pugni e usa le pistole, con altra maschilità aggressiva statuale, che impone il controllo. In questo modo la violenza non viene decostruita ma si alimenta in un circolo vizioso».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram