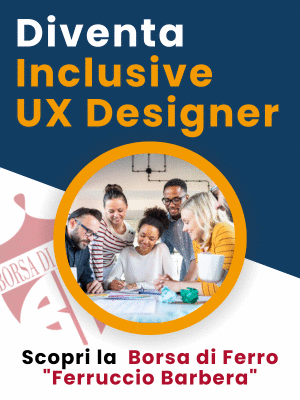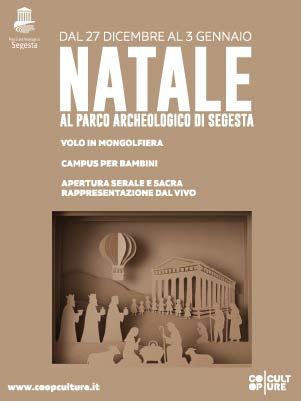Streghe, bestemmiatori, artisti: i segreti dell'Inquisizione nei sotterranei dello Steri
Testimonianza preziosa delle violenze degli Inquisitori a Palermo, le carceri di palazzo Chiaramonte ("detto Steri") sono la memoria di un passato oscuro

I sotterranei di palazzo Chiaramonte a Palermo
Forse non tutti lo sanno, ma all'interno del complesso monumentale dello Steri di Palermo è contenuta una significativa testimonianza dell'attività dell'Inquisizione in Sicilia: racchiuso all'interno delle mura storiche, infatti, c'è quello che dal 1605 al 1782 fu un carcere del Santo Uffizio in cui venivano lasciati morire o venivano rinchiusi in attesa della pena quanti venivano giudicati contrari all'ortodossia cattolica (per saperne di più leggi "Privilegi, immunità, bugie e terrore: la Santa Inquisizione come non l'avete mai vista").
Visitabile tutti i giorni, quello conservato entro i confini delle carceri è un importante pezzo di storia: i reati per i quali si veniva processati erano (ovviamente) l'eresia (eresie luterane, ebraismo) ma anche la bestemmia, la stregoneria, l'adulterio e l'usura.
I numeri: secondo il teologo e giurista Pietro Tamburini (vissuto nel Settecento) nel solo anno 1546 i quindici tribunali attivi in Sicilia condannarono 120 persone al rogo, 60 in effigie e 600 a penitenze minori.
Secondo altri storici dal 1487, anno di istituzione del Tribunale in Sicilia, al 1732 furono inviati al braccio secolare e bruciati o condannati ad altra pena di morte 201 persone, 279 rilasciati perché morti o contumaci: la Sicilia fu la regione italiana nella quale più donne vennero condotte al rogo per ordine della Santa Inquisizione.
I graffiti e i dipinti rimasti dentro le celle sono la testimonianza toccante di un'umanità annichilita, che lì ha lasciato poesie, invocazioni, carte geografiche e preghiere.
Opere d'arte, ma anche - e soprattutto - atti d'accusa verso un'ingiustizia: una memoria storica che col tempo ha rischiato più volte di andare perduta, ma che adesso rinasce, grazie all'opera di restauro curata dall'Ateneo palermitano.
Molti dei dipinti includono data e firma e consentono di risalire all'identità e alle storie dei condannati, uomini e donne che, grattando il pavimento di cotto o procurandosi colori di fortuna, hanno scelto il muro per raccontare il proprio dolore.
L'antico Palazzo di piazza Marina era un tempo sede del Tribunale del Santo Uffizio e fu lo storico Giuseppe Pitrè che nel 1906 riuscì a salvare i graffiti lasciati dai prigionieri in alcune celle segrete dello Steri: "'Sento freddo e caldo, mi ha preso la febbre terzana, mi tremano le budella, il cuore e l'anima mi diventano piccoli piccoli" (scritto da una donna accusata di stregoneria).
Ma tra le cose più importanti e inquietanti, da vedere ci sono i solchi lasciati dalle due gabbie appese alla parte alta della facciata, dove furono esposte per secoli le teste dei baroni che si erano ribellati al re Carlo V all'inizio del suo Regno (1516-1554). Quei teschi, erano rimasti lì fino all'abolizione dell'Inquisizione nel 1782 per volontà dell'illuminato vicerè Caracciolo.
Visitabile tutti i giorni, quello conservato entro i confini delle carceri è un importante pezzo di storia: i reati per i quali si veniva processati erano (ovviamente) l'eresia (eresie luterane, ebraismo) ma anche la bestemmia, la stregoneria, l'adulterio e l'usura.
I numeri: secondo il teologo e giurista Pietro Tamburini (vissuto nel Settecento) nel solo anno 1546 i quindici tribunali attivi in Sicilia condannarono 120 persone al rogo, 60 in effigie e 600 a penitenze minori.
Secondo altri storici dal 1487, anno di istituzione del Tribunale in Sicilia, al 1732 furono inviati al braccio secolare e bruciati o condannati ad altra pena di morte 201 persone, 279 rilasciati perché morti o contumaci: la Sicilia fu la regione italiana nella quale più donne vennero condotte al rogo per ordine della Santa Inquisizione.
I graffiti e i dipinti rimasti dentro le celle sono la testimonianza toccante di un'umanità annichilita, che lì ha lasciato poesie, invocazioni, carte geografiche e preghiere.
Opere d'arte, ma anche - e soprattutto - atti d'accusa verso un'ingiustizia: una memoria storica che col tempo ha rischiato più volte di andare perduta, ma che adesso rinasce, grazie all'opera di restauro curata dall'Ateneo palermitano.
Molti dei dipinti includono data e firma e consentono di risalire all'identità e alle storie dei condannati, uomini e donne che, grattando il pavimento di cotto o procurandosi colori di fortuna, hanno scelto il muro per raccontare il proprio dolore.
L'antico Palazzo di piazza Marina era un tempo sede del Tribunale del Santo Uffizio e fu lo storico Giuseppe Pitrè che nel 1906 riuscì a salvare i graffiti lasciati dai prigionieri in alcune celle segrete dello Steri: "'Sento freddo e caldo, mi ha preso la febbre terzana, mi tremano le budella, il cuore e l'anima mi diventano piccoli piccoli" (scritto da una donna accusata di stregoneria).
Ma tra le cose più importanti e inquietanti, da vedere ci sono i solchi lasciati dalle due gabbie appese alla parte alta della facciata, dove furono esposte per secoli le teste dei baroni che si erano ribellati al re Carlo V all'inizio del suo Regno (1516-1554). Quei teschi, erano rimasti lì fino all'abolizione dell'Inquisizione nel 1782 per volontà dell'illuminato vicerè Caracciolo.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ITINERARI E LUOGHI
Non te l'aspetti (sicuro): c'è una siciliana tra le città italiane in cui ci si diverte di più
41.356 di Redazione -
ITINERARI E LUOGHI
In Sicilia c'è un tunnel che ti porta nel ventre della Terra: tra giochi di luce e scenari unici
23.883 di Federica Puglisi














 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram