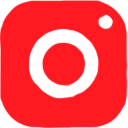A 30 anni restano in Sicilia e scelgono la terra: cosa è la "Stizza" di Angelo e Gaia
Lui agrigentino, lei perugina si ritrovano davanti a una scelta che al di là della "visione romantica" non dimentica le bollette a fine mese. La loro storia

Angelo e Gaia nella campagna di Porto Empedocle (Foto di Livio Cavaleri)
La loro proposta concilia un sistema di coltivazione, rispettoso dei cicli naturali e della biodiversità, e un’etica del lavoro e di comunità. La campagna di Angelo e Gaia ricade nel Comune di Porto Empedocle. La sua posizione è scavata nell’entroterra della provincia agrigentina, distante dal centro urbano una ventina di chilometri di trazzera. Partendo dalla città, cumuli di rifiuti costeggiano la strada. La civiltà, balorda, abbandona i suoi scarti per testimoniare sé stessa.
Superato questo limite, dove la presenza umana raggiunge la sua massima depravazione, la spazzatura si dilegua e comincia il paesaggio rurale, cominciano i vigneti secchi e gli olivi. Non è nell’opposizione città-natura, tuttavia, spiegheranno i protagonisti, che risiede il senso di questa storia.
Di fronte al cancello, ad accogliere i visitatori, abbaiano Lalla, Canegallo e, ultimo arrivato, Otto. Angelo indica la campagna circostante: «Qui intorno solo vigneti intensivi» dice «si seguono le mode agricole del momento. Sfruttano quel che posso sfruttare, poi estirpano». E aggiunge: «La coltura intensiva è la morte del paesaggio».
L’abitazione è composta da quattro locali: assi di legno in cucina indicano lavori in corso; una stufa in pietra, costruita di recente da un amico, è la soluzione per l’inverno; in bagno c’è un ingranditore, la carta da sviluppo e il resto dell’occorrente per camera oscura. «È sempre un work in progress, qui, c’è sempre qualcosa da fare» racconta Angelo. Sul retro della casa, altre due abitazioni sono in macerie, abbandonate alla fine degli anni sessanta. Più che il segno di un mondo passato, i ruderi sono il principio di qualcosa.
Stizza è il nome del progetto. Perché questo nome? «Perché no…?» risponde Angelo, invitando, nel non detto, a riflettere. La stizza è la goccia, in dialetto, che assume significato in rapporto alle altre gocce: la partecipazione e il mutualismo, spiegherà Gaia, sono alla base della loro iniziativa. C’è una lieve esitazione nel loro raccontare; forse è cautela, forse l’atteggiamento di chi condivide, ad alta voce, con gli altri, il proprio ragionamento: intendere il rapporto uomo-lavoro-natura e le relazioni umane è frutto del confronto.
Gaia, perugina, e Angelo, agrigentino, trentenni, hanno lavorato a Torino, dopo aver studiato, rispettivamente, urbanistica e sociologia. Quando il capoluogo piemontese ha smesso di offrire stimoli, Angelo è tornato nella sua provincia, in campagna. Gaia, dopo aver vissuto qualche mese a Londra, lo ha raggiunto. Spiega il ragazzo: «Questa terra mi ha dato i natali, a Gaia no, ma di fatto siamo venuti qua, entrambi, per la prima volta». Nel frattempo, una massa pelosa, che vira dal grigio al bianco al biondo, giace indistinta su di una poltrona; a osservare i tre gatti, dormienti, perenni, si penserebbe che la vicenda di Stizza sia iniziata molto tempo prima.
Angelo è cresciuto in un contesto rurale e, prima della partenza per l’università, ha acquisito familiarità con gli arnesi, tecnici e mentali, per rapportarsi con la natura. Anche i nonni di Gaia, in Umbria, lavoravano la terra. «Conservo un ricordo della campagna come luogo di socialità: grandi feste e mangiate, la cucina tradizionale, la famiglia estesa… un luogo aperto, plurale…» spiega. «Aprire la terra» è l’espressione-chiave per comprendere il loro progetto, e la terra da aprire consta di dieci ettari, coltivati a grani antichi, olive e mandorle.
Cosa vuol dire avviare un’attività agricola, anzitutto? «È una sfida con il territorio; la terra va abitata, non consumata» spiega Angelo mentre raccoglie il basilico e le ultime melanzane dall’orto. Niente diserbi chimici, pesticidi e altre sostanze esogene; sono sufficienti, nel caso della concimazione, le componenti organiche come lo stallatico e i nutrienti delle altre colture (attraverso la tecnica del sovescio, per esempio). «Rimpinzare la terra di chimico equivale a trattarla come una materia morta. Invece la terra è viva, in continua trasformazione».
Non è una questione romantica, né un sogno bucolico. A fine mese, ricorda Gaia, ci sono ancora le bollette da pagare. «A spingerci non è la ricerca di un paradiso perduto, né una civiltà contadina smarrita, non è un punto nostalgico» continua Angelo mentre affetta il pane fatto in casa, con il suo grano «abbiamo fatto delle scelte, come tutti». Una di queste scelte riguarda l’allontanamento dai «ritmi accelerati della contemporaneità».
I due ragazzi vogliono decidere del proprio tempo, senza subirlo, senza che nessuno possa imporlo o sottrarlo. Se il precariato è una condizione generazionale, un peccato originale che incombe per molti, con quell’etimo, precario, che, come ricorda Luciano Gallino, indica qualcosa ottenuto attraverso la preghiera, quindi una concessione revocabile in qualsiasi momento, i due ragazzi, all’opposto, scelgono l’incertezza per costruire qualcosa che sia loro, qualcosa che non possa essere revocato.
«È una scelta politica» allora «cambiare registro e tornare al ritmo delle stagioni». È forte il ragionamento identitario, la ricerca di «un modo diverso di mettere radici», e la volontà di restare, resistere, piccoli. Mentre vige la logica dell’agrobusiness, spiega il ragazzo, «il piccolo agricoltore è stretto dalle tenaglie della grande distribuzione. Manca uno spirito cooperativistico, mutualistico».
Angelo e Gaia, anziché ricorrere alla manodopera, scelgono il mutuo aiuto: per la raccolta, per esempio, chiamano i vicini o gli altri coltivatori, e con essi «scambiano» il proprio tempo, condividono il lavoro, senza obbedire ai ritmi del mercato. Il lavoro, così, diventa funzionale alla ricostruzione di una comunità.
«La vendemmia è una festa» ricorda Gaia, prendendo a esempio un momento collettivo, caro nella sua memoria. Il campo agricolo, in questa visione, ritorna a essere il luogo d’incontro tra le persone, come nelle sequenze dell’Albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, o nei ricordi del protagonista della Luna e i falò di Cesare Pavese, e non la sezione di una catena di montaggio. C’è una corrispondenza letteraria, incidentale, nelle intenzioni dei due ragazzi, e un manifesto, potenziale, nelle idee che stanno seminando.
Cosa accade, dopo il raccolto? Stizza vuole proporre una filiera partecipata, trasparente, in cui chi coltiva la materia prima, chi la lavora e chi consuma il prodotto possano confrontarsi, diventare consapevoli delle esigenze delle parti e quindi responsabili.
Gaia prende a esempio quanto già fatto da Cumpanatico Sud, un’associazione napoletana che dal 2016 organizza un sistema economico sostenibile e condiviso, e dai gruppi di acquisto solidali di Perugia e non solo. «È qualcosa di realistico e realizzabile, soprattutto con il grano» dice la ragazza, mentre cala il tramonto sul mandorleto.
L’utopia, cioè il luogo non ancora realizzato, in costruzione, è una comunità in cui ciascuno sa cosa mangia, come viene prodotto e quanto vale il costo e la dignità del lavoro.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





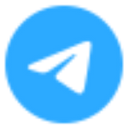


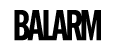





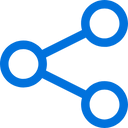
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram