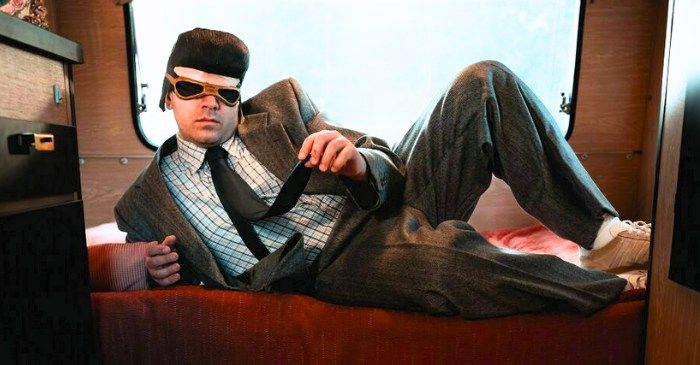È la chiesa più grande dell'Isola, un gioiello barocco: dov'è la "Versailles siciliana"
Si tratta del secondo monastero benedettino più grande d’Europa, il cui sviluppo ha accompagnato la storia degli ultimi 400 anni dell'intera Trinacria. Vi ci portiamo

Il monastero di San Nicolò a Catania
Nel cuore del centro storico di Catania, vicino al vecchio percorso della colata lavica che distrusse parte della città nel 1669, si trova uno dei tesori più importanti del barocco siciliano.
Il monastero benedettino di San Nicolò l'Arena, il secondo monastero benedettino più grande d’Europa, il cui sviluppo ha accompagnato non solo la storia degli ultimi 400 anni di Catania, ma dell’intera Sicilia, visto che i monaci possedevano grazie alle donazioni dei privati grandi feudi, sparsi nelle varie province dell’isola.
Fondato nella prima metà del Cinquecento, questo monastero è stato ricostruito e ampliato più volte, per colpa dei terremoti e delle grandi eruzioni dell’Etna, finché non assunse l’aspetto attuale fra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, quando divenne il monastero più esclusivo della Sicilia.
Ospitava monaci che provenivano dalle famiglie nobiliari catanesi e di altre importanti città e riceveva annualmente ingenti donazioni, in grado di far impallidire le tasse regolarmente imposte dallo stato ai cittadini locali.
Il suo prospetto, tipicamente barocco, sembra più l’ingresso di un palazzo reale e a dimostrare ulteriormente che i suoi ospiti non erano monaci comuni esso nasconde una scala monumentale, decorata da statue ritraenti le vite dei santi e completamente composta da marmo.
Questa scala è così imponente da indurre i visitatori – tra cui Patrick Brydone nel 1773 - a definire il monastero la Versailles siciliana.
Inserito nel 2002 nell'elenco dei beni patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell’Unesco, questo monastero è anche uno dei pochi che presenta due chiostri, uno pensato per dare il benvenuto agli ospiti, mentre quello più interno era di uso esclusivo dei monaci, che essendo quasi tutti di origine nobiliare passavano la maggior parte del tempo a meditare all’aperto, a scrivere missive diplomatiche e ad amministrare i numerosi beni che disponevano in Sicilia.
Per capire l’opulenza degli interni di questo monastero – considerato all’epoca “una reggia per religiosi facoltosi” – si possono prendere per esempio i giardini e il refettorio.
Quest’ultimo presenta un enorme affresco, realizzato da Giovanni Battista Piparo, che raffigura l’ingresso nel paradiso di San Benedetto. Al suo interno, oggi, vengono effettuate conferenze e presentazioni di libri.
Secondo Francesco De Roberto, autore del romanzo “I Vicerè”, i monaci che vivevano in questo monastero erano così viziati che solevano pranzare con un numero quasi infinito di portate, obbligando schiere di uomini a lavorare per ore nell’enormi cucine e nei magazzini, posti vicino al refettorio.
Per quanto questo autore era noto per le sue posizioni anticlericali, la sua descrizione non era molto dissimile dalla verità, considerando che all’interno del monastero lavoravano centinaia di persone.
Del monastero originale, realizzato nel Cinquecento, come già riferito è rimasto poco. L’eruzione del 1669 obbligò i monaci a scappare dall’edificio e quando tornarono nelle loro celle capirono che era necessario ricostruire buona parte del palazzo, per far fronte ai danni prodotti dal vulcano.
La colata, infatti, distrusse buona parte dei giardini esterni e coprì l’intera facciata occidentale, obbligando i monaci a far scavare un passaggio nella pietra lavica per liberare l’edificio dall’abbraccio potenzialmente mortale della roccia appena raffreddatosi. Ciò ebbe però un esito imprevisto.
La realizzazione del nuovo monastero, oltre a rendere l’edificio ancora più grande e decorato, permise a due opere sottostanti di conservarsi nel tempo.
Stiamo parlando di due ville di epoca romana (una realizzata in epoca repubblicana, mentre l’altra di epoca imperiale), che oggi sono visitabili nelle segrete del monastero, divenuto negli ultimi decenni sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, dopo un periodo di lungo abbandono.
Con l’ingresso della Sicilia al Regno d’Italia, i monaci vennero infatti scacciati dal monastero per via delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, volute dai Savoia.
Con queste leggi, il monumento visse un lungo periodo di declino, anche se venne dichiarato monumento nazionale con regio decreto nel 1869. Trasformato più volte nel corso degli anni in palestra e in un centro amministrativo, con scuole e uffici, questo monastero rivide la luce solo dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, i cui bombardamenti danneggiarono parte delle sue strutture.
Al termine dei conflitti, il monastero venne affidato infatti al comune di Catania e successivamente all’Università, in previsione di un lungo restauro, condotto dal professore e architetto Giancarlo De Carlo, che ha per esempio recuperato un’importante fontana all’interno del secondo chiostro.
Dove un tempo c’erano i magazzini, oggi si trova la biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche, mentre sotto le cucine è possibile trovare un percorso storico affascinante, che conduce i visitatori ad entrare nel ventre del monastero.
Il monastero benedettino di San Nicolò l'Arena, il secondo monastero benedettino più grande d’Europa, il cui sviluppo ha accompagnato non solo la storia degli ultimi 400 anni di Catania, ma dell’intera Sicilia, visto che i monaci possedevano grazie alle donazioni dei privati grandi feudi, sparsi nelle varie province dell’isola.
Fondato nella prima metà del Cinquecento, questo monastero è stato ricostruito e ampliato più volte, per colpa dei terremoti e delle grandi eruzioni dell’Etna, finché non assunse l’aspetto attuale fra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento, quando divenne il monastero più esclusivo della Sicilia.
Ospitava monaci che provenivano dalle famiglie nobiliari catanesi e di altre importanti città e riceveva annualmente ingenti donazioni, in grado di far impallidire le tasse regolarmente imposte dallo stato ai cittadini locali.
Il suo prospetto, tipicamente barocco, sembra più l’ingresso di un palazzo reale e a dimostrare ulteriormente che i suoi ospiti non erano monaci comuni esso nasconde una scala monumentale, decorata da statue ritraenti le vite dei santi e completamente composta da marmo.
Questa scala è così imponente da indurre i visitatori – tra cui Patrick Brydone nel 1773 - a definire il monastero la Versailles siciliana.
Inserito nel 2002 nell'elenco dei beni patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell’Unesco, questo monastero è anche uno dei pochi che presenta due chiostri, uno pensato per dare il benvenuto agli ospiti, mentre quello più interno era di uso esclusivo dei monaci, che essendo quasi tutti di origine nobiliare passavano la maggior parte del tempo a meditare all’aperto, a scrivere missive diplomatiche e ad amministrare i numerosi beni che disponevano in Sicilia.
Per capire l’opulenza degli interni di questo monastero – considerato all’epoca “una reggia per religiosi facoltosi” – si possono prendere per esempio i giardini e il refettorio.
Quest’ultimo presenta un enorme affresco, realizzato da Giovanni Battista Piparo, che raffigura l’ingresso nel paradiso di San Benedetto. Al suo interno, oggi, vengono effettuate conferenze e presentazioni di libri.
Secondo Francesco De Roberto, autore del romanzo “I Vicerè”, i monaci che vivevano in questo monastero erano così viziati che solevano pranzare con un numero quasi infinito di portate, obbligando schiere di uomini a lavorare per ore nell’enormi cucine e nei magazzini, posti vicino al refettorio.
Per quanto questo autore era noto per le sue posizioni anticlericali, la sua descrizione non era molto dissimile dalla verità, considerando che all’interno del monastero lavoravano centinaia di persone.
Del monastero originale, realizzato nel Cinquecento, come già riferito è rimasto poco. L’eruzione del 1669 obbligò i monaci a scappare dall’edificio e quando tornarono nelle loro celle capirono che era necessario ricostruire buona parte del palazzo, per far fronte ai danni prodotti dal vulcano.
La colata, infatti, distrusse buona parte dei giardini esterni e coprì l’intera facciata occidentale, obbligando i monaci a far scavare un passaggio nella pietra lavica per liberare l’edificio dall’abbraccio potenzialmente mortale della roccia appena raffreddatosi. Ciò ebbe però un esito imprevisto.
La realizzazione del nuovo monastero, oltre a rendere l’edificio ancora più grande e decorato, permise a due opere sottostanti di conservarsi nel tempo.
Stiamo parlando di due ville di epoca romana (una realizzata in epoca repubblicana, mentre l’altra di epoca imperiale), che oggi sono visitabili nelle segrete del monastero, divenuto negli ultimi decenni sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, dopo un periodo di lungo abbandono.
Con l’ingresso della Sicilia al Regno d’Italia, i monaci vennero infatti scacciati dal monastero per via delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, volute dai Savoia.
Con queste leggi, il monumento visse un lungo periodo di declino, anche se venne dichiarato monumento nazionale con regio decreto nel 1869. Trasformato più volte nel corso degli anni in palestra e in un centro amministrativo, con scuole e uffici, questo monastero rivide la luce solo dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, i cui bombardamenti danneggiarono parte delle sue strutture.
Al termine dei conflitti, il monastero venne affidato infatti al comune di Catania e successivamente all’Università, in previsione di un lungo restauro, condotto dal professore e architetto Giancarlo De Carlo, che ha per esempio recuperato un’importante fontana all’interno del secondo chiostro.
Dove un tempo c’erano i magazzini, oggi si trova la biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche, mentre sotto le cucine è possibile trovare un percorso storico affascinante, che conduce i visitatori ad entrare nel ventre del monastero.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ARTE E ARCHITETTURA
A Palermo riapre il monastero di Santa Caterina: dopo 100 anni "torna" Van Dyck
di Maria Oliveri















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram