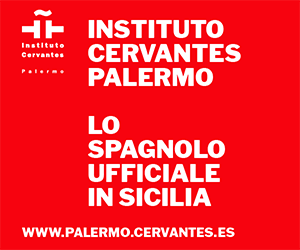Governare le fragilità pure in Sicilia: la guida di Mattarella e Garofoli alle nuove sfide
Un invito a recuperare anche la dimensione della "preparazione" istituzionale. C'è un capitolo dedicato alla sicurezza nazionale, un concetto destinato a tenere banco

La presentazione del libro di Mattarella e Garofalo
Per questo Governare le fragilità (Mondadori, 2024) di Bernardo Giorgio Mattarella e Roberto Garofoli si presenta come un testo prezioso, che invita a pensare con lucidità e misura al ruolo delle istituzioni in un’epoca complessa. Non è un libro di denuncia, ma di proposta.
Non urla, ma persuade. E lo fa con uno sguardo istituzionale limpido e profondo, senza cedere alla tentazione della semplificazione. Bernardo Giorgio Mattarella, giurista e docente, ha spiegato con chiarezza il senso di questa operazione culturale: «Abbiamo usato il termine "fragilità" per indicare alcune debolezze del nostro sistema, che riguardano fattori importanti, relativi alla nostra sicurezza o alla competitività della nostra economia, e richiedono adeguamenti istituzionali.
Riferiamo l’aggettivo "fragile" alle cose importanti, da proteggere o custodire. Una cosa fragile può rompersi, ma può anche essere rinforzata o riparata.
Il nostro non è un libro di denuncia, non vogliamo formulare critiche o accuse, ma attirare l’attenzione su alcuni problemi, che si sono formati o aggravati nel tempo e che forse abbiamo trascurato, in parte perché distratti da varie urgenze, in parte perché, in un contesto diverso da quello attuale, potevamo permetterci di non preoccuparcene troppo».
Non si tratta dunque di invocare nuove paure, ma di costruire consapevolezza. Il punto di partenza, semmai, è l’ammissione che nessun sistema – nemmeno quello italiano – è immune da vulnerabilità strutturali.
Ma è proprio questo il punto: se ben governate, le fragilità possono trasformarsi in occasioni per riformare, innovare, rafforzare. Tra queste, una emerge in modo dirompente: il calo demografico.
«È difficile individuare la più urgente tra le fragilità che richiedono attenzione – sottolinea Mattarella – anche perché spesso questi problemi sono connessi tra loro. Voglio però indicarne una, che ha molteplici aspetti: il declino demografico, che ha visto negli ultimi decenni una forte accelerazione.
In un periodo relativamente molto breve – quindici anni – il numero dei nati in Italia è diminuito di oltre un terzo. Siamo molto al di sotto del “tasso di sostituzione”, che i demografi individuano in 2,1 figli.
Nel libro ci occupiamo di questo problema con riferimento al sistema educativo: meno bambini significa meno diplomati, meno laureati, meno personale qualificato per il mondo del lavoro.
Naturalmente, il calo demografico ha anche altre conseguenze, relative per esempio alla sanità, alla previdenza e ai flussi migratori». Come si può reagire a una trasformazione così profonda?
Una via è ripensare le politiche pubbliche, che non possono più essere guidate da logiche emergenziali ma devono attrezzarsi a gestire il lungo periodo.
In questo senso, Governare le fragilità è anche un invito a recuperare la dimensione della "preparazione" istituzionale. Lo dimostra il capitolo dedicato alla sicurezza nazionale, un concetto che oggi non può più essere ristretto alla difesa armata o alla gestione dell’ordine pubblico.
Mattarella lo spiega con efficacia: «Oggi dobbiamo parlare di sicurezza in termini diversi e più ampi da come se ne parlava in passato. La sicurezza non è più soltanto la difesa dei confini e, all’interno dei confini, dell’incolumità delle persone e dei loro beni.
Le minacce più preoccupanti, che a volte si traducono già in attacchi e danni subiti, sono di altro genere, come dimostrato dagli attacchi di hacker ai siti internet di istituzioni e imprese, che possono mettere in crisi non solo la sicurezza dei dati, ma anche il funzionamento di servizi pubblici essenziali».
Si pensi, ad esempio, alla cybersicurezza, alla tutela dell’energia, alle catene di approvvigionamento delle materie prime: tutte dimensioni ormai decisive per l’autonomia e la tenuta di un paese industrializzato.
Ma serve un salto di qualità strategico, perché «di ciascuno di questi aspetti della sicurezza si occupano una o più amministrazioni. Ciò che forse non si è adeguatamente sviluppato è una strategia unitaria, che si traduca nella chiara identificazione dei rischi, delle minacce e dei possibili rimedi. Deve esserci una strategia complessiva di sicurezza nazionale, che consenta una risposta pronta e coordinata ad attacchi e minacce».
Altro terreno di riflessione – e di responsabilità – è il nesso sempre più stretto tra istituzioni ed economia. In un mondo dove la competitività è globale, anche lo Stato deve diventare "competente" e tempestivo.
«Il rapporto tra istituzioni ed economia si è molto evoluto negli ultimi decenni – osserva Mattarella – e, nonostante i processi di liberalizzazione e di privatizzazione che hanno restituito importanti settori dell’economia all’iniziativa privata, il ruolo delle istituzioni rimane importante.
Negli ultimi anni abbiamo potuto osservare fenomeni che lo hanno reso ancora più importante, tra cui due processi speculari: l’attrazione degli investimenti e il controllo degli investimenti esteri diretti».
In questo contesto, lo Stato deve agire sia come facilitatore che come garante. Da un lato, deve saper attrarre capitali e imprese, creando un contesto normativo favorevole, semplificato e affidabile. Dall’altro, deve proteggere settori strategici da acquisizioni potenzialmente ostili.
«Per entrambe le funzioni – spiega ancora Mattarella – il Governo italiano si è attrezzato con strutture recentemente costituite, che probabilmente richiedono un rafforzamento e una precisazione dei compiti svolti».
Insomma, se il libro di Mattarella e Garofoli ha un merito, è quello di non accontentarsi di diagnosticare problemi, ma di esplorare soluzioni possibili, concrete, misurate. Nessun trionfalismo, certo.
Ma nemmeno scoramento. C’è una fiducia di fondo nella capacità delle istituzioni italiane – se ben orientate – di governare con competenza e visione anche i momenti più difficili.
Perché, come suggerisce il titolo, le fragilità non sono necessariamente sinonimo di sconfitta. Possono diventare, se riconosciute e affrontate con coraggio, la base per una nuova forza.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ARTE E ARCHITETTURA
A Palermo riapre il monastero di Santa Caterina: dopo 100 anni "torna" Van Dyck
di Maria Oliveri















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram