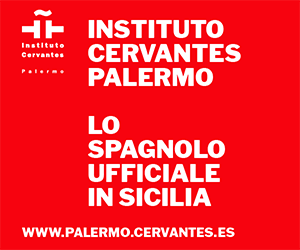STORIA E TRADIZIONI
Chi ha "rubato" il mare di Palermo: un tuffo nella storia, dal dopoguerra al Sacco
Nelle torride giornate d’estate sarebbe splendido poter godere di spiagge pulite e mare cristallino. Purtroppo bisogna prendere l’auto e spostarsi. Ecco perché

Una cartolina che ritrae il litorale di Palermo
Dagli anni Sessanta del secolo scorso in poi l’espansione urbanistica scriteriata ha infatti deturpato e degradato tutta la fascia costiera, comprese le borgate marinare.
Un’immagine tratta da una cartolina postale di Palermo del 1905, facilmente reperibile sul web, ci mostra le spumeggianti onde del mare, che riescivano un tempo quasi a lambire la monumentale Porta Felice.
Il Foro Italico, l’antica Marina, storicamente luogo di passeggiate in carrozza, musica, svaghi, incontri furtivi di aristocratiche coppie clandestine, aveva dunque un aspetto abbastanza diverso da quello che conosciamo oggi.
Perché? Bisogna fare un passo indietro, tornando con la memoria alla bollente estate del 1943, per capire cosa è successo.
Il 22 luglio di quell’anno Palermo veniva occupata dagli americani, che giunsero contemporaneamente sia da via Messina Marine che da corso Calatafimi.
Trovarono una città fantasma, stremata dai bombardamenti, ridotta a un cumulo di macerie e saccheggiata.
La maggior parte della popolazione, affamata e terrorizzata, era fuggita per mettersi in salvo, trovando riparo nelle campagne, sulle colline, persino nelle grotte di Monte Pellegrino.
I civili rimasti in città accolsero gli americani al loro ingresso a bordo di enormi jeep, con tutti gli onori, come dei veri liberatori: qualcuno storceva il naso, ma per la maggior parte della popolazione l’arrivo degli yankees equivaleva (pensavano con sollievo) alla fine dei bombardamenti.
Il porto fu immediatamente rimesso in funzione, ma il governo di occupazione fu costretto a fare i conti con la penuria di cibo e con i danni di guerra: niente acqua corrente, né elettricità.
I campi erano stati abbandonati, il poco bestiame sopravvissuto era scheletrito. Le strade e le ferrovie erano impraticabili. La città era stata quasi rasa al suolo.
Scriveva il generale Patton: “Lungo la fascia costiera ogni casa è praticamente un mucchio di rovine”. Erano stati danneggiati (o distrutti) chiese, conventi, palazzi e persino il cimitero dei Cappuccini e quello di S. Maria dei Rotoli.
Bisognava rimuovere e in tempi brevi gli immensi cumuli di macerie che invadevano vicoli e e strade, per ripristinare la viabilità.
Gli unici mezzi a disposizione erano i carretti e dunque ci sarebbero voluti mesi! L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, sotto il controllo dell’AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories, il governo militare alleato) decise che le macerie andavano sversate nel mare del Foro Italico e oggi su quei detriti sorge uno spazio verde che occupa oltre 40.000 metri quadrati! Il provvedimento in merito allo smaltimento delle macerie ha inesorabilmente modificato la linea costiera del lungomare e della città.
L’ufficio del Comune scelse quel luogo nel rispetto del famigerato Piano Giarrusso del lontano 1885 (N.d.r. il piano di risanamento che non risparmiò gli sventramenti per realizzare l’asse di Via Roma) che non solo prevedeva l’espansione della città a discapito del mare, ma che rendeva la superficie ricolmata al Foro Italico uno spazio edificabile!
Lo sversamento delle macerie fu uno dei primi affari del dopoguerra su cui il malaffare mise immediatamente le mani.
Scriveva Mario Genco: "La camorra dei carrettieri s’era impadronita del business, truffava sui quantitativi di materiali da sgomberare, minacciava gli impiegati del Genio Civile che dovevano attestare il lavoro effettuato, falsificava firme e documenti, intimoriva e costringeva al ritiro delle gare d’appalto le ditte concorrenti…
Era già cominciata l’irresistibile carriera di alcuni carrettieri fulmineamente diventati costruttori.” Gli stessi costruttori che qualche anno dopo sarebbero stati protagonisti del "Sacco di Palermo".
Il Sacco fu una delle più grandi speculazioni edilizie della storia siciliana; comportò la distruzione di palazzi storici e ville liberty, nel periodo che va dagli anni ‘60 agli anni ’70 del Novecento.
Lo scempio fu opera di tanti imprenditori, ma sotto il patrocinio di personaggi quali ad esempio Salvo Lima e Vito Ciancimino, entrambi legati a doppio filo con la criminalità mafiosa.
Nel corso di quattro anni del loro malgoverno furono rilasciate oltre 4000 licenze edilizie, mentre le banche concedevano denaro facile per cementificare la Conca d’Oro.
Di giorno si innalzavano enormi condomini in cemento armato e di notte si sversavano materiali di scarto dei cantieri nel mare di Palermo, deturpando tutta la costa, dall’Addaura fino quasi a Ficarazzi.
La spiaggia di Vergine Maria ad esempio fino agli anni ’60 non esisteva: c’erano solo scogli e l’acqua lambiva il massiccio edificio della Tonnara Bordonaro, che i bambini della borgata all’epoca chiamavano "il castello".
Il litorale è stato mortificato, utilizzato come enorme discarica e gli sfabbricidi dei palazzoni di cemento armato che venivano costruiti senza criterio hanno insabbiato l’antico porticciolo.
Per quanto riguarda la “Costa Sud”, la storia della sua mancata riqualificazione occupa più di mezzo secolo. Ci fu un tempo felice in cui sui chilometri che vanno da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari sorgevano numerosi stabilimenti balneari: i più noti erano i Bagni Italia, il Trieste-Virzi, i Bagni Petrucci, che facevano concorrenza anche alla più blasonata Mondello.
Dopo la guerra, il Piano di ricostruzione del 1947 redatto dall’Ufficio tecnico del Comune, voleva riproporre in particolare alla foce del fiume Oreto, lungo la Costa Sud, il rapporto tra il mare e la città, e al tempo stesso poneva particolare attenzione al tema del verde pubblico: le previsioni furono però disattese.
Il piano approvato nel 1962 favorì i grandi interessi privati a discapito di quelli pubblici, poiché venne applicato il sistema delle singole licenze, favorendo il sistema mafioso clientelare.
Lo strumento urbanistico del ’62 fu la maggiore causa dello scellerato consumo di suolo nel territorio palermitano. Durante gli anni del boom edilizio selvaggio sul litorale della Costa Sud venne inoltre creato “il mammellone”: una sorta di promontorio artificiale, formato di materiale di risulta.
Le mareggiate col tempo hanno eroso il mammellone, riversando nel mare rifiuti di ogni tipo, contaminando l’acqua e il terreno (è stata riscontrata la presenza di piombo, arsenico, stagno).
Palermo dunque è oggi una città a forte vocazione turistica ma che ha perso ogni rapporto con il suo mare e con la sua identità marinara. Il mare non è accessibile, è sporco, inquinato, non balneabile… e - nonostante tante promesse - un processo serio di riqualificazione non è mai stato avviato: che peccato! Un’altra grande occasione mancata…
Fonti: D. Michelon, Palermo al tempo dei bombardamenti M. Leone, F. Lo Piccolo, F. Schilleci, Il paesaggio agricolo nella Conca d’Oro di Palermo
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram