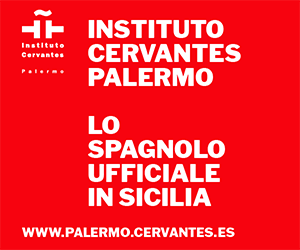ITINERARI E LUOGHI
Ci passi ma non sai che custodiscono tesori: in giro tra le "città invisibili" della Sicilia
Scoprire queste città è un invito a cambiare punto di vista: a rallentare e a immaginare la vita che scorreva dove oggi passano cavi, tubi e metropolitane

L'Area archeologica di Solunto vista dall'alto (foto dal sito web della Regione Siciliana)
Nel Palermitano, il sottosuolo parla greco. Non per modo di dire. Qui infatti c'è la necropoli greca più grande della Sicilia, scoperta per caso durante i lavori di raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina: oltre novemila tombe, databili tra la fine del VII e il V secolo a.C., appartenenti all’antica Himera.
Un ritrovamento che ha lasciato a bocca aperta persino gli archeologi più navigati: è il più grande complesso funerario greco rinvenuto in Italia negli ultimi trent’anni. Le tombe, spesso accompagnate da oggetti rituali, ceramiche, armi e piccoli gioielli, raccontano un mondo perduto fatto di guerrieri, artigiani e donne con in mano il filo delle storie familiari.
Alcuni di questi reperti sono ora visibili nella mostra “Himera. Viaggio tra archeologia e storia” allestita in un luogo insolito quanto simbolico: la Sala Reale della stazione di Palermo.
Un modo elegante per dire che il passato, ogni tanto, prende il treno e ci viene incontro.
Ma Palermo sotterranea non è solo grecità. Scavando sotto via Mariano Stabile, tra hotel e chiese protestanti, sono affiorate strutture idrauliche sette-ottocentesche: canalette in calcarenite, archi a tutto sesto, pozzi di scolo perfettamente conservati. E più sotto ancora, tracce islamiche, bizantine, romane. È come se la città, invece di consumarsi, si fosse accumulata come una lasagna di pietra e memoria. Come scrive Pietro Todaro nel suo "Palermo sotterranea": «Ogni strato è una storia, ogni umidità una voce».
Anche fuori città il sottosuolo racconta. A Solunto, sul promontorio che guarda il mare di Santa Flavia, sono tornate alla luce 220 tombe puniche scavate nella roccia, con le loro tanagrine – quelle figurine delicate in terracotta che sembrano sussurrare segreti al passato.
Ad Alia, nelle Grotte della Gurfa, si entra in un mondo che sfida le categorie: ipogei che sembrano usciti dal mondo miceneo, camere a cupola che evocano più un rituale misterico che un uso pratico. Dicono che vi sia stato sepolto Minosse in persona. Sarà vero? Chissà. Ma a volte, più della verità, conta la suggestione.
Siracusa non è da meno, anzi. Se Palermo è la città stratificata, Siracusa è quella scavata.
Sotto la chiesa di San Giovanni alle Catacombe si apre una delle reti sotterranee più imponenti del mondo romano cristiano: gallerie larghe e ordinate, ispirate al castrum militare, con rotonde che un tempo furono cisterne e oggi raccontano il battesimo della fede. Qui venne scoperto nel 1872 il celebre sarcofago di Adelfia, oggi conservato al Museo Paolo Orsi: un tripudio di figure scolpite nella pietra, una Bibbia scolpita prima che la carta la potesse raccontare.
Ma il cuore segreto di Siracusa pulsa sotto Ortigia.
L’ipogeo di Piazza Duomo, riaperto nel 2019, è un labirinto d’acqua, pietra e guerra. Fu progettato nel Seicento come cisterna, poi adattato come rifugio antiaereo nella Seconda guerra mondiale. In un colpo solo, si cammina tra i secoli e si respira la paura e la resilienza dei siracusani. Scendendo di pochi metri, si entra in un’altra epoca – un salto temporale senza bisogno di effetti speciali.
Più a nord, nel quartiere di Santa Panagia, una necropoli greca è venuta alla luce durante lavori pubblici: trecento tombe con corredi votivi, una porta monumentale, tratti delle mura di Dionisio I. Sotto l’asfalto, la Siracusa del V secolo a.C. ci osserva paziente. E anche sotto la stazione ferroviaria, pare ci sia un tratto di via romana larga dieci metri, ancora lì, nascosta come un’arteria dimenticata.
Scoprire queste città sotterranee non è solo un esercizio da archeologi. È un invito a cambiare punto di vista. A rallentare. A immaginare la vita che scorreva dove oggi passano i cavi, i tubi, le metropolitane.
Le "città invisibili", come scriveva Italo Calvino, sono fatte anche di ciò che non si vede. E se Palermo e Siracusa hanno un’anima, non è (solo) in quello che mostrano, ma in quello che custodiscono nel buio, in silenzio, aspettando che qualcuno si decida a scavare – con le mani, o con lo sguardo.
A volte, è proprio lo sguardo distratto di un viandante o lo scavo di un cantiere a risvegliare antiche presenze.
Ne è un esempio la Necropoli punica di Palermo, situata nella parte occidentale della città (zona Caserma Tukory), dove sono stati ritrovati numerosi sepolcri dal periodo punico-romano.
Inoltre, all’interno del complesso di Piazza della Vittoria, che include parti di Villa Bonanno, sono stati scoperti edifici romani con mosaici raffiguranti le Stagioni e Orfeo, risalenti tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C.
Infine, in occasione degli scavi nella rete fognaria di via Roma, esistono notizie su ritrovamenti come canali, manufatti medievali e pavimentazioni in cotto con stratigrafie significative, ma senza ambienti termali o mosaici.
A Siracusa, nel frattempo, l’area dell’ex caserma Abela, trasformata in spazio universitario, ha restituito negli ultimi anni frammenti preziosi della città romana tardoimperiale: tratti di mura, cisterne e un suggestivo ambiente ipogeico con affreschi in ocra rossa, forse parte di un luogo di culto domestico. Uno spazio intimo, sotterraneo, nascosto sotto un edificio militare, oggi restituito al sapere.
Sono questi i luoghi che ci insegnano una cosa semplice e potente: che la storia non è solo un racconto del passato, ma un tessuto vivo, ancora capace di parlare, di sorprenderci, di metterci davanti allo specchio. Basta saperla ascoltare. O, appunto, guardare sotto i nostri piedi.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram