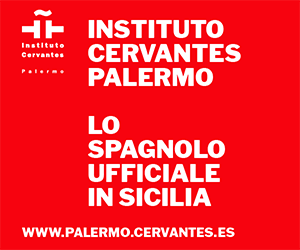STORIA E TRADIZIONI
In Sicilia c'è un proverbio per ogni pianta (magica): i "talismani" che non ti aspetti
Nella cultura siciliana le piante non sono mai state semplici elementi della natura, ma veri e propri talismani. Alcune incarnano poteri ambivalenti, ecco quali

Questo intreccio tra botanica e credenze popolari affonda le radici in un passato dove mito, religione e pratiche ancestrali si fondono, creando un patrimonio unico di simboli e rituali.
Alcune piante incarnano poteri ambivalenti, divisi tra benedizione e maledizione. L’aglio, ad esempio, era considerato un guardiano contro spiriti maligni e malattie: si poneva sotto il letto delle partorienti per scacciare influssi negativi, sfruttando allo stesso tempo le sue proprietà antisettiche.
La mandragora, con radici antropomorfe, era venerata come talismano afrodisiaco e anestetico, ma anche temuta per la sua tossicità.
Altre, come il prezzemolo, portavano sfortuna se coltivate in casa, come recita il proverbio "Cu chianta pitrusinu chianta guai". Al contrario, la pigna, simbolo di fertilità, adornava case e chiese, augurio di prosperità.
Ma vediamo alcuni proverbi siciliani sugli svariati poteri benefici e malefici della piante.
A casa unni cc’è u basilicu, u diavulu nun trasi” (Dove c’è il basilico, il diavolo non entra). Diffuso soprattutto nel Palermitano e nell’agro nisseno, questo proverbio celebra il basilico come pianta apotropaica.
Le sue foglie profumate, spesso poste sui davanzali o alle entrate delle case, si credeva tenessero lontani gli spiriti maligni e le malattie. Non a caso, era usato anche nelle pratiche curative contadine, come impacco per febbre e punture d’insetto.
"Ruta e focu, scantu di ogni locu" (Ruta e fuoco, protezione da ogni luogo). La ruta, pianta dal sapore amaro e dall’odore intenso, era considerata un talismano contro il malocchio, specialmente nelle campagne trapanesi. Si appendevano mazzetti alle porte delle stalle per proteggere il bestiame, mentre le donne la portavano addosso in piccoli sacchetti di lino.
La sua associazione col fuoco deriva dall’uso di bruciarne le foglie durante rituali di purificazione.
"L’agghiu è riccu, e nun voli munnizzu" (L’aglio è ricco e non vuole concime). Nell’area agrigentina e nel siracusano, l’aglio era simbolo di forza e resistenza, sia fisica che spirituale.
Coltivato persino nei cortili più aridi, si riteneva scacciasse le influenze negative. Le collane d’aglio erano appese alle culle dei neonati per allontanare le “fattucchiere”, mentre i contadini lo masticavano prima del lavoro nei campi come tonico.
“A pigna ‘n casa, ricchezza nni vasa” (La pigna in casa, ricchezza abbonda) Le pigne decorative, intrecciate in corone o appese alle travi, erano augurio di fertilità e abbondanza, specialmente nel ragusano e nel catanese. Usate nelle chiese durante le feste patronali, simboleggiavano la connessione tra cielo e terra, oltre a ricordare la forma del grappolo d’uva, emblema di prosperità.
“Cu chianta ficu a portu, si senti lu suttu du mortu” (Chi pianta un fico vicino al portone, sente il respiro della morte). Nel catanese e nel messinese, si evitava di piantare fichi vicino alle abitazioni.
Si credeva che le loro radici attirassero le anime inquiete, mentre l’ombra densa dei rami fosse rifugio di spiriti maligni. Un altro detto, “Ficu a muro, mal’auguriu” (Fico al muro, mal augurio), sottolinea il timore che la pianta causasse crolli o litigi familiari.
“Nuci a curti, morti sùbbitu” (Noce nel cortile, morte immediata). Diffuso nelle zone interne, come l’ennese e il nisseno, riflette la credenza che il noce, soprattutto se isolato, fosse albero "sanguinario".
La sua linfa scura e il fogliame fitto erano associati al lutto, tanto che si evitava di dormirvi sotto per non cadere in un sonno eterno. Le noci stesse, però, erano usate in pozioni curative, dimostrando il dualismo tipico del folklore.
"A donna ca porta rosi ‘n testa, porta spini ‘n cori” (La donna che porta rose in testa, ha spine nel cuore). Nel siracusano, regalare rose rosse era gesto ambiguo: simbolo d’amore, ma anche di tradimento se offerte in numero dispari.
Le spine rimandavano alla sofferenza amorosa, mentre le rose bianche, legate al culto mariano, erano invece benauguranti. Alcune piante incarnano ambivalenze culturali, come l’aloe (“Àvia ‘n casa, saluti e risa” – Aloe in casa, salute e risate), diffusa nel trapanese e nel messinese come protettore domestico.
Se però fioriva improvvisamente, si trasformava in presagio di lutti (“Quannu l’àvia si ni scogghia, ‘n casa un’anima si nni cogghia”).
Anche il limone aveva doppia valenza: “Si l’aranciu porta unniuri, u limuni porta duluri” (Se l’arancio dona onore, il limone porta dolore), tipico delle coltivazioni siracusane.
I fiori d’arancio erano usati nei matrimoni, mentre il limone, associato all’acidità della vita, andava maneggiato con cautela. Questi proverbi, oggi studiati anche da antropologi e linguisti, raccontano una Sicilia in cui ogni foglia aveva un linguaggio segreto, ogni giardino una mappa simbolica.
Pur stemperandosi con la modernità, restano tracce di questa eredità: nei mercati di Ballarò si vendono ancora mazzetti di ruta, mentre nelle campagne di Modica le nonne sussurrano “megghiu na fogghia di mèntula ca centu duchi di mèdicu” (meglio una foglia di menta che cento dolci del medico), a ricordare che la saggezza verde sopravvive, tra scienza e magia.
Il 24 giugno, vigilia della festa di San Giovanni, la Sicilia si trasformava in un laboratorio di incantesimi. Erbe come la verbena (simbolo di pace) e l’iperico (noto come "erba scaccia-diavoli") venivano raccolte all’alba, quando la rugiada era carica di poteri curativi. Queste piante, essiccate in mazzi, proteggevano le case dal malocchio o diventavano ingredienti per pozioni.
Si credeva che in questa notte i confini tra il visibile e l’invisibile si assottigliassero, permettendo alle erbe di assorbire energie soprannaturali. Sagge donne depositarie di saperi erboristici, univano conoscenze empiriche a gesti simbolici.
Preparavano unguenti con ruta o artemisia, ma anche decotti per combattere vermi intestinali, recitando formule durante la Settimana Santa. La loro arte, spesso tramandata oralmente, mescolava rimedi pratici a rituali: ad esempio, lavare le case con acqua e sale per purificarle, o usare l’olio d’iperico, raccolto nella notte magica, per curare ferite.
L’invidia e il malocchio erano temuti come forze tangibili. Per neutralizzarli, si ricorreva a rituali complessi: versare acqua e olio in un piatto osservando se le gocce si espandevano (segno della presenza del male), o spargere sale agli angoli delle case recitando preghiere.
A Caltabellotta, si lanciava sale alle spalle del presunto "iettatore" mentre si pronunciava uno scongiuro. Anche le fave diventavano strumenti divinatori: tre sotto il cuscino di una ragazza potevano rivelare il destino matrimoniale. Ogni fase della vita era accompagnata da piante e gesti simbolici.
Le donne incinte interpretavano il sesso del nascituro attraverso il latte versato in acqua, mentre la culla del neonato doveva essere preparata di mercoledì, giorno propizio. I nati di venerdì, considerati immuni alle stregonerie, erano ritenuti dotati di poteri intuitivi.
La Trinacria, emblema siciliano con tre gambe e il volto di Medusa, incarnava protezione e rinascita, intrecciando serpenti (rinnovamento) e spighe (abbondanza).
L’Inquisizione spagnola, attiva in Sicilia tra il XVI e il XVIII secolo, esercitò un profondo controllo sulle pratiche medico-magiche tradizionali, colpendo in particolare le guaritrici.
l’Inquisizione limitò la diffusione di pratiche erboristiche, malgrado la persecuzione, queste pratiche sopravvissero in forma privata o rituale, tramandate oralmente e celate dietro atti religiosi.
I registri dell’Inquisizione offrono anche una preziosa finestra sulla cultura materiale siciliana del tempo, inclusi gli oggetti usati dalle guaritrici nelle loro pratiche quotidiane.
Il lungo dominio inquisitoriale, pur soffocando ufficialmente queste conoscenze, non riuscì a cancellare il sapere delle donne, che continuò a vivere nei riti familiari e nelle credenze popolari.
Oggi, queste tradizioni sopravvivono nelle feste popolari, nei gesti scaramantici o nelle pratiche di ecoturismo che valorizzano le erbe spontanee. Il legame tra piante e magia in Sicilia non è folklore, ma una testimonianza vivente di come l’uomo abbia cercato di decifrare il mondo attraverso la natura.
Un patrimonio fragile, minacciato dalla modernità, che invita a riscoprire il dialogo tra scienza e simbolo, tra terra e sacro.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|













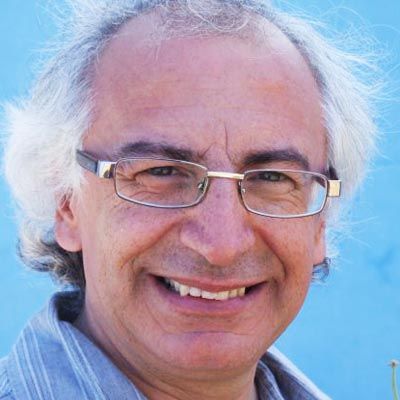

 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram