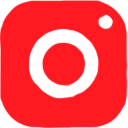CINEMA E TV
Il muro, una barriera di odio tra civiltà e barbarie
Il muro (Mur)
Francia/Israele 2004
Di Simone Bitton
Un muro variopinto scorre davanti allo spettatore, ornato di graffiti che evocano Matisse e Haring: “Il muro” di Simone Bitton comincia così, con immagini quasi briose e rassicuranti. Ma non tarda a imporre il maestoso grigiore della barriera che separa Israele e Cisgiordania. La macchina da presa si sposta poi in un cantiere, dove alcuni arabi – paradossalmente - innalzano il muro che li imprigionerà, mentre il paesaggio si copre gradualmente di lastroni di cemento. La Bitton, israeliana di origine marocchina, raccoglie testimonianze su come viene vissuto quotidianamente il muro da entrambe le popolazioni e intervista anche il Generale Amos Yaron, personaggio vicino ad Ariel Sharon e ideatore dell’obsoleta misura. Le opinioni si inseriscono in uno spettro che va dalla rassegnazione allo sdegno: ma al di là della classificazione delle barriere che declinano quel blocco di cemento in eufemismi burocratici come “barriera difensiva” o “linea-ostacolo”, tutti (tranne il generale, ovviamente) si rendono conto che si tratta di un monumento brutto, costoso e inutile. Soprattutto perché il muro si può scavalcare, non solo con le armi ma con le proprie gambe, per riconquistare quelle libertà elementari che cemento e filo spinato negano prepotentemente. Queste recinzioni, tuttavia, sono soltanto il correlativo oggettivo di barriere più antiche ed evanescenti: lingua, religione, banali abitudini.
Le differenze si traducono spesso in conflitti (anziché in risorse, come ci dice un altro film al momento in sala, “Kinsey”) e la guerra è, come sempre, un grande affare: il muro ha infatti creato una vera e propria industria della separazione, che vive di questi 640 km di cemento, filo spinato e torrette di controllo superaccessoriate (c’è anche la versione con aria condizionata). La vita alienata degli intervistati è un messaggio fortissimo che vuole reagire a questa militarizzazione del quotidiano e al silenzio che la circonda. Una situazione che costringe a vivere nel timore esasperato che rende ipersensibili verso bus, giubbini e qualsiasi altra cosa considerata innocua ad occhi occidentali. Dei bambini israeliani scappano dinanzi alla regista per paura della macchina da presa: “Ci sembrava un’arma”, affermano poi, rassicurati. Un’arma che si ostina a mostrare armi più pericolose, un’arma che sceglie di vivere realmente quel che si vuole raccontare, anziché accontentarsi di una sicurezza embedded. Perché quello che si allunga, al cospetto dell’indifferenza occidentale, è sì un novello muro di Berlino, ma anche un nuovo muro del pianto. E la storia non si può scrivere lungo i muri.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|





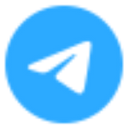


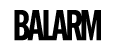




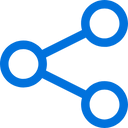
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram