Nell'800 in Sicilia ti sposavi in bianco solo in una città: com'erano gli abiti nell'Isola
L’abito nuziale rappresentava un vero e proprio linguaggio tessile, attraverso il quale si esprimevano identità sociale, valori culturali e speranze per il futuro

Fino a tutto l’Ottocento in Sicilia non esisteva ancora la consuetudine dell’abito nuziale bianco universale; al contrario, la sposa vestiva secondo le usanze del proprio paese di origine.
Ad esempio, a Terrasini (PA) la sposa indossava un abito celeste, a Milazzo (ME) un giubbino di raso con maniche ampie abbinato a una gonna azzurra guarnita di nastri, velo bianco fiorato sul capo, grembiule candido e gioielli d’oro e corallo.
Nelle zone rurali del Siracusano le spose portavano in autunno veste di lana azzurra, con crocetta d’oro appesa a una collana di corallo, fazzoletto di seta sul capo e un mantellino di saio azzurro sulle spalle.
Invece a Palermo le spose borghesi avevano già adottato il vestito bianco con velo e ghirlanda sul capo, in linea con la moda europea del tempo.
Questo dualismo urbano-rurale è fondamentale per comprendere le differenze nell’abito nuziale siciliano ottocentesco.
Nella seconda metà dell’Ottocento, soprattutto nelle città come Palermo, Catania o Messina, la borghesia cominciò ad allinearsi sempre più ai canoni della moda internazionale.
Le influenze francesi e vittoriane si fecero strada nei guardaroba nuziali: comparvero così i vestiti bianchi in raso o seta, ispirati all’abito della regina Vittoria che nel 1840 aveva lanciato la moda della sposa in bianco.
Le spose borghesi più all’avanguardia abbandonarono le vivaci combinazioni di colore della tradizione locale per abbracciare il candore simbolico del bianco, percepito come colore della purezza virginale e della nuova eleganza borghese.
A Palermo già verso la fine del secolo “il vestito della sposa era bianco con un velo sul capo trattenuto da una ghirlanda”, in perfetto stile ottocentesco europeo. Questo look prevedeva abiti confezionati su misura nelle sartorie alla moda della capitale isolana.
Un celebre esempio descritto dal folklorista Pitrè è il “vestito nuziale della ricca burgisa”, la sposa appartenente alla borghesia rurale benestante. Esso si componeva di diversi elementi sfarzosi: innanzitutto la baschina, un corpetto rigido (busto) con falde di seta rossa a fiori multicolori, aperto sul davanti e allacciato con nastri di seta blu.
Sotto la baschina si intravedeva la cuvertina, un panno di velo bianco utilizzato per coprire il décolleté lasciato scoperto dal corpetto, che veniva fissato incrociando i lacci di seta sul petto. Al di sotto si indossava poi il fadillinu, una gonna sopragonna corta di raso rosso ornata sull’orlo inferiore da una fettuccia color celeste.
La gonna era piuttosto corta per i canoni dell’epoca – arrivava appena sopra i malleoli – lasciando in bella vista un paio di calze azzurre (cerulee) di cotone. Completava la parte inferiore un elegante grembiule: il fadali, realizzato in leggero velo d’India bianco (una stoffa fine di cotone), molto increspato e decorato con trine, legato in vita da un nastro candido.
Non mancavano infine gli accessori coordinati: la sposa borghese tradizionale portava scarpine di raso bianco a fiorellini azzurri con rosette di nastro rosso sulla punta, rigorosamente senza tacco.
Sulle spalle indossava spesso una mantellina di seta gialla a fiori multicolori, a mo’ di corto soprabito per le uscite. I capelli, raccolti con cura, venivano adornati con la spatuzza d’argento, un fermaglio prezioso a forma di piccola spada, simbolo augurale e di protezione ancora in uso nell’Ottocento.
Completavano il quadro ricchi gioielli: vistosi orecchini pendenti in filigrana d’oro (chiamati fiuccagghi in dialetto), numerosi anelli alle dita e soprattutto più giri di collane di corallo rosso e ambra portate al collo.
Solo nei primi del ’900 il velo diventò un accessorio irrinunciabile anche in Sicilia: solitamente di tulle o di velo leggero ricamato, scendeva ad avvolgere la sposa ed era fermato da una corona di fiori d’arancio, simbolo augurale di fertilità mutuato dalle usanze nobiliari europee.
L’abito nuziale nella Sicilia dell’Ottocento rappresentava un vero e proprio linguaggio tessile, attraverso il quale si esprimevano identità sociale, valori culturali e speranze per il futuro.
Ad esempio, a Terrasini (PA) la sposa indossava un abito celeste, a Milazzo (ME) un giubbino di raso con maniche ampie abbinato a una gonna azzurra guarnita di nastri, velo bianco fiorato sul capo, grembiule candido e gioielli d’oro e corallo.
Nelle zone rurali del Siracusano le spose portavano in autunno veste di lana azzurra, con crocetta d’oro appesa a una collana di corallo, fazzoletto di seta sul capo e un mantellino di saio azzurro sulle spalle.
Invece a Palermo le spose borghesi avevano già adottato il vestito bianco con velo e ghirlanda sul capo, in linea con la moda europea del tempo.
Questo dualismo urbano-rurale è fondamentale per comprendere le differenze nell’abito nuziale siciliano ottocentesco.
Nella seconda metà dell’Ottocento, soprattutto nelle città come Palermo, Catania o Messina, la borghesia cominciò ad allinearsi sempre più ai canoni della moda internazionale.
Le influenze francesi e vittoriane si fecero strada nei guardaroba nuziali: comparvero così i vestiti bianchi in raso o seta, ispirati all’abito della regina Vittoria che nel 1840 aveva lanciato la moda della sposa in bianco.
Le spose borghesi più all’avanguardia abbandonarono le vivaci combinazioni di colore della tradizione locale per abbracciare il candore simbolico del bianco, percepito come colore della purezza virginale e della nuova eleganza borghese.
A Palermo già verso la fine del secolo “il vestito della sposa era bianco con un velo sul capo trattenuto da una ghirlanda”, in perfetto stile ottocentesco europeo. Questo look prevedeva abiti confezionati su misura nelle sartorie alla moda della capitale isolana.
Un celebre esempio descritto dal folklorista Pitrè è il “vestito nuziale della ricca burgisa”, la sposa appartenente alla borghesia rurale benestante. Esso si componeva di diversi elementi sfarzosi: innanzitutto la baschina, un corpetto rigido (busto) con falde di seta rossa a fiori multicolori, aperto sul davanti e allacciato con nastri di seta blu.
Sotto la baschina si intravedeva la cuvertina, un panno di velo bianco utilizzato per coprire il décolleté lasciato scoperto dal corpetto, che veniva fissato incrociando i lacci di seta sul petto. Al di sotto si indossava poi il fadillinu, una gonna sopragonna corta di raso rosso ornata sull’orlo inferiore da una fettuccia color celeste.
La gonna era piuttosto corta per i canoni dell’epoca – arrivava appena sopra i malleoli – lasciando in bella vista un paio di calze azzurre (cerulee) di cotone. Completava la parte inferiore un elegante grembiule: il fadali, realizzato in leggero velo d’India bianco (una stoffa fine di cotone), molto increspato e decorato con trine, legato in vita da un nastro candido.
Non mancavano infine gli accessori coordinati: la sposa borghese tradizionale portava scarpine di raso bianco a fiorellini azzurri con rosette di nastro rosso sulla punta, rigorosamente senza tacco.
Sulle spalle indossava spesso una mantellina di seta gialla a fiori multicolori, a mo’ di corto soprabito per le uscite. I capelli, raccolti con cura, venivano adornati con la spatuzza d’argento, un fermaglio prezioso a forma di piccola spada, simbolo augurale e di protezione ancora in uso nell’Ottocento.
Completavano il quadro ricchi gioielli: vistosi orecchini pendenti in filigrana d’oro (chiamati fiuccagghi in dialetto), numerosi anelli alle dita e soprattutto più giri di collane di corallo rosso e ambra portate al collo.
Solo nei primi del ’900 il velo diventò un accessorio irrinunciabile anche in Sicilia: solitamente di tulle o di velo leggero ricamato, scendeva ad avvolgere la sposa ed era fermato da una corona di fiori d’arancio, simbolo augurale di fertilità mutuato dalle usanze nobiliari europee.
L’abito nuziale nella Sicilia dell’Ottocento rappresentava un vero e proprio linguaggio tessile, attraverso il quale si esprimevano identità sociale, valori culturali e speranze per il futuro.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|













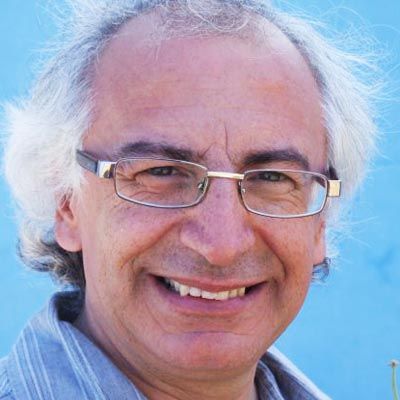

 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram















