Oltre gli Archi del borgo in Sicilia: respiri aria pura e mangi "i panuzzi di San Brasi"
A 416 metri di altezza, le colline appiattiscono un territorio ricco di colture e di fede. Qui la vita scorre lenta lontana dall’incessante lavoro frenetico delle città

San Biagio Platani in Sicilia
"Tra scinnuti e acchianati, curvi nichi e ranni", il fascino colorato coltiva nuove speranze. Improvvisamente, senza preavviso alcuno, lo sguardo volge a nord. È San Biagio. La zona periferica racconta di una comunità che prova a misurarsi con il cambiamento imposto dal progresso. Lo spopolamento in atto colpisce tutti, nessuno escluso. A 416 metri di altezza, le colline appiattiscono un territorio ricco di colture. L’aria è pura, lontana dall’incessante lavoro frenetico delle grandi città. Il borgo si tinge “a festa".
Gli Archi - di cui tanto si parla - è una tradizione saputa e risaputa. Un evento smisurato, che lascia poco spazio ai fronzoli. Secoli di passione da invidiare. Siamo gelosi di così tanta capacità. Corso Umberto I (un tempo bloccata dalla piccola chiesa del Purgatorio - successivamente demolita) splende agli occhi dei turisti e semplici curiosi dell’ultima ora. I contenuti storici vanno letti in ottica socio- religiosa. Hanno una lunga storia, meritano di essere valutati durante la visita. Noi, imperterriti come sempre, vogliamo scindere i due momenti.
Se della prima si è parlato fin troppo, per un attimo lasciamo l’argomento incustodito e andiamo oltre… la normalità. San Biagio riflette come una stella nuda, con un percorso a sé. La fede tanto vituperata altrove, trova terreno fertile nell’animo e meno nella quantità di edifici presenti. Risalta la Chiesa Madre (ubicata tra Corso Umberto I e Viale della Vittoria). Eretta nel 1635 (non dimenticatevi di questa data), rappresenta il luogo di culto principale.
Un tempo era a unica navata, mentre nei secoli - dopo numerosi interventi di ristrutturazione - ha subito profondi cambiamenti. La bella facciata ottocentesca venne demolita nel 1952 per innalzare l’attuale prospetto. La pietra viva è geniale e condivisa. Risulta suddivisa in due ordini da una cornice di marcapiano. I due ordini perfezionano l’entrata con ingresso principale e la torre campanaria con orologio. Le navate sono (adesso) tre, arricchite da capolavori di Padre Fedele di San Biagio. Opere come il Miracolo di San Biagio, il Martirio di San Fedele e [...]. Spinti dallo spirito di osservazione, andiamo oltre. Entriamo nell’angolo dedicato alle donne. Il silenzio è d’obbligo. Abbassiamo il capo e riflettiamo. Il rosso fuoco è protagonista - insieme ai pensieri - di una persecuzione ormai incontrollabile.
Chiudiamo gli occhi in segno di speranza. E che sia una gran speranza. San Biagio coltiva bontà, la tocchiamo nella gente. Ci mimetizziamo tra essi. Il Palazzo Ducale è una forma nobile per introdurre gli aspetti storici. Quel 1635 (non voglio interrogarvi) suona strano. Molto. Le fonti sono testimoni di una “licentia populandi” concessa. Eppure, il confronto storico è una comunicazione di dati e fatti. A partire dai rinvenimenti di epoca bizantina. Lo scampanellio di quel 1635 risuona strano. Ricerche e approfondimenti indicano di feudi appartenenti alla baronia di Sant’Angelo Muxaro e acquisiti nel 1592 dagli Aragona-Tagliavia di Castelvetrano. Qual è la verità? Entriamo dentro una raffica storica che asseconda la seguente fonte: il centro fu fondato nel 1648 da Don Mariano Gianguercio. E poi si susseguirono le famiglie dei Sidoti, Ioppolo, Spatafora, Pescatore e Bonanno fino al termine del feudalesimo (1812). Esiste un nesso logico? Siamo attendisti.
Il tempo scorre, il languorino è impaziente. Siamo di fronte a una scelta ricca e golosa. Tra “panuzzi di San Brasi”, il “buccellato” e i “cucciddateddi”, la “vutti è china e semu puru mbriachi di cuntintizza”. Il riposo perfeziona la buona volontà. Si riparte alla ricerca del Museo degli Archi di Pasqua. Descrive minuziosamente i passaggi di “sacrificio”. Miniature ed elementi decorativi sono elementi imprescindibili! La passeggiata è un lento ricamo che ci conduce alla Chiesa del Carmine (o Beata Maria Vergine del Carmelo). Della struttura originale del 1640 rimane… il richiamo al neoclassico. Il ritorno è un peregrinare verso gli Archi, dove tutto ebbe inizio. Osserviamo, scrutiamo, fotografiamo i particolari connessi e disconnessi. Dietro al lavoro certosino non manca, di certo, l’impegno delle confraternite de la “Madunnara” e “Signurara”. Elogi a scena aperta. San Biagio appaga le aspettative. Di un borgo solido e identitario. Dopo l’ennesimo scatto, ci sentiamo di appartenere alla comunità di Sammrasi. E mentre ci accingiamo ad andar via, gli echi pasquali stornellano gli ultimi passi in terra sanbiagese.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|










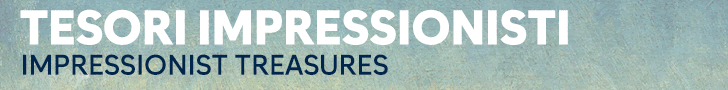




 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram
















