Si svolge in Sicilia, sfida i falsi miti: perché "Mafia, Terra Madre" non è solo un gioco
Uscito su tutte le piattaforme, in pochi giorni è diventato uno dei videogiochi più venduti. Ambientato nell'Isola, si ispira ai racconti di Pirandello e Camilleri

Un frame del videogioco "Mafia: Terra Madre"
Nel corso delle ultime ore, migliaia di videogiocatori in tutto il mondo hanno cominciato ad immergersi in questa preziosa ricostruzione storica della nostra isola, degna dei migliori affreschi letterari che sono stati realizzati dai principali autori siciliani dello scorso secolo: da Luigi Pirandello a Leonardo Sciascia.
Di questo videogioco abbiamo parlato spesso, analizzando le ambientazioni come l’importante sforzo di doppiaggio in siciliano dell’intera opera, voluto dalla stessa Hangar 13.
In questa occasione non vogliamo tuttavia recensire il titolo ora che è uscito sul mercato o celebrare nuovamente i suoi successi, considerando il responso positivo da parte del pubblico siciliano e internazionale, che lo sta premiando rendendolo tra i giochi più venduti di questa estate.
Qui vogliamo solo riflettere sulla valenza del medium videoludico per l’esporre a un grande pubblico temi complessi come la storia dell’origine della mafia e i problemi connessi all’insularità, argomenti che necessitano di profondi ragionamenti culturali e filosofici che fanno parte del nostro essere siciliani.
Per capire la grandezza di “Mafia: Terra madre” dobbiamo capire prima il suo stretto legame con le opere di Verga, Pirandello, Camilleri e di tutti quegli autori che hanno deciso di prendere maggiore consapevolezza della loro origine, sfidando i silenti segreti e le manifeste atrocità che hanno formato la nostra stessa cultura.
Gli sviluppatori di questo videogioco hanno infatti deciso di trarre ispirazione dai racconti di Verga e Pirandello per immaginare un protagonista che dalle infernali zolfatare del Nisseno – dove migliaia di “carusi” sono morti per colpa del capitalismo e dell’indifferenza dello Stato - riesce a farsi strada nella microcriminalità dell’inizio del secolo, per raggiungere per la prima volta una posizione in quella che considera una vera famiglia: il clan di Don Bernardo Torrisi.
Come però viene descritto spesso nelle opere veriste e dei primi del Novecento, in Sicilia la famiglia non è solo amore e protezione, ma anche dovere, silenzio, violenza e rispetto.
Tutti principi che non a caso faranno parte di quella struttura mafiosa che - nella realtà come nel gioco – attrarrà molti giovani nel corso del secolo, portando l’organizzazione a governare il mondo… o meglio il suo sottobosco.
Quello che si può infatti percepire, girovagando nella mappa di “Mafia: Terra Madre”, è che all’epoca i vari clan erano l’unico mezzo per sfuggire a una condizione di vita miserevole, in cui lo Stato era assente o era percepito come il peggiore dei nemici, essendo stato responsabile di quella guerra al brigantaggio che gli storici moderni paragonano a una guerra civile non dichiarata, dove la Sicilia e varie regioni del Sud vennero spogliati di qualsiasi forma di ricchezza, anche umana.
Era difficile per un gioco far percepire la costante sensazione di tragedia che contraddistingueva la mentalità mafiosa e la società siciliana dell’epoca. Basti pensare che opere letterarie e seriali più moderne – come la serie sui Florio uscita su Disney Plus - non sono riuscite a ottenere questo stesso obiettivo, sebbene godessero di maggiore considerazione da parte del pubblico più anziano.
“Mafia: Terra Madre” riesce tuttavia a raggiungere questo risultato, con rara eleganza e onestà. Esplorando le campagne siciliane a dorso di cavallo o entrando nelle antiche ville di stile ottocentesco presenti nel gioco, il videogiocatore non subisce passivamente l’ambientazione o la trama ideata da Hangar 13.
Esso si ritrova immerso in un periodo storico spesso non compreso, il più delle volte non riconosciuto dalla stessa collettività per paura di affrontare i propri fantasmi, impersonando un personaggio – Enzo Favara – che i videogiocatori più esperti stanno amando proprio per via delle sue negatività.
Favara non è infatti il classico antieroe che spesso viene rappresentato negli sceneggiati nostrani. Egli è al contempo il mezzo con cui capiamo la condizione dei nostri antenati, ma anche il personaggio che ci consente di riconoscere il bello e il marcio che continua a essere presente nella comunità siciliana.
Un metro di paragone che ci consente di distanziarci da un certo mito della Mafia, che la vede come organizzazione di semplici violenti, con la brama dei soldi – ricostruzione che negli ultimi anni ha ripreso a diffondersi grazie e soprattutto a un modo di raccontare spregiudicato del mondo criminale in televisione – ma anche di comprendere le ragioni storiche, economiche e culturali che ci differenziano da quegli uomini che, per sopravvivere, furono costretti a fare delle dolorose scelte.
In una Sicilia bella e terribile, più simile al Far West che alla Sicilia attuale, ciascun giocatore sarà così condotto a immergersi in un dilemma morale, che è difficile districare ancora oggi. Ribadendo al termine di questo articolo la repulsione necessaria e dovuta nei confronti del comportamento mafioso, che dagli inizi del Novecento ha provocato migliaia di morti solo nella nostra isola, ci si domanda tuttavia come mai sia stato proprio un gioco prodotto all’estero ad ereditare il ruolo della letteratura nello svelamento degli angoli più oscuri e dolorosi della nostra storia.
Forse perché a differenza di quanto professano i media generalisti, il tema della Mafia e l’origine delle cause che ne hanno influenzato il percorso storico sono ancora un tabù per buona parte di noi, che si può circoscrivere e controllare ignorandone volutamente le ragioni sociali e storiche o facendo in modo che non se ne parli.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|










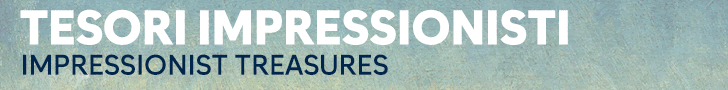




 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram
















