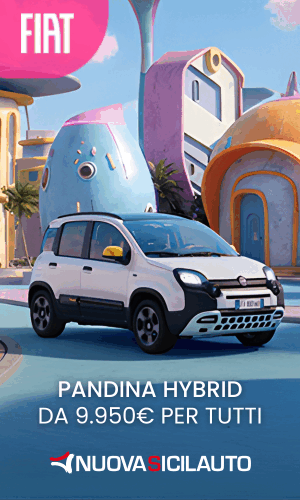STORIA E TRADIZIONI
Un colore nato per caso, lo sbarco in Sicilia: perché le "camicie rosse" si chiamarono così
Tra le tante storie intrecciate a quel giorno alcune grandi e altre no, ce n’è una che resiste al tempo e che ancora oggi accende la fantasia di storici e lettori e studenti

Una scena dal film "Il Gattopardo"
Uno degli episodi più audaci e mitici del Risorgimento italiano, un momento che avrebbe cambiato per sempre il destino della penisola, tracciando la via verso l’Unità.
Tra le tante storie intrecciate a quel giorno, alcune grandi e altre minime, ce n’è una che resiste al tempo e che ancora oggi accende la fantasia di storici e lettori, studenti e appassionati: quella delle camicie rosse, un capo d’abbigliamento divenuto simbolo universale del garibaldinismo, nato quasi per caso in una terra lontana, trasformato in leggenda tra stoffe, tintorie, fuochi di battaglia e spiriti ribelli.
Per comprenderne l’origine, bisogna tornare indietro di diciassette anni e spostarsi a Montevideo, nell’Uruguay del 1843, dove Garibaldi, allora esule e combattente al servizio della causa repubblicana, aveva riunito cinquecento volontari italiani nella Legione Italiana con l’intento di difendere la giovane Repubblica uruguaiana dall’attacco del dittatore argentino Juan Manuel de Rosas.
I suoi uomini, privi di risorse, mezzi e divise, combattevano inizialmente con abiti civili, finché non si presentò un’occasione inaspettata quando fu messo a disposizione un carico di camiciotti di lana rossa, destinati ai macellai di Buenos Aires ma rimasti invenduti a causa della guerra e dell’interruzione delle attività nei saladeros, i grandi macelli sudamericani.
Quei camiciotti, pensati per nascondere le macchie di sangue, furono distribuiti ai garibaldini, e benché il colore non fosse stato scelto per motivi simbolici, cominciò a farsi strada nell’immaginario collettivo come emblema di coraggio, ribellione e passione, tanto che Garibaldi ne rimase affascinato al punto da adottarlo anche nelle campagne successive, trasformandolo in una vera e propria firma della sua epopea.
Quando, nella primavera del 1860, si cominciò a organizzare la spedizione verso la Sicilia, la camicia rossa era già leggenda, e si rese necessario produrne in gran numero per vestire i volontari che si sarebbero imbarcati da Quarto.
La sfida era complessa, il tempo poco, le risorse limitate, ma in aiuto della causa intervenne un piccolo borgo della Val Seriana, Gandino, noto sin dal Seicento per la lavorazione dei pannilana e, soprattutto, per la qualità della sua tintura scarlatta, una tonalità intensa e brillante ottenuta grazie a una tecnica raffinata basata sull’uso della cocciniglia, un minuscolo insetto parassita raccolto e essiccato, le cui femmine erano ricercate per l’acido carminico che producevano, elemento fondamentale per ottenere quel rosso vivo che aveva incantato le corti europee.
La tecnica, giunta probabilmente in Europa attraverso i traffici veneziani con l’Olanda, fu perfezionata a Gandino al punto che i tintori della valle, con ostinazione e talento, riuscirono a rompere il monopolio concesso dal Senato della Serenissima ai veneziani Armellini, imponendosi nel mercato e guadagnando prestigio internazionale, tanto che si narra che persino alcuni imperatori si fossero rivolti a loro per ottenere prestiti, conquistati dalla bellezza e dalla lucentezza dei loro tessuti.
All’epoca della spedizione dei Mille, Gandino contava ben dieci tintorie attive, tra cui quella di Prat Serval – condotta da Pietro e Abramo Maccari – insieme alle aziende dei Radici, Fiori, Crotti, Frana, Pasini, Motta, Bonduri, Rottigni e Ghirardelli, e proprio quest’ultima famiglia, con Marco Ghirardelli e i Radici, fu tra le prime a introdurre nella valle le nuove tecnologie della Rivoluzione industriale, modernizzando le tecniche produttive e rendendo possibile un’impresa così rapida e corale.
Giovan Battista Fiori, imprenditore locale ben inserito negli ambienti piemontesi, si adoperò con energia e abilità per radunare un vero e proprio consorzio produttivo e dare vita, in pochissimo tempo, a quello che oggi potremmo definire un pool di imprese, coordinando tintorie e laboratori sartoriali e facendo in modo che la valle intera si trasformasse in una fucina di patriottismo tessile.
Le stoffe tinte di scarlatto furono poi trasportate in parte a Bergamo, dove la sartoria di Celestina Belotti, fidanzata del garibaldino Francesco Nullo, le trasformò in camicie, e in parte a Milano, dove patriote come Laura Solera Mantegazza e altre signore risorgimentali completarono il lavoro di confezione; alla fine, si riuscì a produrre tra le trecento e le quattrocento camicie, insufficienti a vestire l’intera spedizione ma abbastanza da creare l’immagine simbolica che avrebbe attraversato la storia.
Molti dei Mille partirono da Quarto con abiti civili, improvvisati, alcuni con giacche da marinaio o pantaloni da lavoro, ma bastarono quelle camicie rosse, distribuite tra ufficiali e primi volontari, per accendere l’immaginario e costruire il mito di un esercito popolare, variegato, romantico e determinato, che più che un esercito vero e proprio sembrava una compagnia teatrale armata di ideali e fucili.
Quando l’11 maggio le navi garibaldine approdarono a Marsala, il vento continuava a soffiare favorevolmente e nel porto si trovavano due navi inglesi, l’Argus e l’Intrepid, che con la loro sola presenza scoraggiarono i borbonici dal reagire con forza, consentendo ai Mille di sbarcare tra le cantine e i vicoli della città quasi senza incontrare resistenza, mentre alcuni garibaldini approfittavano dell’occasione per assaggiare il celebre vino marsalese, secondo un aneddoto tanto amato quanto raccontato.
Non tutti indossavano la camicia rossa, ma chi la portava sembrava splendere al sole siciliano, tra la polvere delle strade e l’entusiasmo della popolazione, in un quadro che sarebbe rimasto impresso nell’iconografia del Risorgimento e nella memoria collettiva del Paese.
Quel capo, nato nei magazzini inutilizzati dei macelli sudamericani, trasformato dalle sapienti mani bergamasche e cucito con passione da donne che credevano nell’Unità, divenne il simbolo di un’Italia che stava nascendo, il colore stesso di un’idea che mescolava fuoco, sangue, coraggio e ribellione, un rosso che non era solo tinta ma identità, scelta, battaglia.
Ancora oggi, camminando per le strade di Marsala, osservando i monumenti o i dipinti dell’epoca, ciò che colpisce non è tanto la divisa completa quanto quella fiammata scarlatta che emerge tra la polvere e la luce, il rosso che ha attraversato la storia e che continua a raccontarla, il rosso che ha colorato l’Unità d’Italia e che, nato per caso, è diventato leggenda.
Gandino, orgogliosa della sua parte in questa storia, custodisce ancora oggi il ricordo con una lapide apposta nel 1961 presso la Tintoria degli Scarlatti, e con la consapevolezza che quel rosso che ha fatto l’Italia è nato anche tra le sue montagne, grazie a mani operose, a una tradizione antica e a un improvviso bisogno di libertà.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram