Un romanzo siciliano ispirò Mary Shelley: il castello (irreale) della torre di Frankenstein
Tra le autrici che vennero in un qualche modo citate da Polidori e da Mary Shelley c’è la scrittrice oggi considerata l’anticipatrice dello stile di tutti gli autori horror inglesi

Una scena da Frankestein di Guillermo del Toro
Parlando di mostri sacri della letteratura mondiale e delle giornate dedicate al culto dei morti che si svolgono a novembre non si può non pensare alla Creatura immaginata dalla Shelley, le cui disavventure non hanno solo ispirato vari film, spesso dozzinali, che hanno segnato la storia del cinema, ma dato anche origine a due dei generi letterari più importanti in assoluto, ovvero l’horror e la fantascienza. La letteratura gotica e lo sci-fi nascono infatti grazie alla fantasia della famosa autrice inglese, moglie di quel Percy Shelley che viene considerato il più importante dei poeti romantici inglesi, insieme a Lord Byron.
Non tutti però sanno che la stesura di Frankenstein avvenne contemporaneamente alla stesura della prima opera in cui è presente un vampiro moderno, “Il vampiro” di John Polidori, durante una gara letteraria svolta presso la villa in cui risiedevano i Shelley durante l’estate del 1816, noto anche come “l’Anno senza estate”. In quel contesto, gli scrittori presenti trassero ispirazioni dal contesto uggioso e dalla loro prigionia dorata - la Villa Diodati, affittata da Byron e dai Shelley presso il lago Lemano in Svizzera – per scrivere le loro immortali opere, dando origine a quello che da lì in avanti sarebbe stato descritto come il libro gotico anglosassone.
Esso si discosta di molto rispetto alla letteratura orrorifica anticipatrice dei decenni precedenti, che aveva come ambientazione principale il Mediterraneo e in particolare il Sud Italia. Le opere gotiche anglosassoni erano infatti ambientate in contesti più nordici, in lucubri paludi o all’interno di nebbiosi villaggi di contadini, ma essendo sia Polidori che Mary Shelley dei grandi amanti della cultura classica scelsero comunque di citare nelle loro opere alcuni luoghi e situazioni tipici della letteratura antecedente.
Tra le autrici che vennero in un qualche modo citate da Polidori e da Mary Shelley c’è la scrittrice inglese Ann Radcliffe, oggi considerata l’anticipatrice dello stile e dei contenuti di tutti gli autori horror inglesi. La Radcliffe, all’epoca in cui Polidori e Mary Shelley scrissero le corrispettive opere, era ancora in vita, ma avendo pubblicando la maggioranza dei suoi testi in forma anonima, in quanto donna, oggi non sappiamo se il suo nome era conosciuto dai colleghi. Di certo le sue opere erano note, tanto che sul finire del Settecento i suoi romanzi erano considerati dei veri e propri best seller, stampati non solo in Inghilterra ma anche negli USA e nelle colonie.
L’opera principale della Radcliffe, che secondo i critici anticipò gli stili e i temi dei romanzieri horror del secolo successivo, è “Romanzo Siciliano”, l’opera che sembrò influire maggiormente l’immaginazione degli autori successivi. In questo romanzo si raccontano le vicende di una famiglia nobiliare siciliana, condannata dal destino a vivere delle esperienze paranormali in grado di far accapponare la pelle.
La storia è ambientata nel castello dei marchesi di Mazzini, una località inventata dall’autrice. Il marchese, uomo autoritario e severo, vive con le sue due figlie, Emilia e Giulia, mentre la madre delle ragazze è morta da tempo, o almeno così tutti credono. L’assenza della madre aleggia come un’ombra sul castello e come una maledizione nei confronti dell’ex marito, ma l’elemento più spaventoso del racconto è la descrizione di una parte dell’edificio, misteriosamente abbandonata. Al suo interno, di notte, si odono lamenti e rumori inquietanti, da alcune pareti trasuda una muffa dal colore del sangue e nessuno, tanto meno Emilia e Giulia, osano esplorare quelle stanze. La descrizione di questo castello ricorda molto da vicino l’ambientazione scelta da Polidori (e successivamente da Bram Stoker) dove far vivere il vampiro, ma esistono anche dei parallelismi con la torre usata da Victor Frankenstein per compiere i suoi macabri esperimenti.
Nel corso del romanzo della Radcliffe (la cui stessa esistenza è per buona parte avvolta dal mistero), Giulia si innamora del nobile Ippolito di Vivaldi, ma il padre ha in mente per lei un matrimonio di convenienza, scelta che porta la giovane a fuggire tra mille pericoli. La sua fuga attraverso i paesaggi montuosi, i conventi le rovine greche-romane abbandonate della Sicilia diventa così un percorso di crescita personale, in cui la paura e la speranza si alternano di continuo. Intanto, nel castello dei Mazzini, i misteri si infittiscono.
Le urla provenienti dal lato abbandonato dal castello si fanno più orribili e insistenti, mentre l’aspetto del marchese diventa sempre più orribile e malato, essendo afflitto da una malattia della mente. Alla fine si scopre che la marchesa, creduta morta, era stata in realtà murata viva dal marito per gelosia e crudeltà. La sua apparente “presenza spettrale” non era che il frutto delle sue urla disperate e dei tentativi di comunicare con il mondo esterno.
Costretta a vivere al buio, nutrendosi dei resti che gli venivano concessi dal marito, la donna aveva cominciato a perdere la ragione e a cacciare a mani nude i topi che circolavano per le sale. Era il sangue di queste creature a trasudare dalle pareti. Come in tutte le opere di Ann Radcliffe, gli elementi soprannaturali trovano alla fine una spiegazione razionale: il terrore non nasce dai fantasmi, ma dalle passioni umane, come l’avarizia e la crudeltà, mentre il romanzo si conclude con la liberazione della marchesa, che ritrova la lucidità rivedendo le figlie, e la punizione del colpevole, in un ritorno finale all’ordine e alla giustizia.
In “Romanzo Siciliano”, paradossalmente, le antiche rovine vengono descritte alla piena luce del giorno, ma è proprio grazie a questa luce se l’orrore diventa ancora più visibile all’occhio del lettore, rivelandosi in un contesto di apparente pace eterna. Con questo romanzo Ann Radcliffe consolida anche il modello del romanzo come strumento di indagine delle passioni umane, specialmente quelle femminili, con la protagonista che è al contempo vittima ed eroina dell’opera, rappresentando la virtù e la sensibilità oppresse dal potere patriarcale.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|










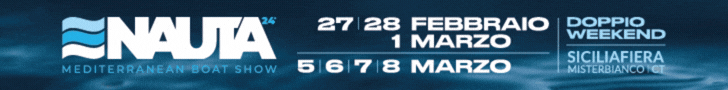




 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram
















