Cinema da record, Sicilia set a cielo aperto: ma "la crisi è dietro l'angolo", i motivi
Da un'Isola fatta di set e macchine da presa che girano per dieci ore al giorno a una che potrebbe ritornare improvvisamente ai tempi in cui vedere una troupe era un evento

Proiezione cinematografica all'aperto
Questo se ci si limita solo al lavoro sul set. Perché fuori, la filiera prosegue con montatori, e VFX artist, e compositori di colonne sonore, e tecnici del suono. Dall’anno prossimo, cioè dalle soglie del 2026, in Sicilia, come in tante altre regioni, «ci sarà molta meno produttività». A parlare è Dario Indelicato, fondatore di "Siamo ai titoli di coda", gruppo collettivo di lavoratori del settore cine-audiovisivo, oltre che montatore, tecnico di imaging digitale e documentarista, originario di Trapani ma trasferitosi a Roma più di venticinque anni fa. La sua è una fotografia dell’isola fatta in questo preciso momento storico e proiettata in un futuro proprio dietro l’angolo: «In questi giorni ci sono in giro per la Sicilia, e per tutta l’Italia più in generale, produzioni in cui si corre come i pazzi per partire entro febbraio 2026, perché se un film, una serie, un cortometraggio, vengono attivati entro febbraio, rientreranno nello scaglione finanziario della manovra 2025». Altrimenti niente, nessun set, nessun ciak battuto, nessuna macchina da presa che filma.
«Ci sono serie che sarebbero partite in primavera inoltrata, quasi a ridosso dell’estate, che stanno anticipando con velocità incredibile, il messaggio è chiaro: “Partiamo ora, perché dopo non si sa se riusciremo a farlo”». Da maggio a fine agosto 2025 c’erano non più di venti opere in produzione in tutta Italia. In quel periodo normalmente c’è «un picco massimo molto più alto – dice Indelicato – per questioni ad esempio climatiche, o di luce, dato che le giornate durano di più».
Il calo era dovuto a un’incertezza generale, in cui i produttori non sapevano quali prospettive di rientro potesse avere il loro investimento, anche piccolo. Poi, da metà ottobre ad oggi, il recupero improvviso: «Si sono attivate sessanta produzioni, è schizzato tutto di punto in bianco, non ci ha capito più niente nessuno, si sono susseguite chiamate all’ultimo momento per formare le squadre dei tecnici, perché tutti si affrettano a girare adesso che è ancora possibile recuperare il famoso "tax credit" (un incentivo fiscale che permette alle società di produzione di ottenere uno sgravio sulle tasse dovute allo Stato, ndr.), che sanno che non avranno più. Tutti i progetti sospesi nel tempo adesso stanno cercando di partire. Siamo davanti a una bella bolla che si sgonfierà di colpo entro fine marzo, poi arriverà il vuoto. Ad aprile, con le condizioni proposte in questo momento, il settore chiude. Ci sarà un crollo che ammonta quasi all’80% della produttività, c’è chi dice di più. Rimarranno in pochi, le piccole e medie società non ce la faranno. C’è una ricaduta micidiale».
“Come se milioni di voci gridassero terrorizzate e a un tratto si fossero zittite”, diceva Obi-Wan Kenobi nel primo, storico “Guerre stellari”. Solo che adesso non è un film, al contrario. È un mondo concreto, che rischia di non avere più tante voci, un mondo in cui esprimersi, soprattutto per un esordiente o un regista alle prese con le sue prime opere, sarà più difficile di quanto non lo sia già. A dirlo è Giuseppe William Lombardo, palermitano, classe 1994, prossimamente in sala con "Lo scuru", film interamente girato in Sicilia, in una parte nascosta fra la piana di Gela e le contrade aspre di Butera, Niscemi e Mazzarino. È lui uno dei giovani registi che rischiano, all’indomani del taglio, di vedere la propria voce messa a tacere. «Sui tagli previsti per adesso (da circa 700 milioni disponibili sino ad oggi si dovrebbe scendere a 550 per il prossimo anno e 500 per il 2027, ndr.) si può discutere quanto si vuole, e premetto che se qualcuno ha truffato è giusto che paghi – spiega Lombardo – ma non c’è alcun motivo di andare a incolpare un intero settore. Il tax credit servirebbe per le opere difficili, che non hanno una destinazione commerciale forte. Perché il 40% del suo totale viene destinato sempre ai film stranieri, che magari hanno già una grande produzione alle spalle, e non si pensa di investire maggiormente sulle opere prime e seconde?».
Il rischio, naturalmente, è la paralisi creativa, la tendenza all’omologazione e una volontà di non ricercare da parte dei produttori. Traducendolo in una visione pratica, se la Sicilia che vende maggiormente è quella più classica, più conosciuta, «da cartolina», dei prodotti più commerciali, quella è l’unica Sicilia che rischia di finire in sala o sulle piattaforme di streaming, e tutto ciò che se ne discosta rischia di non essere più finanziato perché non è sicuro che piaccia, che venda. «Eppure – aggiunge Lombardo – il tax credit servirebbe ai giovani autori a rischiare, a formare, insieme ai bandi selettivi e altri strumenti, nuovi talenti.
Purtroppo non esiste la formula perfetta che ci dice quale film avrà successo. È triste pensare che per un giovane autore ci saranno, in futuro, ostacoli in più. Conterà sempre l’idea? Cos’è che potrà rendere vincente un progetto? Cos’è che permetterà di chiudere definitivamente il budget? I film si fanno creando cose nuove. È come se si stesse chiedendo di far sparire i registi giovani che sperimentano, o di omologare tutti nel nome di una presunta "identità culturale italiana" (parole dello stesso ministro della cultura Alessandro Giuli, ndr.) che inevitabilmente si andrebbe a perdere proprio a causa dell’omologazione che porta tutti a giocare sul sicuro».
Il taglio, comunque, non è il solo problema. «Non c’è ancora stato – ricorda Dario Indelicato – e la manovra dev’essere comunque discussa alla Camera nei prossimi giorni, ma ci sarà. C’è un problema nella condotta ministeriale, che è paradossale perché per la seconda volta c’è un ministro della Cultura che chiede di tagliare il fondo, e c’è un motivo per cui chiede di tagliarlo, perché c’è la necessità di coprire un buco nelle casse del Ministero della cultura, a loro non piace chiamarlo così, ma c’è a causa di un cosiddetto “splafonamento” che con la vecchia legge era possibile».
In breve, al cinema era stato assegnato un fondo su cui, nel periodo di produzione intensiva immediatamente post-pandemia, è mancato un controllo attento e scrupoloso, e questo ha portato a spendere più di quanto si poteva, sino ad ammontare «a circa un miliardo e mezzo», spiega Indelicato. «L’obiettivo del Ministero è di recuperare questa mancanza tagliando, ed è una follia, perché se tagli probabilmente recuperi su questa mancanza, ma nel frattempo hai raso al suolo un settore che non è più in grado di sopravvivere. Non è una cura, è una forma d’eutanasia».
E secondo Indelicato il problema non sono nemmeno i film che vengono prodotti, spesso accusati di «non avere un pubblico»: «Questo non è il vero metro di misura, soprattutto oggi, con cui si può stabilire la valenza di un film o meno. La sala purtroppo non risponde più a una logica di successo, perché la gente non va in sala. Non è che è il film che non li attira, ci sono mille altri problemi per cui la gente non va in sala, a partire dai costi elevati di un biglietto per una famiglia. Il cinema non dovrebbe mai essere valutato nella misura dell’incasso, dovrebbe avere un valore più culturale, artistico, il suo metro di misura è il tempo. Ci sono film che diventano belli dopo un decennio, che vengono capiti o apprezzati di più con gli anni. In base alla logica dell’incasso, anche Van Gogh l’avremmo dovuto buttare nella spazzatura da subito. L’incasso riguarda più l’intrattenimento, ed è su questa distinzione, tra cinema e intrattenimento, che dovremmo iniziare a lavorare».
Che immaginario cinematografico aspetta il pubblico in sala nei prossimi anni? «I classici quattro, cinque nomi che fanno sempre lo stesso film» è la risposta di Zavvo Nicolosi, il regista paternese che con il duo musicale Colapesce e Dimartino portò al cinema, nel 2023, "La primavera della mia vita", suo lungometraggio d’esordio ambientato interamente in una Sicilia insolita fatta di pani lisergici, leggende di uno Shakespeare messinese e miti sui giganti. «Film come "Le città di pianura", che da poco è stato in sala, ad esempio sono destinati a finire. Eppure in Italia – continua Nicolosi – ci sono due tipologie di pubblico al cinema: i benestanti tra i 50 e i 75 anni, persone con stipendi discreti, abituate alla sala, in grado di spendere sette, otto, dieci euro di biglietto, e poi una fascia di cinefili giovanissimi che va a vedere, o rivedere, anime giapponesi come "Demon Slayer", "Akira" o "Perfect Blue". Mentre i primi vanno – e continueranno – a vedere cose come "Follemente", "C’è ancora domani" o i film di Riccardo Milani, tutti prodotti con budget superiori alla media da produttori medio-grandi, i secondi già adesso non vengono rappresentati da storie che li raccontino, e rifuggiranno da un cinema che non si prende il rischio di raccontarli».
In breve, non ci può essere mercato per un film che non viene proiettato, per una storia che si sceglie di non girare perché esiste il rischio che la vadano a vedere in pochi, pochissimi. «E finirà che il cinema lo potrà fare solo chi se lo potrà permettere economicamente – dice Dario Indelicato – . Nel nostro settore c’è una particolarità, e cioè che la maestranza, spesso e volentieri, a seconda del reparto in cui lavora e a cui fa riferimento, ha un’evoluzione, acquisisce l’esperienza che la fa diventare autore, sceneggiatore, direttore della fotografia, iniziando come assistente o aiuto dell’assistente. Questa cosa non sarà più possibile perché gli occupati saranno sempre meno, quindi il racconto della realtà arriverà soltanto da chi ha una famiglia ricca, da chi non ha dovuto fare sacrifici, ed è difficile raccontare qualcosa per il mondo partendo da quel punto lì. La grande storia che ci ha resi grandi a livello cinematografico viene sempre dal basso, da un percorso di crescita interna. Se io non ho nemmeno più la possibilità di crescere ed evolvermi per poter offrire anche il mio pensiero, questo è un problema culturale immenso. Un disastro in cui potrà essere testimone della vita solo chi vive nel privilegio».
Da una Sicilia fatta di set e macchine da presa che girano per dieci ore al giorno a una che, improvvisamente, potrebbe ritornare ai tempi di "Ragazzi fuori" o "La piovra", in cui vedere una troupe che gira era davvero un evento in grado di catalizzare l’attenzione di una comunità. «Una soluzione – conclude Indelicato – potrebbe essere cercare di supportare la cultura, dato che a farlo è il Ministero della cultura. E quindi ad esempio una serie Rai, che è chiaro che può attingere ad altre risorse economiche, dovrebbe guardare a quelle risorse più che al fondo per il cinema. In questo momento di vulnerabilità, è più importante tutelare la parte culturale.
Servono misure graduali, non eccessivamente dirompenti, bisognerebbe mantenere il fondo allo stesso livello, se c’è stata un’evoluzione che ha portato a un incremento d’occupazione nel settore, come si può pensare di tornare indietro? Significa mandare a casa gente che fa questo lavoro da venticinque o trent’anni, come si reinventano? Per dirla in siciliano, ci voli ‘u ventu ‘n chiesa, ma no ‘a astutari i cannili…».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|










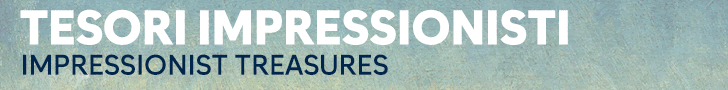




 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram















