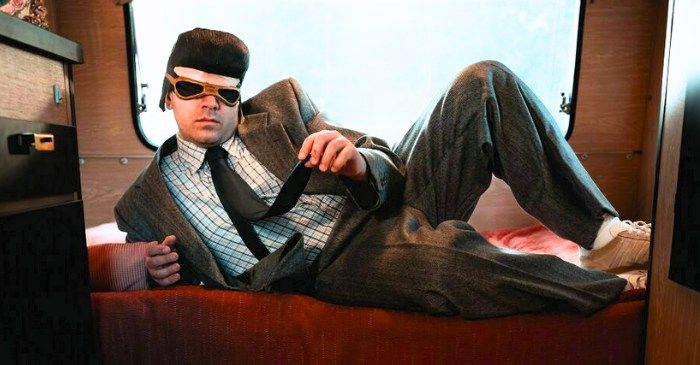STORIA E TRADIZIONI
Le usi per i fiori ma ci conservavano bontà siciliane: perché la "burnia" si chiama così
A prima vista può sembrare un semplice recipiente, occhi esperti invece lo identificano con il "mitico" contenitore dell'Isola. Vi raccontiamo la sua storia

burnia
Un “mitico” contenitore che, una volta scoperchiato, non sprigiona secondo mitologica rimembranza presenze o mali del mondo, ma profumi colti e conservati, provenienti direttamente dalla Trinacria. A prima vista può sembrare un semplice recipiente, occhi esperti invece lo identificano con burnia.
Il termine siciliano, come molti vocaboli dell’Isola e non solo, deriva dall'arabo "burnïya", in spagnolo (albornía) e catalano (al)búrnia, e presente in sardo con (bùrnia) e in tutte queste versioni indica un vaso.
Originariamente era un contenitore in terracotta dalla forma cilindrica, simile a una piccola giara, usata per conservare gli alimenti che richiedono l’uso della salamoia e che rischiano di rovinarsi per temperature estreme: olive, capperi, acciughe, strutto, strattu (passata di pomodoro concentrata).
L’argilla è la materia prediletta per dar forma a questi contenitori, ancora oggi usata nella lavorazione delle ceramiche in diverse località della Sicilia come Caltagirone, Santo Stefano di Camastra e Sciacca per citarne alcuni.
E partendo proprio dalla materia prima e dalla lavorazione la burnia assume la sua particolare forma secondo un processo svolto per fasi: dalla forgiatura, in cui vaso e coperchio sono modellati a mano partendo proprio dall’argilla, all’essiccazione con lunga cottura a temperature elevate, fino alla smaltatura con immersione in smalti colorati.
Infine, una seconda cottura per fissare lo smalto e la decorazione a mano con motivi geometrici o ghirlande di fiori. Ore di pazienza, dunque, per un manufatto in terracotta che oltre ai cibi poteva custodire anche unguenti, estratti e sostanze per le preparazioni farmaceutiche.
Questo perché la terracotta è nota per essere un materiale isolante; beneficio di cui erano a conoscenza anche nel XV secolo. Esistono, infatti, testimonianze delle burnie di Sciacca di colore bianco o verde o quelle di Polizzi.
Oggi il termine burnia oltre alla Sicilia, lo troviamo anche in Piemonte e Liguria e il passare del tempo mantiene il significato anche se ce lo mostra nella sua forma più evoluta e diffusa: un barattolo in vetro con tappo o chiusura ermetica.
Le tradizionali burnie invece continuano a sopravvivere nelle case dei parenti come cimeli speciali adibiti a usi che vanno oltre i cibi e aromi: da vaso per fiori, a elemento decorativo testimoni di un passato in cui conservare era un atto di cura e pazienza.
Il mistero che avvolge le burnie e la loro funzione protettiva di cibi, invisibili a un primo sguardo, è anche il fulcro di un antico proverbio siciliano: “Sgarrari la burnia - sbagliare la burnia”, cioè scambiare o prendere una cosa per un’altra.
Questo probabilmente perché quando si credeva di aver preso la burnia dei capperi, in realtà ci si poteva ritrovare al cospetto di quella contenente le acciughe.
Fonte: XLI Convegno 2008: Unguenta solis. Ceramica da farmacia tra Medioevo ed Età Moderna.
Il termine siciliano, come molti vocaboli dell’Isola e non solo, deriva dall'arabo "burnïya", in spagnolo (albornía) e catalano (al)búrnia, e presente in sardo con (bùrnia) e in tutte queste versioni indica un vaso.
Originariamente era un contenitore in terracotta dalla forma cilindrica, simile a una piccola giara, usata per conservare gli alimenti che richiedono l’uso della salamoia e che rischiano di rovinarsi per temperature estreme: olive, capperi, acciughe, strutto, strattu (passata di pomodoro concentrata).
L’argilla è la materia prediletta per dar forma a questi contenitori, ancora oggi usata nella lavorazione delle ceramiche in diverse località della Sicilia come Caltagirone, Santo Stefano di Camastra e Sciacca per citarne alcuni.
E partendo proprio dalla materia prima e dalla lavorazione la burnia assume la sua particolare forma secondo un processo svolto per fasi: dalla forgiatura, in cui vaso e coperchio sono modellati a mano partendo proprio dall’argilla, all’essiccazione con lunga cottura a temperature elevate, fino alla smaltatura con immersione in smalti colorati.
Infine, una seconda cottura per fissare lo smalto e la decorazione a mano con motivi geometrici o ghirlande di fiori. Ore di pazienza, dunque, per un manufatto in terracotta che oltre ai cibi poteva custodire anche unguenti, estratti e sostanze per le preparazioni farmaceutiche.
Questo perché la terracotta è nota per essere un materiale isolante; beneficio di cui erano a conoscenza anche nel XV secolo. Esistono, infatti, testimonianze delle burnie di Sciacca di colore bianco o verde o quelle di Polizzi.
Oggi il termine burnia oltre alla Sicilia, lo troviamo anche in Piemonte e Liguria e il passare del tempo mantiene il significato anche se ce lo mostra nella sua forma più evoluta e diffusa: un barattolo in vetro con tappo o chiusura ermetica.
Le tradizionali burnie invece continuano a sopravvivere nelle case dei parenti come cimeli speciali adibiti a usi che vanno oltre i cibi e aromi: da vaso per fiori, a elemento decorativo testimoni di un passato in cui conservare era un atto di cura e pazienza.
Il mistero che avvolge le burnie e la loro funzione protettiva di cibi, invisibili a un primo sguardo, è anche il fulcro di un antico proverbio siciliano: “Sgarrari la burnia - sbagliare la burnia”, cioè scambiare o prendere una cosa per un’altra.
Questo probabilmente perché quando si credeva di aver preso la burnia dei capperi, in realtà ci si poteva ritrovare al cospetto di quella contenente le acciughe.
Fonte: XLI Convegno 2008: Unguenta solis. Ceramica da farmacia tra Medioevo ed Età Moderna.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ARTE E ARCHITETTURA
A Palermo riapre il monastero di Santa Caterina: dopo 100 anni "torna" Van Dyck
di Maria Oliveri















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram