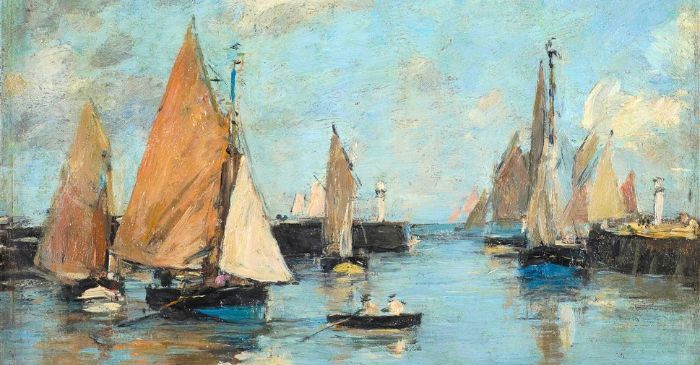TRADIZIONI
Non solo l'arancina, ma anche un dolce: qual è la torta contesa tra Palermo e Catania
La torta Savoia, come tanti altri dolci siciliani, è probabilmente frutto di varie contaminazioni, di culture lontane, di viaggi e viaggiatori: ecco la sua storia

La torta Savoia
La torta Savoia è un dolce intramontabile della pasticceria siciliana. Un classico goloso e irresistibile a cui è difficile dire di no.
Si tratta di una torta composta da sottili strati di pan di Spagna, farciti di crema alle nocciole e ricoperta di glassa al cioccolato.
L’elenco degli ingredienti, così diversi da quelli tipici della pasticceria tradizionale isolana (mandorle, pistacchi, zuccata, ricotta) rivela sicuramente un’origine particolare.
Lo scrittore Leonardo Sciascia, appassionato di buon cibo e dolci, dalle impanatigghie ai taralli, non disdegnava mai la torta Savoia della più antica pasticceria di Ragusa, fondata da Giovanni Di Pasquale nel 1960.
A contendersi il primato di aver inventato la torta Savoia sono però altre due città siciliane: Palermo e Catania.
Diciamo subito che la leggenda, per altro recente che vuole attribuire l’invenzione del dolce alle monache benedettine di Catania non ha nessun fondamento storico.
Innanzitutto quali benedettine, viene spontaneo chiedere?
A Catania dopo la ricostruzione del terremoto del 1693 c’erano 5 monasteri, 4 benedettini (S. Placido, S. Agata, S. Benedetto, S. Giuliano, Ss.ma Trinità) e uno di clarisse (S. Chiara).
Gli archivi dei monasteri di Catania ci rivelano che erano le clarisse a produrre e vendere dolci, e non le benedettine! Tanto che per il loro commercio venivano chiamate spregiativamente dalle religiose delle altre comunità “monache viscuttare” (biscottare).
Le benedettine infatti erano solite confezionare dolci solo per loro stesse e per persone di riguardo (come re Ferdinando III in visita a Catania), per il Vescovo e i confessori, per i familiari, non per farne commercio.
Le monache consumavano sorbetti di fragole per il Corpus Domini, sorbetti di anguria per la Fiera d’Agosto, sorbetti di cioccolata e pistacchi per la festa delle Quarantore.
Durante le feste in tutte le comunità era cospicuo il consumo dei dolci tra cui cannoletti a base di riso uova e latte, biscotti di mandorle ricoperti di liffia (glassa), mostazzole, cassate di ricotta per Pasqua.
Ma anche fastucata (dolce a base di pistacchi legati da zucchero vanigliato e spolverati con cannella), cobaita e dolce bianco (biancomangiare).
Importante era l’uso di cioccolato: il 7 Giugno 1796 dopo un lauto banchetto380, tra gelati e sorbetti, la badessa di San Giuliano distribuì ad ogni monaca quasi 4 chili di cioccolata.
Sappiamo che butirro di cioccolata veniva ordinato al monastero della Ss. Trinità di Catania ma della torta Savoia nessuna traccia.
Gli archivi dei monasteri di Palermo ci mostrano che nel Settecento e nell’Ottocento anche le religiose del capoluogo consumavano grandi quantità di ciccolatte o cioccolatta, spesso sciolta in tazza (chicchera) ma non ne utilizzavano nella preparazione dei dolci-
Persino nella crema di ricotta dolce ingrediente principe di cannoli e ricotta mescolavano la cucuzzata (zuccata) tagliata a pezzetti.
Escluse le monache ed esaminati gli ingredienti, verrebbe da ipotizzare piuttosto che l’origine della torta Savoia sia legata alla pasticceria Svizzera, dove del resto si poteva gustare fino agli anni ’90 del secolo scorso.
La pasticceria Svizzera si afferma in Sicilia tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento: a Palermo ci sono i Caflish e la ditta Rageth Khoch, a Catania i Caviezel.
Erano tutti originari del Cantone dei Grigioni, l’Engandina: i valligiani emigrarono in gran numero e furono i primi ad aprire i caffè a Venezia nel Settecento.
Nell’Ottocento se ne incontrano in tutta Europa occupati nell’esercizio della pasticceria, della fabbricazione e della vendita di liquori e cioccolata.
Il XIX secolo è proprio il periodo in cui si registra il maggiore flusso di emigrazione e nelle maggiori città del continente troviamo almeno un caffè grigionese.
A Petch in Ungheria troviamo il caffè Caflisch, a Munster in Germania il caffè Schucan, a Genova Giacomo Pitchen (poi Piccinini), Giulio Cadisch proprietario di negozi e caffè e la famosa pasticceria Klainguti fondata nel 1828.
I pasticceri provenivano prevalentemente dalle regioni protestanti del cantone; gli emigranti cattolici si arruolavano negli eserciti stranieri.
Luigi Caflish, originario di Trin, inaugurò una pasticceria a Livorno, poi ne aprì una a Roma e nel 1825 un’altra a Napoli: qui si vendevano al pubblico “Confetture, pasticcerie, frutti canditi, dolci, cioccolatta, bomboniere” (Annuario storico 1886).
Luigi era solo un omonimo di un altro Caflisch, Christian (1831-1897) che aprì a Palermo la prima delle pasticcerie svizzere nel 1873.
Si legge ne La Trinacria Annuario di Sicilia (1905) che la premiata pasticceria svizzera Caflish C. sita in Via Vittorio Emanuele 180, esportava in tutto il continente con accurato servizio di pacchi postali (del peso di 1,800 kg, di 3 kg, di 5 kg) e di spedizioni per ferrovia.
In questo c'erano frutta candita, frutta pasta reale (imitazione), dessert specialità della casa, pastine per trattamenti, dolci riposto assortiti, dolci di Natale scelti, dolci di Natale e mustacciuoli.
Ma anche i biscotti di San Martino sia semplici che ripieni, torrone decorato, pietrafendola, cioccolata alla cannella, confetti, cassata, cannoli (in numero di 10, 20 oppure 40) e persino panettoni del peso di 2 chili!
Ancora nessun accenno alla torta Savoia.
Nel frattempo, scrive Ettore Sessa, altri Caflisch erano arrivati a Palermo e avevano aperto la pasticceria Caflisch di G.B. (iniziali del nome del proprietario).
Il locale, con sede in Via Maqueda 248-50-52, risulta già attivo già ai primi del Novecento e il personale parlava inglese, francese e Tedesco (il Cicerone siciliano, 1907).
Spedivano la loro merce in Francia, Svizzera, Austria, Inghilterra, Germania, Belgio, Malta, Tunisi, Danimarca, Olanda, Russia.
Troviamo finalmente in un inserto pubblicitario di questa pasticceria, in cui vengono elencati i dolci della casa, insieme a cannoli, frutta candita, zuccata, confetti, dolci di riposto, cioccolatta cannella garantita puro cacao e zucchero, cassatine di pistacchio: il dolce Savoja!
Una postilla in basso specifica: chiedere il vero dolce Savoja esclusiva specialità della Real Ditta C. Caflish di G.B, garantito per la durata di un mese, il migliore dell’esportazione.
Dunque veniva chiamato dolce Savoja e non torta Savoia, nome che avrebbe utilizzato invece la pasticceria svizzera Caveziel negli anni ’20, come si evince da una scatola utilizzata per le spedizioni di dolci.
Nel 1914 era stata inaugurata a Catania la prima pasticceria svizzera Caviezel & C. fondata da Alessandro Caviezel e Ulrico Greuter, e costituita da 70 dipendenti, tra cui 7 svizzeri e un tedesco.
Si trovava nella centralissima Via Etnea 200 – 2002.
Oltre ai dolci d’Oltralpe Specialità della casa erano la cassata alla siciliana e la frutta di pasta di mandorla (Annuario dell’industria e commercio, guida generale d’Italia 1947).
Allora ci chiediamo di nuovo: chi inventò la torta Savoia?
Dal momento che tra due litiganti c’è sempre un terzo che gode, scopriamo che già nel 1897 torta Savoia era un marchio registrato da un’altra pasticceria, la Digerini Marinai e Co. Di Firenze, il più famoso biscottificio della città che ha chiuso i battenti negli anni '60.
Il negozio per la vendita si trovava in via Vecchietti, mentre la fabbrica era in via Piagentina e qui le massaie si recavano per comprare a un prezzo ribassato e molto conveniente gli scarti di produzione: i biscotti rotti, o troppo cotti, o con una forma non perfetta.
La pasticceria era famosa per i suoi biscotti, i frollini e i wafers chiamati fruffrù, per i biscotti Bimbi d’Italia, risposta fiorentina ai più famosi Plasmon.
Si legge nella rivista quindicinale Rassegna Nazionale del 1898, che tra le specialità della premiata fabbrica di biscotti e dolci Digerini Marinai e Co., Firenze Via Borgo San Lorenzo 8 Firenze, vi sono Dessert, Wafer, Bijou, torta Olandese e la famosa torta Savoia!
Del resto Firenze fu capitale del Regno d’Italia, dal 3 febbraio 1865 al 3 febbraio 1871: dunque avrebbe anche un senso un dolce inteso come omaggio alla casa Regnante.
Com’era realizzata questa Torta Savoia della Digerini Marinai?
Lo scopriamo sfogliando sia il Bollettino delle controversie sulla qualificazione doganale del 1925 che la Rivista di politica economica del 1926: “Torta Savoia. Dolce costituito da strati di biscotto, alternato con sottili strati di cioccolato, presentato per l’esportazione dalla Ditta Digerini Marinai e C.".
La ricetta dunque non era poi così diversa dalla Torta Savoia che mangiamo ancora oggi.
I pasticceri svizzeri hanno sicuramente preso spunto dal dolce fiorentino ma sostituirono gli strati di biscotto con strati di pan di Spagna sottilissimo.
Si potrebbe ipotizzare che si siano ispirati alla torta Dubos, il dolce ungherese più famoso del mondo, uno dei preferiti della principessa Sissi.
Brevettato dal pasticciere József Dobos, questa torta è composta da cinque strati di pan di Spagna, su ognuno dei quali è spalmata una crema di cioccolato e burro, tranne sull’ultimo strato, ricoperto da caramello.
Ricordiamoci che esisteva a Budapest un caffè fondato dai Caflisch nel 1869 e che a Palermo i Caflish già nel 1911 vendeva cioccolatini importati dall’Ungheria con il marchio registrato Buda (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana).
Così come Rageth e Kokh spedirà in tutto il Regno torta Rako, Cassata Rako, Torta Rotschild, Cassata Rotschild e cioccolattini Bada, di cui aveva registrato il marchio (La Trinacria Annuario di Sicilia 1933).
Questa ipotesi non sembrerebbe azzardata perché i pasticceri Svizzeri erano avvezzi alle contaminazioni… i Grigioni importarono per esempio in Svizzera una torta francese, il dolce tradizionale engandinese, la famosa torta di noci: si consideri che in Engandina non crescono noci.
La ricetta venne appresa da un pasticcere svizzero che aveva lavorato nella regione francese del Dauphinè (Almanacco del Grigioni italiano 2004 Anna Maria Nunzi Pasticceri in Viaggio).
La torta Savoia dunque, come tanti altri dolci siciliani, è probabilmente frutto di varie contaminazioni, di culture lontane, di viaggi e viaggiatori, di piccoli grandi imprenditori e rispecchia forse più di ogni altro dolce al meglio l’aspetto eclettico della gastronomia isolana.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|










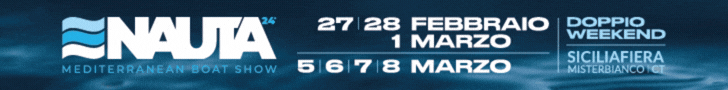




 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram