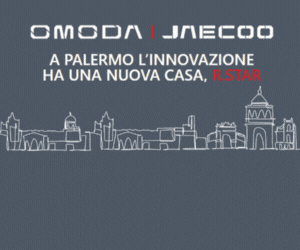TRADIZIONI
Paesino che vai, piatto che trovi: la festa di San Giuseppe e la "tavulata di virgineddi"
In Sicilia ogni momento è giusta per stare a tavola. L’altare, la tavola e la tradizione si uniscono insieme per diventare occasione di un viaggio tra sapori e saperi

Una delle tradizionali tavolate di San Giuseppe allestite a Valguarnera Caropepe
Pesce fritto, verdure in pastella, pane, sfinci e cannoli: queste golosità messe tutte insieme ci dicono forse qualche cosa?!
Sì: che in Sicilia ogni momento, ogni evento, ogni ricorrenza è buona per stare a tavola a fare festa per noi goduriosi siculi, la cui fame atavica sembra sempre non avere un domani.
Una fame che ha fama – il gioco di parole ci sta tutto – ormai dovunque: se dici Sicilia, dici cibo e bontà.
Una regione ricca di tradizioni legate alla cucina che si mescolano tra sacro e mito, santità e ricettari che rendono la tavola una delle manifestazioni della nostra cultura più attese e tramandate…e una vera attrazione.
Quelle parche e votive legate alla festa di San Giuseppe sono le prime che anticipano il "risveglio gastronomico pasquale" preludio dell’arrivo della primavera.
Una delle usanze popolari legate alla sacralità della nostra identità, è la tradizione dei Virgineddi, ovvero, "delle tavole di San Giuseppe" appunto.
Un'usanza oggi entrata a far parte del nostro folklore ma le cui origini raccontano storia rurale antica come il mondo che nelle comunità cristiane ha mescolato insieme i riti pagani, ma oltre al sentimento religioso ha anche un valore culturale e sociale estremamente importante.
Si tratta di una tavolata che le famiglie e la chiesa dei paesi organizzavano per i poveri, i bambini in particolare, per i quali ci si univa a cucinare un pranzo al quale venivano invitati gli indigenti per onorare il Santo, la cui generosità e amore per la famiglia veniva così celebrata.
Rappresentava, ad ogni modo, un evento per stare insieme, un momento di ringraziamento alla natura e ai numi protettori dopo le giornate di raccolta nei campi. In diverse località questa festa diventa un evento straordinario che vede unirsi paesani e visitatori in uno scambio a dir poco emozionante.
Sebbene con qualche variazione, la tradizione delle tavole dei vergineddi si è mantenuta pressoché intatta, con varianti di paese in paese.
La comunità partecipa unendo uomini e donne che si dedicano all’organizzazione di un pasto servito in lunghe tavolate, alcune abbellite anche con decorazioni, dove si servono pietanze povere, ma cariche di quel sentimento che rende tutto il menu ricchissimo.
E se il momento del pasto sembra il più coinvolgente, lo è in realtà la preparazione che restituisce una atmosfera gioiosa tra la gente che si mette ai fornelli già da qualche giorno prima, per preparare la quantità necessaria.
E se prima c'erano solo i poveri, oggi a queste tavole ci si siede tutti, condividendo innanzitutto il senso della comunità oltre che la devozione.
Il menu, come abbiamo anticipato, trattava cibi semplici, si cucinava quel che c’era, come tradizione della cucina contadina: piatti di pasta fatta in casa, secca e non fresca, condita con i legumi tipo ceci o lenticchie, il baccalà fritto - unica proteina disponibile a buon mercato e facile da conservare grazie alla salatura ortaggi di stagione tipo broccoli e carciofi, verdura raccolta nei campi che in alcuni posti vengono tuffati nella famosa pastedda e fritti in olio - una delle cose che in assoluto rappresenta la goduria della nostra gastronomia – oppure cotti e conditi semplicemente.
Seguono il finocchio e l’arancia che chiudevano il pasto in passato, ma che oggi si conclude con una passata di "sfinci" con o senza ricotta, la cui bontà non si può fare a meno di osannare tutto l’anno. In alcune parti troviamo pure il cannolo, come le squisite "raviole o cassatelle con la ricotta", le crespelle di riso con miele e i biscotti a base di mandorle.
Ma una delle cose che non può mancare è il pane votivo, detto il pane di San Giuseppe, preparato in svariate forme, tutte secondo la tradizione ricordando simboli sacri, facendo riferimento principalmente agli elementi della natura di fiori e alberi, oppure richiamando i simboli della Pentecoste come il pesce, i chiodi della crocifissione e la scala, e ancora gli attrezzi del falegname in onore del santo.
Altro elemento tra le caratteristiche che lo contraddistinguono dai pani quotidiani, sono la lucentezza ottenuta dalla spennellata d’uovo sulla superficie e la presenza dei semi di papavero distribuiti sopra il pane. Il pranzo si conclude infine con la cerimonia di benedizione dei pani che vengono poi donati ai commensali.
L’evento del pranzo è spesso caratterizzato anche da esposizioni di altari decorati con agrumi e ramoscelli d’alloro e persino i caratteristici pani, lavorati nelle case del posto, sono esposti come veri e propri capolavori d’artigianato da ammirare.
L’altare, la tavola e la tradizione si uniscono insieme per diventare occasione di un viaggio nella Sicilia dei sapori e dei saperi.
Sì: che in Sicilia ogni momento, ogni evento, ogni ricorrenza è buona per stare a tavola a fare festa per noi goduriosi siculi, la cui fame atavica sembra sempre non avere un domani.
Una fame che ha fama – il gioco di parole ci sta tutto – ormai dovunque: se dici Sicilia, dici cibo e bontà.
Una regione ricca di tradizioni legate alla cucina che si mescolano tra sacro e mito, santità e ricettari che rendono la tavola una delle manifestazioni della nostra cultura più attese e tramandate…e una vera attrazione.
Quelle parche e votive legate alla festa di San Giuseppe sono le prime che anticipano il "risveglio gastronomico pasquale" preludio dell’arrivo della primavera.
Una delle usanze popolari legate alla sacralità della nostra identità, è la tradizione dei Virgineddi, ovvero, "delle tavole di San Giuseppe" appunto.
Un'usanza oggi entrata a far parte del nostro folklore ma le cui origini raccontano storia rurale antica come il mondo che nelle comunità cristiane ha mescolato insieme i riti pagani, ma oltre al sentimento religioso ha anche un valore culturale e sociale estremamente importante.
Si tratta di una tavolata che le famiglie e la chiesa dei paesi organizzavano per i poveri, i bambini in particolare, per i quali ci si univa a cucinare un pranzo al quale venivano invitati gli indigenti per onorare il Santo, la cui generosità e amore per la famiglia veniva così celebrata.
Rappresentava, ad ogni modo, un evento per stare insieme, un momento di ringraziamento alla natura e ai numi protettori dopo le giornate di raccolta nei campi. In diverse località questa festa diventa un evento straordinario che vede unirsi paesani e visitatori in uno scambio a dir poco emozionante.
Sebbene con qualche variazione, la tradizione delle tavole dei vergineddi si è mantenuta pressoché intatta, con varianti di paese in paese.
La comunità partecipa unendo uomini e donne che si dedicano all’organizzazione di un pasto servito in lunghe tavolate, alcune abbellite anche con decorazioni, dove si servono pietanze povere, ma cariche di quel sentimento che rende tutto il menu ricchissimo.
E se il momento del pasto sembra il più coinvolgente, lo è in realtà la preparazione che restituisce una atmosfera gioiosa tra la gente che si mette ai fornelli già da qualche giorno prima, per preparare la quantità necessaria.
E se prima c'erano solo i poveri, oggi a queste tavole ci si siede tutti, condividendo innanzitutto il senso della comunità oltre che la devozione.
Il menu, come abbiamo anticipato, trattava cibi semplici, si cucinava quel che c’era, come tradizione della cucina contadina: piatti di pasta fatta in casa, secca e non fresca, condita con i legumi tipo ceci o lenticchie, il baccalà fritto - unica proteina disponibile a buon mercato e facile da conservare grazie alla salatura ortaggi di stagione tipo broccoli e carciofi, verdura raccolta nei campi che in alcuni posti vengono tuffati nella famosa pastedda e fritti in olio - una delle cose che in assoluto rappresenta la goduria della nostra gastronomia – oppure cotti e conditi semplicemente.
Seguono il finocchio e l’arancia che chiudevano il pasto in passato, ma che oggi si conclude con una passata di "sfinci" con o senza ricotta, la cui bontà non si può fare a meno di osannare tutto l’anno. In alcune parti troviamo pure il cannolo, come le squisite "raviole o cassatelle con la ricotta", le crespelle di riso con miele e i biscotti a base di mandorle.
Ma una delle cose che non può mancare è il pane votivo, detto il pane di San Giuseppe, preparato in svariate forme, tutte secondo la tradizione ricordando simboli sacri, facendo riferimento principalmente agli elementi della natura di fiori e alberi, oppure richiamando i simboli della Pentecoste come il pesce, i chiodi della crocifissione e la scala, e ancora gli attrezzi del falegname in onore del santo.
Altro elemento tra le caratteristiche che lo contraddistinguono dai pani quotidiani, sono la lucentezza ottenuta dalla spennellata d’uovo sulla superficie e la presenza dei semi di papavero distribuiti sopra il pane. Il pranzo si conclude infine con la cerimonia di benedizione dei pani che vengono poi donati ai commensali.
L’evento del pranzo è spesso caratterizzato anche da esposizioni di altari decorati con agrumi e ramoscelli d’alloro e persino i caratteristici pani, lavorati nelle case del posto, sono esposti come veri e propri capolavori d’artigianato da ammirare.
L’altare, la tavola e la tradizione si uniscono insieme per diventare occasione di un viaggio nella Sicilia dei sapori e dei saperi.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ITINERARI E LUOGHI
Comprata (a 3 euro) in Sicilia, diventa una residenza d’arte: dov'è "Casuzzabut"
di Redazione















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram