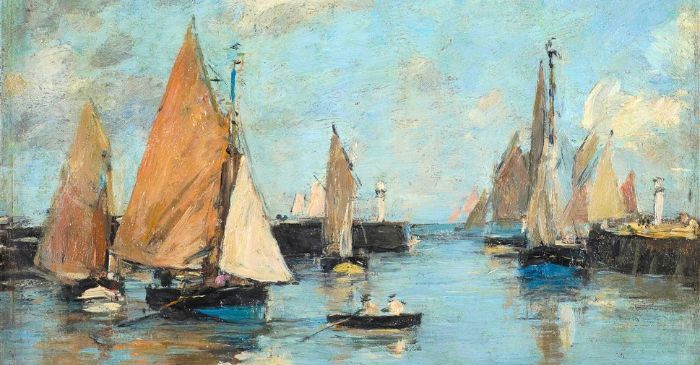STORIA E TRADIZIONI
Ti ci ritrovi spesso bloccato nel traffico di Palermo: la vera storia di via Colonna Rotta
Perché questa via si chiama così? Ve lo siete chiesto forse mentre vi trovavate in coda tra un colpo di clacson e un'imprecazione. Ecco come si ruppe la colonna

Via Colonna Rotta a Palermo
A complicare il tutto, uno dei misteri che avvolge l’ancien palermitanitudine, ovvero la questione di via Colonna Rotta e l’origine del suo nome. L’aneddoto della colonna è famoso, certo, il contorno un po’ meno.
Per dargli luce facciamo un breve salto nel passato. «Ammainate le vele!» «Che disse?» «Munnate le pere…» «Le pere?» «E io che saccio…» Nella primavera del 1610 arrivava via mare a Palermo il nuovo viceré Pedro Téllez Girar, duca d’Osuna.
Per inteso, l’argomentazione "viceré" era un po’ trubola, non troppo diversa da quella dell’allenatore del Palermo, che ne esoneri uno perché pareggia e te ne arriva un altro che i gol li fa nella sua porta.
Pedro era un trentunenne di bell’aspetto e di buona famiglia, motivo per cui, il duca di Terranova cu cerca trova e il Conte di Buscemi caminami appresso ca ti sistemi (in quel momento pretore) pensarono di poterne fare un boccone.
Eh, ma mai giudicare un libro dalla copertina. Il duca D’Osuna vantava un curriculum di tutto rispetto: scorrerie varie, battaglie navali, una vita di scannate con il padre e vari arresti per duelli, risse e frodi. Malo conto si erano fatti i loro signori.
Infatti, quattro giorni dopo aver preso possesso della carica, fece arrestare tutti i vagabondi e malacarne di Palermo, sfrattò dalla città 40 persone e mise il divieto di portare armi (pena: cinque anni a remare nelle galee). D'altronde doveva fare da sé. Essendo la Sicilia colonia spagnola, infatti, nemmeno poteva contare sul re Filippo III perché era cintura nera di inzerbinamento.
Aveva passato una vita a farsi comandare a bacchetta da sua moglie Margherita d’Austria, poi era rimasto vedovo, aveva nominato il duca di Lerma suo favorito, ed aveva continuato a farsi comandare a bacchetta da lui.
E così, nel mentre che in Europa si gettavano le basi per la Guerra dei Trent’anni, che Galileo Galilei scopriva il pianeta Nettuno, e la gente smetteva di parlare liberamente perché veniva pubblicata la prima edizione dell’accademia della Crusca, a Palermo, povertà e carestia, che la gente si mangiava i calli delle mani col sale e limone.
Contemporaneamente, nel sottosuolo della chierica società, stava scoppiando una faida fra due degli ordini più potenti dell’epoca.
All’angolo sinistro, con 90 libri di peso e migliaia di conversioni vinte per KO tecnico, i Gesuiti. All’angolo destro, con 87 indulgenze di peso, detentori della cintura pesi massimi del Concilio di Trento, i Teatini. Dagli spalti, i tifosi intonavano: “Tu la sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità”.
Il motivo dello scontro non era dottrinale né santifico per un Kaiser. Il problema era sempre lo stesso, dai tempi che il primo uomo di Neanderthal occupò abusivamente la prima caverna: le benedettissime proprietà.
La verità è che i gesuiti erano arrivati per primi, circa nella metà del 500, voluti dal viceré Juan De la Vega, con il compito di riavvicinare i siciliani al credo.
Più che al credo, veramente, dovevano essere avvicinati alla corona, datosi che la gente s’era rotta il kaiz di non mangiare, ed era una cinquantina d’anni che faceva rivolte.
Per fortuna a placare gli animi arrivò una bella peste, che vide scendere in campo nientepopodimenoche il famoso Gianfilippo Ingrassia (quello dell’ospedale), che propose il primo lockdown della storia facendo leva sul distanziamento sociale.
È proprio in questi anni che i gesuiti, dopo essersi impadroniti di mezza città, affermavano il loro potere completando la costruzione di Casa Professa. Così era: la peste provocava agli ordini monastici la febbre del mattone.
Se ne andò l’epidemia e arrivarono i Teatini al motto di “'Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost'”. Inizialmente trovarono sistemazione nella chieda di Santa Maria della Catena, dove nel 1602 fecero la loro casa.
Per carità, bello il posto: vista mare e a due passi dalla stazione del tram. Tuttavia era troppo piccolo. I teatini cominciarono quindi a comprare e comprare (perché ai parrini piccioli non gliene sono mancati mai), fino a che non riuscirono a mettere le mani sulla chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, con la promessa di costruire una cappella nella nuova chiesa che sarebbe sorta accanto.
La prima pietra verrà posta nel 1612, e a presenziare alla cerimonia ci saranno il viceré Pedro Téllez Girar, duca d’Osuna e l’arcivescovo Giannettino Doria (lo stesso che nel 1625 porterà in processione le esequie di Santa Rosalia, per liberare la città da un’atra peste). 34 mastodontiche colonne prevedeva il progetto.
Dove prenderle 34 colonne, alcune delle quali avrebbero dovuto raggiungere gli 11 metri? Semplice, alla cava del monte Billiemi, a pochi passi dalla città, cui marmo era conosciuto per i suoi pregi.
Ogni volta che una delle dette colonne attraversavano la città, discendendo per il Cassaro, era tutto stupore: i colpi di “minkia!” del popolo arrivavano a mare. I gesuiti invece rodevano, poiché in fondo era tutta una gara a chi ce l’avesse più grossa… la colonna.
Ebbene, sarà stato un colpo di sfortuna, saranno state proprio le maledizioni dei gesuiti, fatto sta che un giorno una di queste cadde e muriù u cane. No, per fortuna non c’era nessun animale sotto.
"Muriu u cane" è un modo di dire tutto nostro, nel senso che si ruppe definitivamente. Così fu, a colonna si rumpiù e la storia finiu. Passarono i giorni, i mesi, le stagioni, gli batté il sole, gli piovve addosso.
Se ne andarono gli anni, i re, ne arrivarono altri. Quello che non cambiò mai fu il nome di quella via, che, da quel fatidico giorno, ancora oggi, è chiamata: via Colonna Rotta. Nel congedarmi chiedo venia ai lettori per la prolissità.
Sarei potuto arrivare direttamente al punto, ma in questo modo un pezzo di marmo sarebbe rimasto solo uno stupido pezzo di marmo.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|










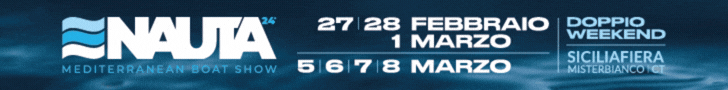




 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram