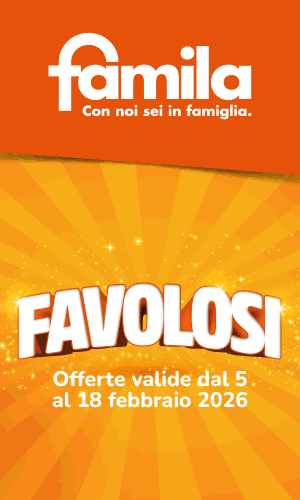RICETTE
Solo leggerle ti fa venire fame: a tavola con Montalbano, le ricette (segrete) di Camilleri
La sua penna riesce a suscitare anche nel lettore più sobrio un certo languorino. L’elenco delle ricette che spuntano qui e là, tra le pagine dei romanzi, è lungo

Una scena da "Il Commissario Montalbano"
Andrea Camilleri nato a Porto Empedocle (Ag) il 6 settembre 1925, è stato scrittore, sceneggiatore, regista e autore di importanti romanzi storici di ambientazione siciliana.
Il grande successo è arrivato però solo alla soglia dei settant’anni, alla fine degli anni ‘90, con la saga di Salvo Montalbano, il commissario più celebre d’Italia: intuitivo, sanguigno, simpatico, generoso, paladino della giustizia ma allergico alle regole e da sempre affetto da "pititto lupigno".
Il commissario è un eroe buono, abita in una villetta "a ripa di mare", dove si dedica a fare lunghe nuotate e scorpacciate di cibo casereccio. I piatti della tradizione siciliana non mancano mai nei romanzi di Montalbano, che d’altra parte sembra riuscire a trovare il bandolo della matassa e a risolvere i suoi casi solo dopo aver mangiato bene.
La passione per la cucina del commissario ha anche un significato molto forte: Salvo è spesso da solo, lontano dagli affetti, da Livia, la sua eterna fidanzata genovese.
Il buon cibo ha dunque anche una forte valenza consolatoria, le pietanze elaborate risollevano il morale di Montalbano, soprattutto se è nirbusu (di malumore) o se non riesce a venire a capo di qualche indagine.
Trova conforto nelle specialità della trattoria San Calogero o ancora meglio nelle sorprese culinarie che la governante Adelina (cuoca sopraffina) lascia riposte, in attesa del suo arrivo, nel forno e nel frigorifero: "Appena aperto il frigorifero, la vide. La caponatina! Sciavuròsa, colorita, abbondante, riempiva un piatto funnùto, una porzione per almeno quattro pirsone. Erano mesi che la cammarera Adelina non gliela faceva trovare.
Il pane, nel sacco di plastica, era fresco, accattato nella matinata. Naturali, spontanee, gli acchianarono in bocca le note della marcia trionfale dell’Aida. Canticchiandole, raprì la porta-finestra doppo avere addrumato la luce della verandina. Sì, la notte era frisca, ma avrebbe consentito la mangiata all’aperto. Conzò il tavolinetto, portò fora il piatto, il vino, il pane e s'assittò". (Da La gita a Tindari).
Il cibo va consumato in rigoroso silenzio secondo il commissario: “la debbo preavvertire di una cosa anche a costo di apparire vastaso…io quando parlo non mangio. Di conseguenza, se mangio non parlo”. (da Il ladro di Merendine);
Spesso preferisce cenare in solitudine e concentrazione, per poter gustare fino in fondo le pietanze che ama, e poter immergersi nelle proprie emozioni sino quasi a perdersi nei sapori: “masticò lentamente, socchiuse gli occhi, emise una specie di gemito”.
La penna di Camilleri riesce a suscitare anche nel lettore più sobrio un certo languorino. L’elenco delle ricette che spuntano qui e là, tra le pagine dei romanzi, è lungo: il pesce “mangiato freschissimo”; gli arancini con la carne aggrassata che “Adelina ci metteva due jornate sane sane a pripararli.”; la pasta alla Norma “con le milinzane fritte e la ricotta salata”;
E ancora “La pasta ' ncasciata, “un piatto che uno gemeva di godimento a ogni forchettata , ma che Adelina gli faceva trovare raramente dato che ci voleva il tempo so ' a pripararlo”; il sugo di seppie “stretto e nero, come piaceva a lui”; il coniglio alla cacciatora che “quanno Adelina glielo faciva a Montalbano spuntavano le lagrime per la cuntentizza”; i sauri imperiali con la cipollata; le triglie di scoglio fritte; i purpi alla carrettiera e quelli alla napoletana con olive nere di Gaeta e capperi di Pantelleria; le alici all’agretto “che la signora Elisa , la moglie del questore , aveva saputo cucinare con arte e perizia”;
la pappanozza di patate e cipolle…Noi mancano poi i golosi dessert: petrafennola (“il dolce che più duro era più gustoso diventava”), cubaita, biscotti regina, cannolo e granita di limone (“un bicchiere di succo di limone, due di zucchero, quattro di acqua. Da leccarsi le dita!”; da Il cane di terracotta).
In una intervista del 2007 Camilleri affermava: “Le cose che non posso fare io, che non posso mangiare io, le faccio mangiare a Montalbano.” Sulla tavola di Montalbano Camilleri, che sapeva cucinare bene, ama rispolverare le ricette della sua infanzia, quelle della nonna Elvira, “una cuoca formidabile sia chiaro”, “la generalessa della cucina nella casa di campagna di Porto Empedocle”.
Anche la ricetta dei famosi arancini di Montalbano, neanche a dirlo, è quella della nonna. Raccontava Camilleri: “Mia nonna diceva che prepararli era lungariusu, ci voleva tanto tempo. Perché bisognava preparare la carne, tanto di maiale e tanto di vitello, spezzettandola col tagghiaturi, la mezzaluna. Ci voleva tempo.
Si aggiungevano i piselli, un po' di caciocavallo ragusano e qualche pezzettino di salame, si impastava tutto in un pugno di riso e si passava l'arancino nell'uovo, nella farina e nel pangrattato, per l'impanatura. Ma non si friggevano subito. No, bisognava aspettare una notte, lasciarli riposare in pace.
E il giorno dopo, a tavola, si vedeva com'erano venuti. Perché il problema dell'arancino era il dosaggio, che non era mai lo stesso, e dunque ogni volta mia nonna passava un esame. "Comu vinniru stavota?" domandava. "Un tanticchia asciutti. L'autra vota erano megliu" rispondeva mio nonno.
Un giorno li fece in un modo davvero sublime, e io stavo per dirglielo. Mio zio Massimo mi diede un cavuciu (calcio) sotto la tavola. "Boniceddu" mi sussurrò. Ma perché?, gli domandai.
"Perché lei deve sempre superare se stessa: se tu le dai soddisfazione, è finita". Un’altra specialità della nonna era un piatto di sua invenzione, dal nome particolare: la munnizza (spazzatura). Camilleri spiegava così la ricetta: “Ci vogliono otto o dieci verdure diverse, alcune crude e altre cotte. Poi si prendono delle gallette e si copre il fondo della teglia affinché assorbano l'eccesso di olio e di aceto. Si comincia con uno strato di verdure cotte, e lo si copre con un altro strato di verdure crude. Poi ancora cotte, e di nuovo crude.
Tanti strati, insomma, finché non diventa una sorta di panettone coloratissimo. Che va condito con olio, aceto e sale e ricoperto con acciughe, fette di arance amare, capperi, olive verdi, patate, rape e uova sode a fette. Però bisogna mangiarlo il giorno dopo, quando tutta questa roba si è amalgamata a dovere.
Ogni volta che la rifaccio, assaporo il piacere di tornare indietro nel tempo”. Il sapore dei cibi dell’infanzia suscitava in Camilleri molte emozioni e ricordi… “Anche se” - concludeva lo scrittore - ”La verità è che i sapori del passato sono irripetibili".
Scrive Gaetano Savatteri: “Camilleri non scopre la cucina e la pasticceria, che esistevano da molto tempo prima che il commissario Montalbano entrasse nella trattoria San Calogero. Camilleri fa molto di più inventa la cucina come genere letterario, come elemento essenziale del racconto sulla Sicilia”. Il cibo nei romanzi di Montalbano diventa dunque simbolo di cultura e di identità, ma anche di consolazione e di memoria familiare.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|















 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram